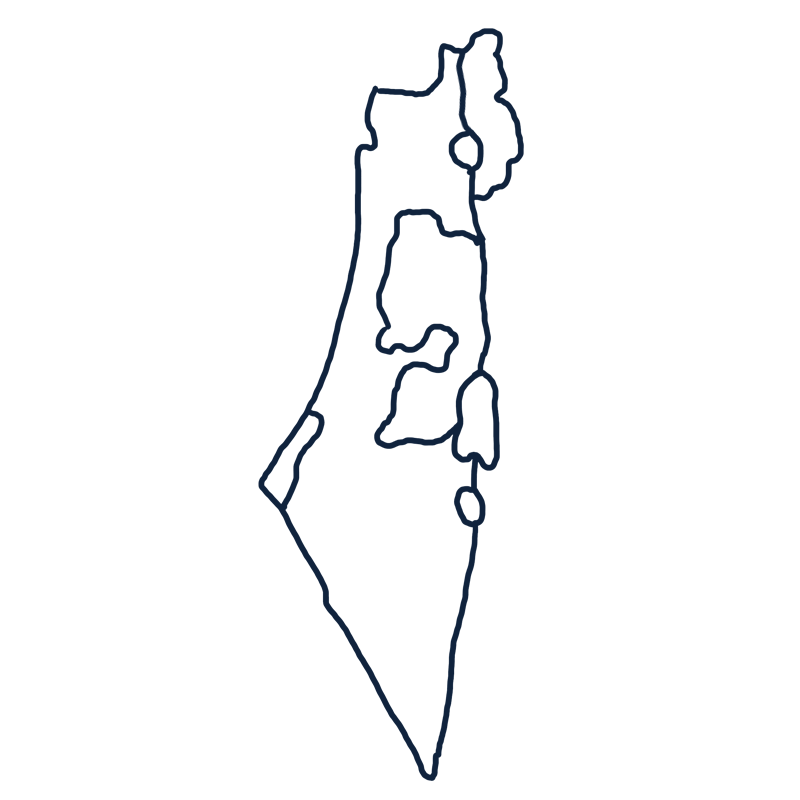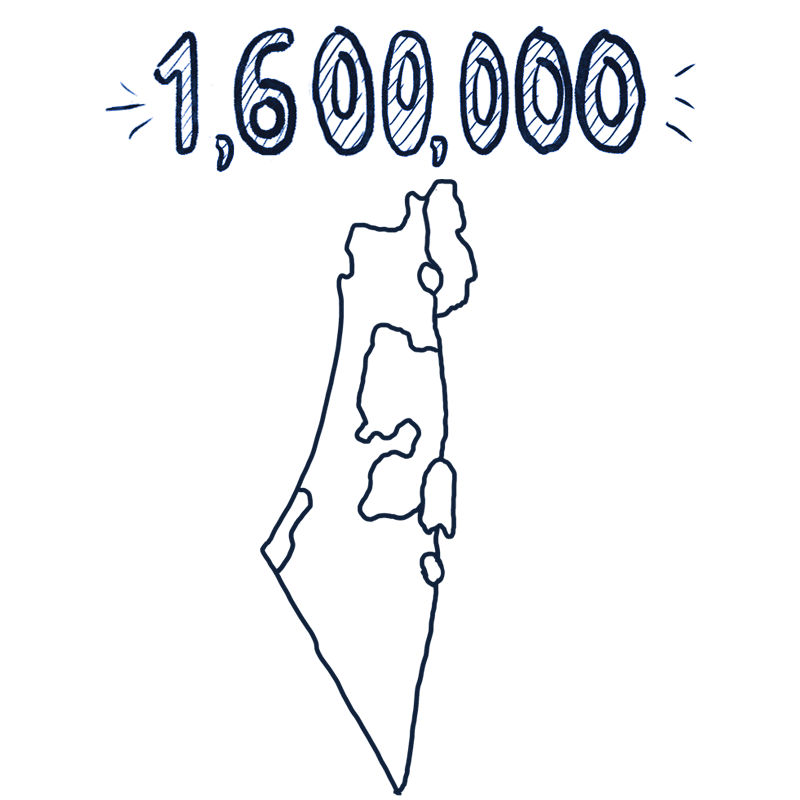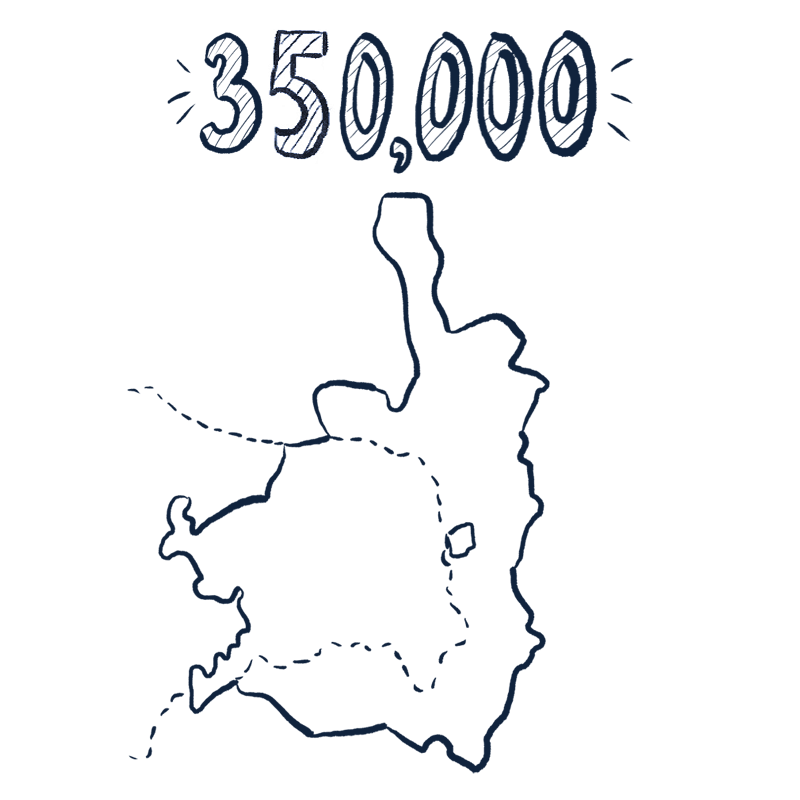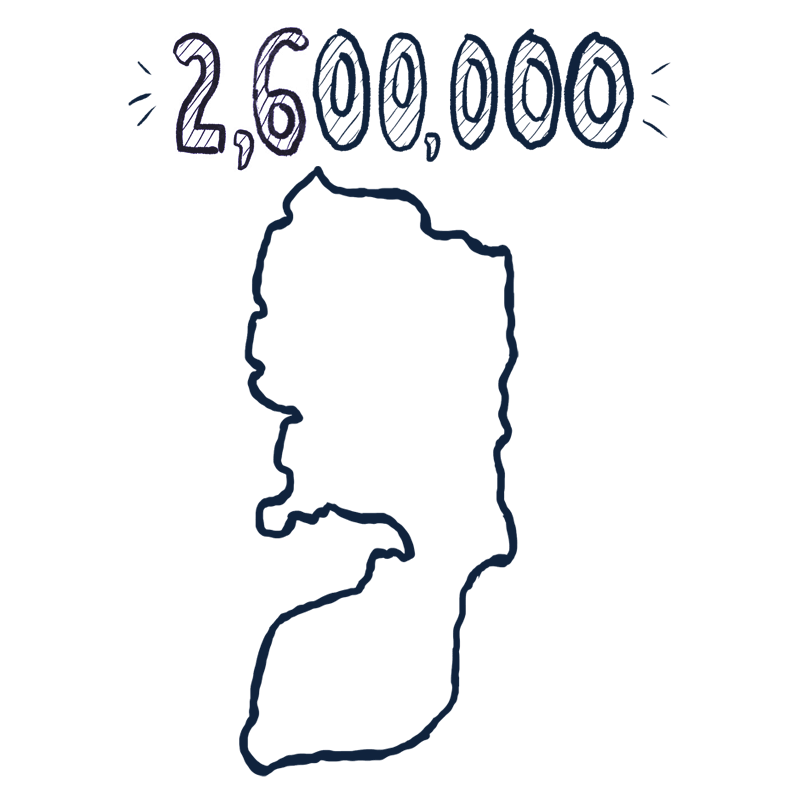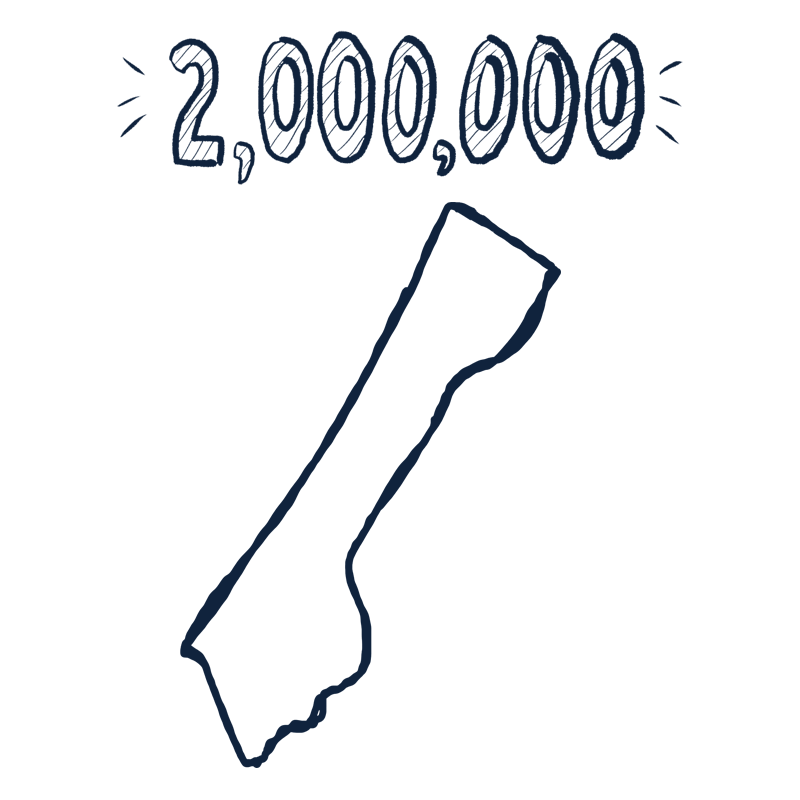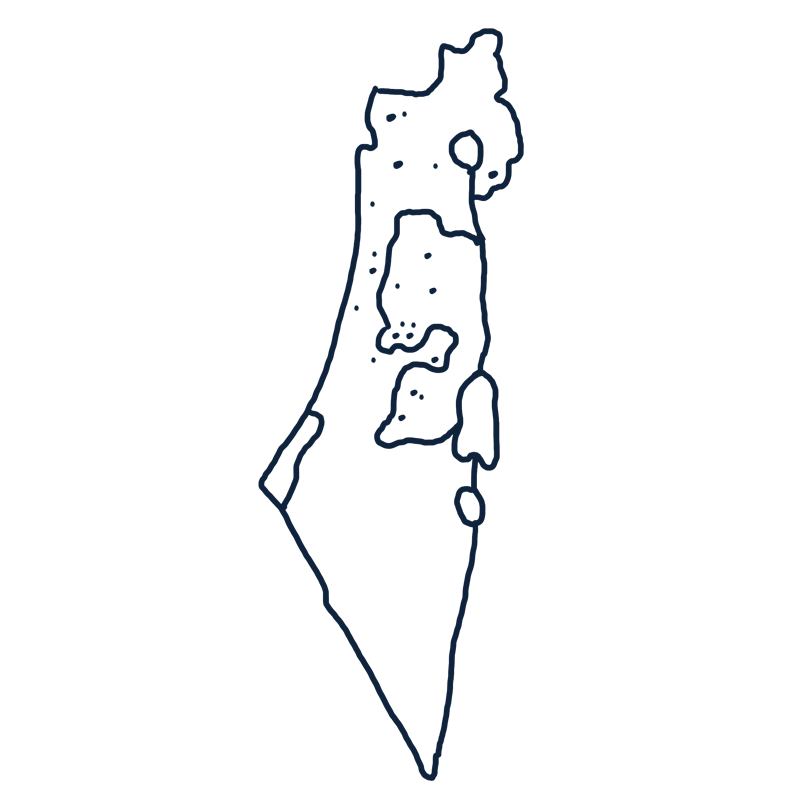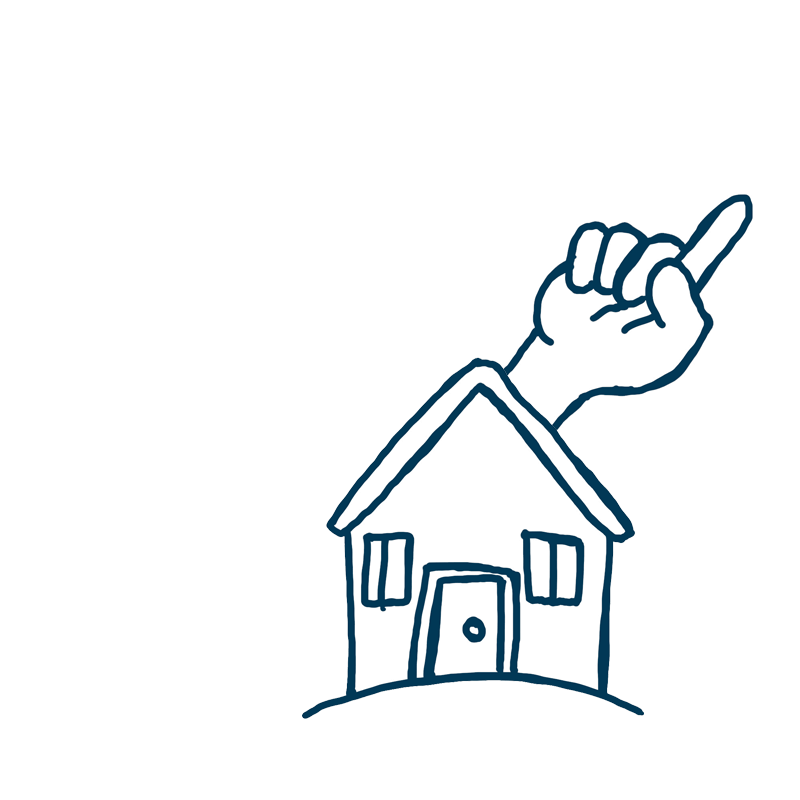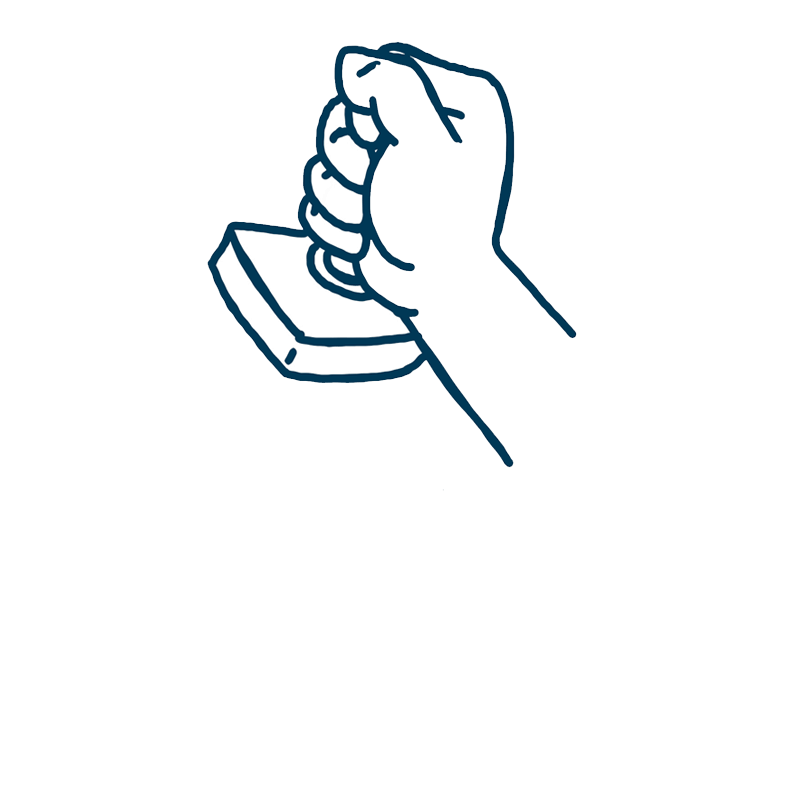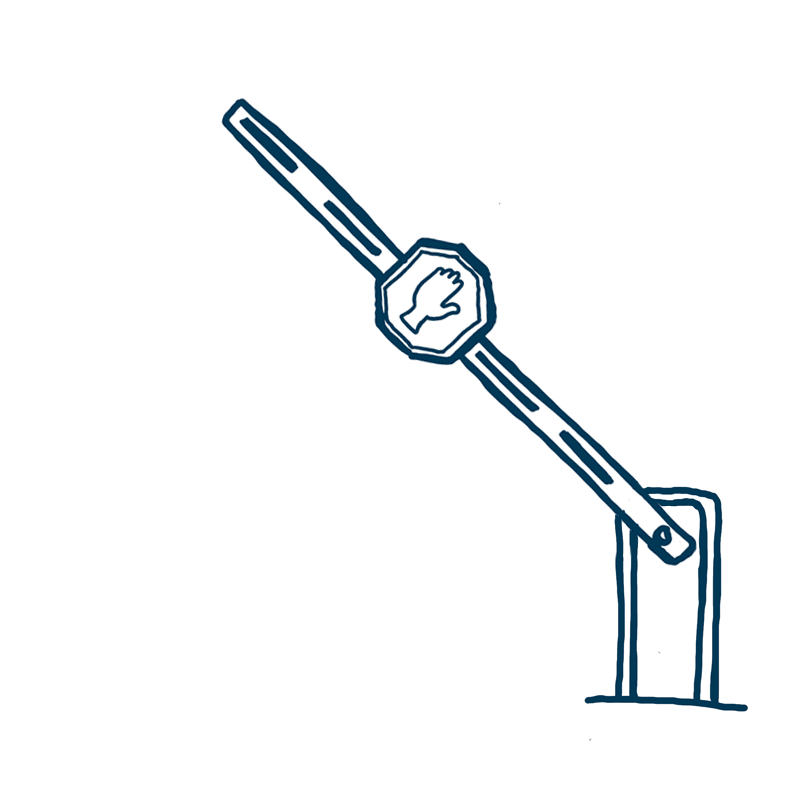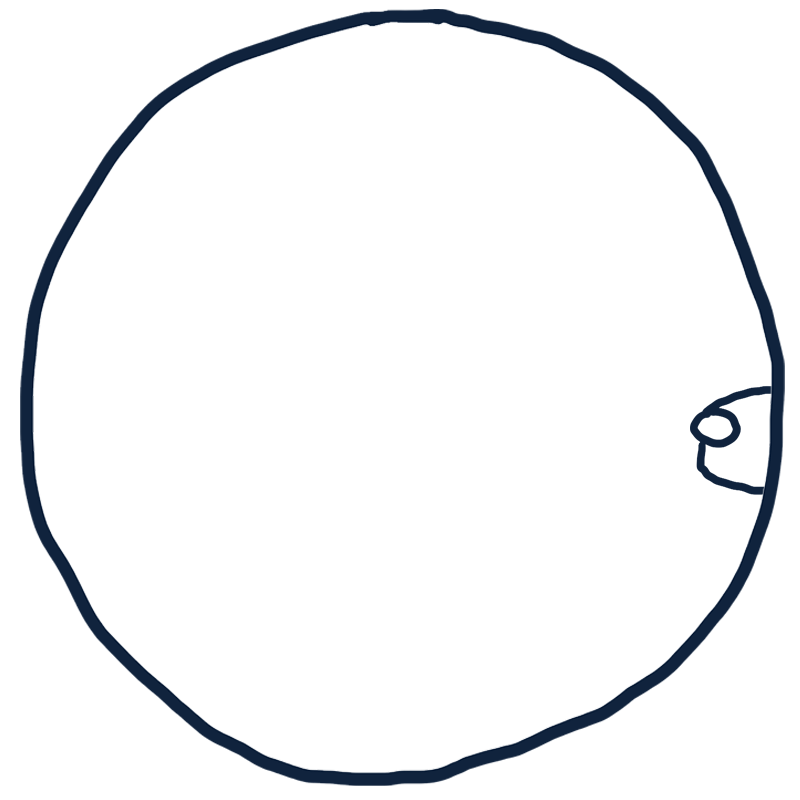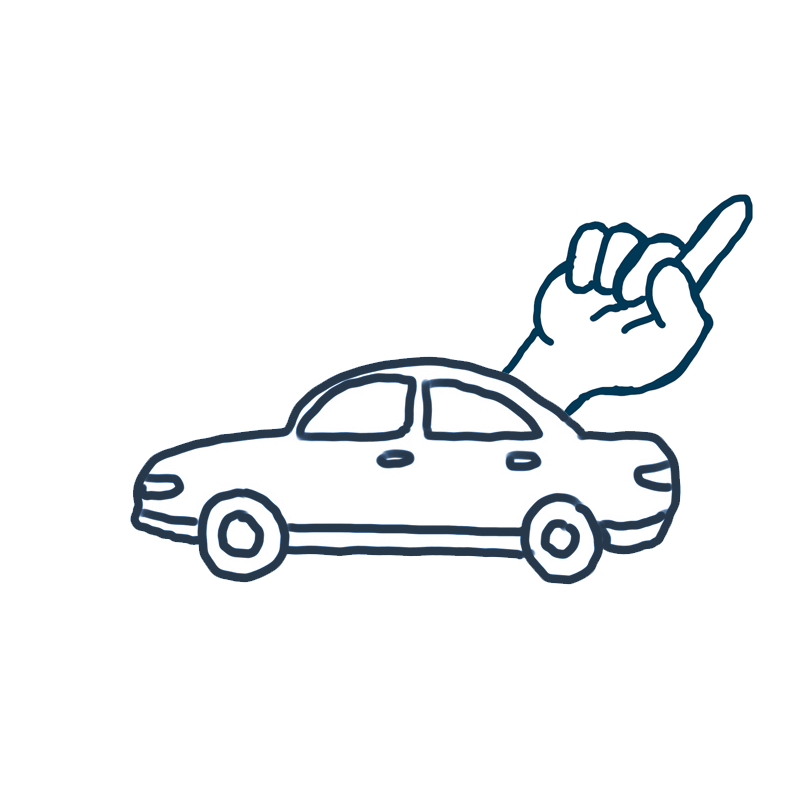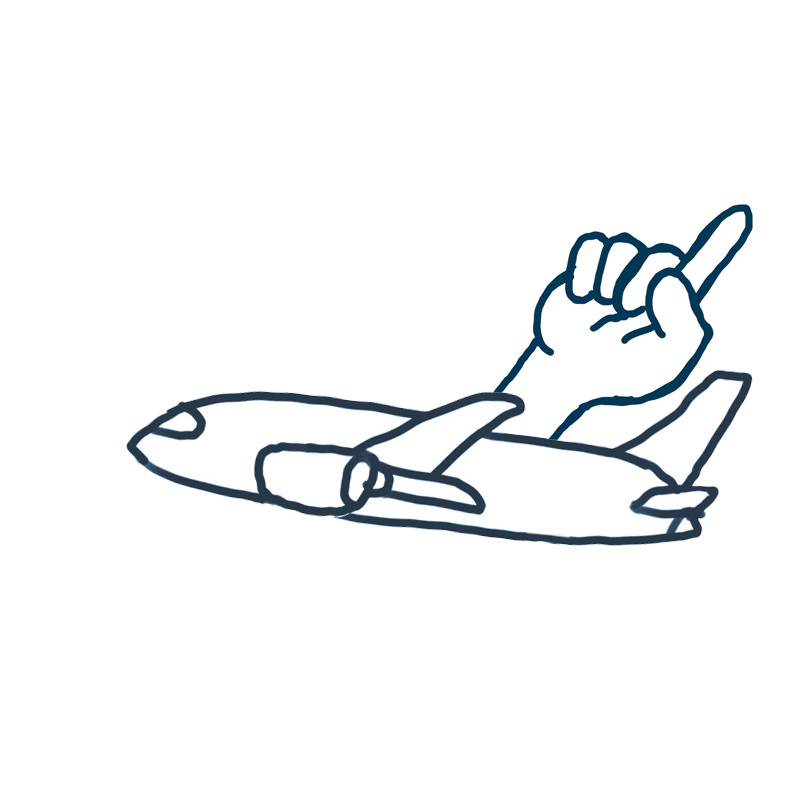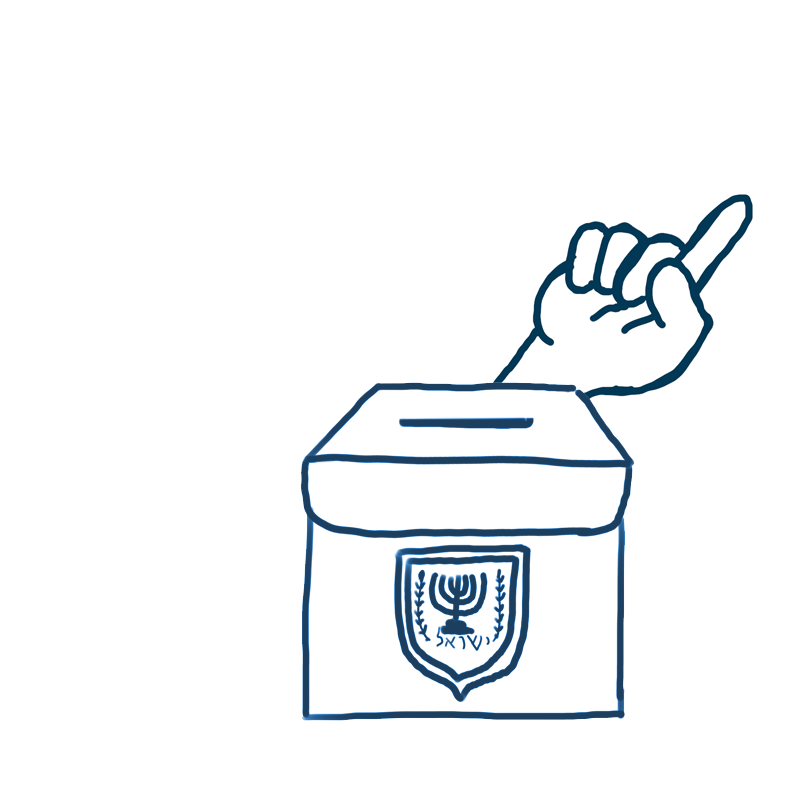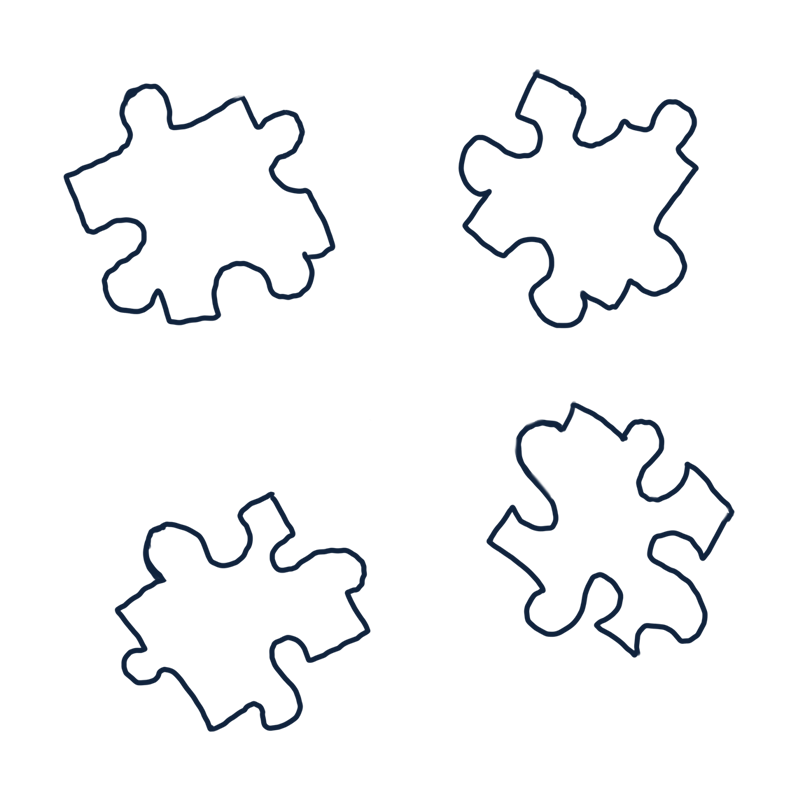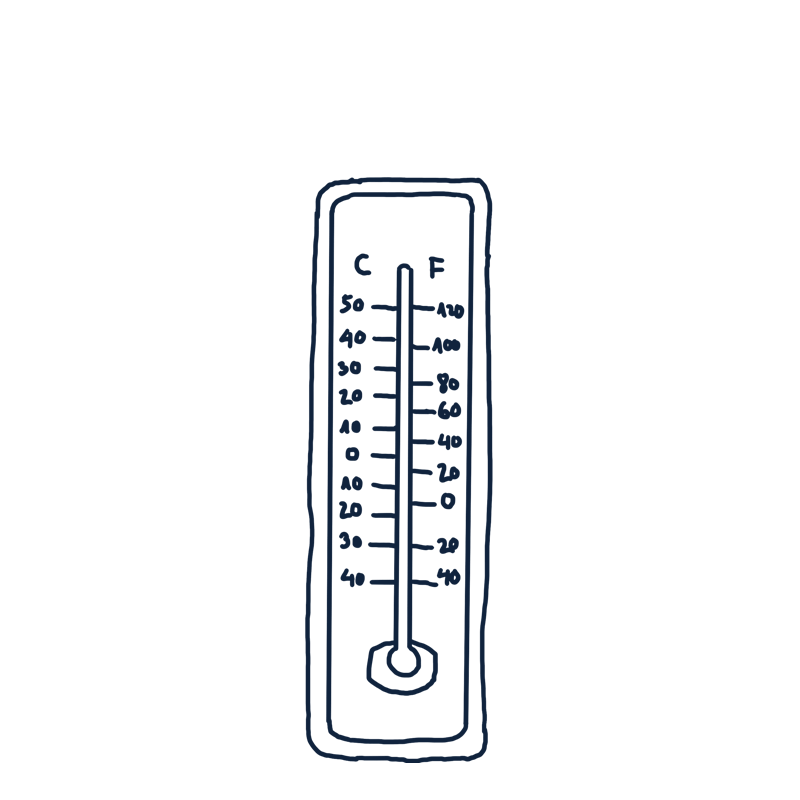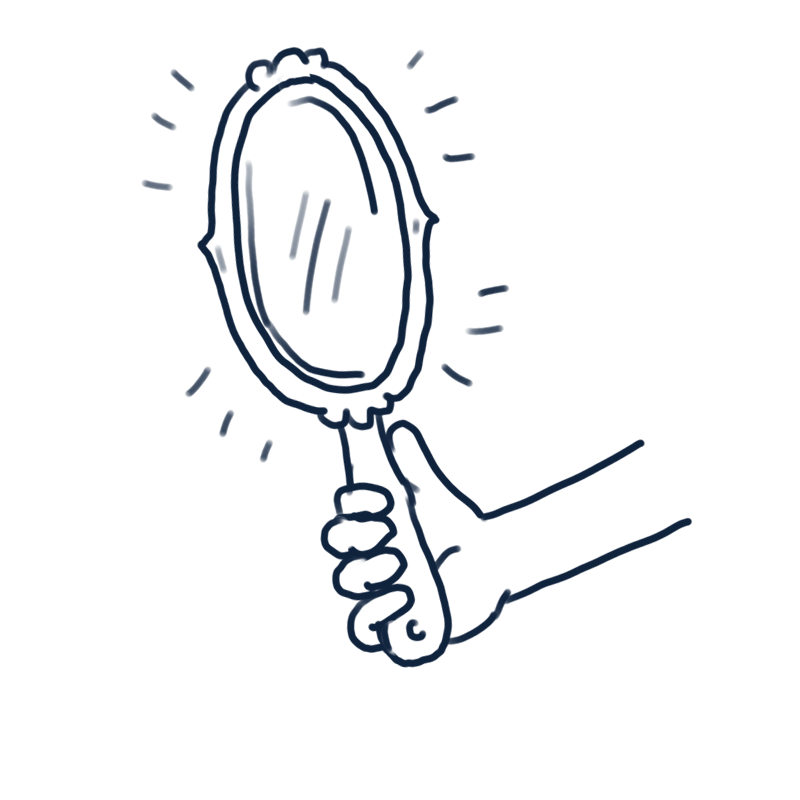Con la grazia, la fede e una macchina fotografica
Noor Abdo
24 gennaio 2021- Wearenotnumbers
Nato durante la prima Intifada, Momen aveva solo una settimana di vita quando l’occupazione israeliana gli uccise il padre lasciandolo orfano nella Palestina occupata. Da quando è nato niente gli è stato facile. Lottando contro il dolore emotivo e fisico per tutta la vita, Momen ha tracciato un sentiero tutto suo.
Fotografo in divenire
Momen Faiz ha scoperto la sua passione per la fotografia da ragazzo quando viveva ad Al Shejayeh, un’area di confine nella zona est di Gaza. È un posto strategico per fotografare le rivolte e l’oppressione che avvenivano nell’area. Ha fatto i primi tentativi con una macchina fotografica che gli avevano prestato perché non ne aveva una sua. Questo gli ha offerto l’opportunità di stringere rapporti con un gruppo di fotografi e giornalisti. Ha ascoltato i loro consigli su dove mettersi per scattare le foto ed è così diventato un esperto a trovare l’angolazione giusta da cui catturare le immagini.
Momen ha cercato di comprarsi l’equipaggiamento, ma era troppo caro. Ha cominciato a lavorare come fotografo freelance per agenzie internazionali, la prima è stata Domtex.
Momen si è sempre trovato vicino alle zone dove di solito avvenivano gli attacchi perché casa sua è nei pressi del confine.
Da teenager, Momen aveva grandi sogni e visioni: diventare famoso e andarsene da Gaza, la più grande prigione a cielo aperto mai esistita, e riuscire a mostrare il suo talento al mondo. Tutto quello che sapeva del mondo esterno gli veniva dalla TV e dalla radio. Voleva girare il mondo. Ma il blocco aveva altri piani.
“Adesso non posso andare”
Una fredda mattina di settembre, Momen stava digiunando in occasione del Giorno di Arafah, il giorno prima di Eid- Al-Adha [importanti festività religiose islamiche, ndtr.], mentre andava in missione per riprendere la lotta dei commercianti palestinesi. A loro non restava altra scelta che scavare dei tunnel per poter svolgere una normale attività commerciale a causa delle restrizioni imposte dall’occupazione israeliana nelle zone di confine. Per Momen fare delle foto era solo un’altra sfida e stava gironzolando per trovare l’angolatura perfetta da cui scattare le immagini.
In un attimo Momen venne gettato a terra da un missile proveniente da un aereo da ricognizione israeliano che l’ha preso di mira direttamente e intenzionalmente. Il ventunenne perse conoscenza e sentì che l’anima stava abbandonando il suo corpo. Ma, mentre la vita gli stava passando davanti agli occhi, sentì una voce che lo implorava di andare avanti e di mettersi di nuovo in piedi. In quel momento, tutto quello che Momen disse a se stesso fu: “Non posso andarmene ora …. Non ho ancora fatto niente per la Palestina.”
L’inizio di una nuova vita
L’incidente capitato a Momen avvenne nel novembre 2008, durante un altro attacco israeliano contro Gaza durante l’operazione “Caldo Inverno” [dal 29 febbraio al 3 marzo 2008], durante la quale vennero usate contro civili inermi armi bandite a livello internazionale come le bombe al fosforo, e si lasciò dietro distruzioni massicce e un alto numero di morti.
Fuori dalla sua finestra tutto stava crollando, ma Momen era sotto anestesia e non sentiva nulla. Non sapeva dove si trovasse o cosa gli fosse successo. Quando riprese conoscenza, gli dissero che era nell’ospedale Al-Shifa. Tutto cominciò a essere più chiaro, ma continuava a non sentire nulla. Allungando la mano per toccare le ferite sulle sue gambe, Momen non le trovò, non c’erano più!
I chirurghi avevano dovuto amputare entrambe le gambe sopra il ginocchio dato che la loro condizione continuava a peggiorare a causa della scarsità di attrezzature mediche dell’ospedale. La cancrena si era sviluppata e si era estesa a entrambe le gambe. Momen sarà confinato su una sedia a rotelle per il resto della sua vita. Per lui la possibilità di ottenere delle protesi è ridottissima a causa della continuazione del blocco e del peggioramento della situazione economica della Striscia. Ha passato 25 giorni nell’ospedale Al-Shifa prima di essere trasferito in Arabia Saudita per la riabilitazione.
La macchina fotografica, la mia migliore amica
Appena fuori dall’unità di terapia intensiva, la prima cosa che Momen ha cercato è stata la sua migliore amica, la macchina fotografica. Era l’ultimo raggio di speranza che aveva. La strinse al cuore sussurrandole: “e adesso non abbandonarmi.”
Momen parla della sua macchina fotografica: “Mi ha confessato che si sentiva frustrata perché scattava immagini di crimini di guerra contro civili disarmati, donne e bambini, sapendo di non poter cambiare la realtà di quello che stava succedendo …Poteva solo scattare immagini e aiutarmi silenziosamente a condividerle con il mondo e così non essere altro che una testimone.”
Un raggio di speranza
Dopo otto mesi di cure in Arabia Saudita, il destino aveva un piano per cambiare la vita di Momen, che aveva attirato una grande attenzione mediatica perché il suo percorso era eroico: sopravvissuto a un attacco brutale, entrambe le gambe amputate e ora determinato a ricostruirsi una vita, sempre sorridendo!
In mezzo a tutto quello che gli stava succedendo notò un reporter che spiccava fra gli altri. Una rifugiata palestinese che aveva passato tutta la sua vita in Arabia Saudita ed era molto interessata a raccontare la storia di Momen. La passione di Dima, la sua fiducia in sé e il suo coraggio hanno fatto innamorare follemente Momen. E lei non ha avuto alcun dubbio quando Momen le ha chiesto di sposarla, pur sapendo molto bene che sarebbe stato difficile lasciare la famiglia e iniziare una nuova vita a Gaza.
E adesso?
Consolato dall’amore, Momen adesso aveva una ragione per andare avanti. Dima l’ha motivato a non arrendersi, lei è stata la sua luce al fondo del tunnel che l’ha spinto, insistendo che sarebbe ritornato ancora più forte.
Con la sua sedia a rotelle e la macchina fotografica Momen ha dato un significato nuovo alla parola perseveranza. Si è rifiutato di stare a letto e ogni giorno si è alzato e ha affrontato la vita. Momen ha scelto di vivere. Ha attraversato paesaggi urbani diversi per scattare foto e non ha avuto paura di salire su auto, edifici, bulldozer, qualsiasi cosa che si frapponesse fra lui e la migliore inquadratura. La sua sedia a rotelle e la macchina fotografica sono diventate parti integranti del suo corpo.
La prima mostra internazionale di Momen è stata in Italia nel 2016. Ovviamente non ha potuto essere presente perché non gli è stato concesso un visto di viaggio. Ha partecipato via Skype e tenuto un discorso per suscitare interesse a favore della lotta palestinese.
La macchina fotografica di Momen era fiera di lui. Avevano ancora una lunga strada da percorrere insieme, ma questo era un primo passo importante nel mondo delle esposizioni internazionali. Dopo quella mostra, è stato conosciuto a livello internazionale ed è riuscito a pubblicare su varie piattaforme altri lavori che documentano la lotta quotidiana dei palestinesi.
In giro per il mondo in sedia a rotelle
Dopo che la sua richiesta di visto era stata respinta varie volte e a causa delle chiusure dei confini, Momen finalmente è riuscito a lasciare Gaza per partecipare alla sua prima mostra in Malesia. Il viaggio fino all’aeroporto internazionale del Cairo è stato movimentato e arrivato là non è stato facile muoversi nell’aeroporto con una sedia a rotelle. Ha dovuto aspettare otto giorni dentro l’aeroporto fino a quando il visto è stato accettato.
La famiglia di Momen è rimasta a Istanbul mentre lui era presente per la prima volta in Malesia alla sua mostra nel 2018.
Al suo ritorno a Istanbul, alla ricerca di una nuova opportunità, ha deciso di restare là.
Sfortunatamente nel 2019, ha perso il lavoro e non ha più percepito lo stipendio. Si trattava di un salario speciale conferito a chi era stato ferito durante la guerra e impossibilitato a lavorare. Questa perdita ha messo in pericolo lui, sua moglie e i loro quattro bambini.
Perché stava succedendo a loro? Tutte le difficoltà che Momen si era trovato davanti non erano colpa sua. Ogni peso che lo opprimeva dipendeva dal fatto che era un palestinese che voleva vivere libero.
A Momen e alla sua famiglia non è rimasta altra scelta che cercare un posto che li avrebbe accolti. All’inizio del 2020 hanno fatto domanda di visto per visitare l’Arabia Saudita e partecipare al pellegrinaggio della Umrah. Ovviamente non sapeva che il Covid-19 avrebbe colpito il mondo, bloccandolo là. Dato che il loro visto stava per scadere, hanno cercato un modo per ritornare in qualsiasi posto li accettasse. Data l’estrema difficoltà di ottenere un visto in un simile momento non trovavano altro che porte chiuse.
Catturare la verità a Gaza
Oggi, dopo sette difficili mesi, Momen e la sua famiglia sono finalmente nella Striscia di Gaza con i loro cari.
La fotografia per Momen, non è solo un hobby, è il suo modo di evadere, uno strumento che gli ha dato le ali per volar via dal blocco di Gaza. La macchina fotografica è dedita a fare il suo dovere, documentare in modo trasparente l’occupazione della Palestina. E, sebbene qualche volta sia stanca, non si arrende mai. Come Momen.
Insieme sono una coppia perfetta, nessuno lascia mai l’altro e insieme trasmettono un messaggio di determinazione, resilienza e patriottismo. Non smetteranno mai di lottare per far sentire la voce della Palestina.
Nonostante le difficoltà quotidiane, con i suoi obiettivi, sulla sua sedia a rotelle e con un sorriso sul volto capace di ispirare chiunque lo veda, Momen continua a catturare la verità.
(tradotto dall’inglese da Mirella Alessio)
 democratico permanente che governa circa 9 milioni di persone, tutti cittadini israeliani; all’interno dei territori occupati da Israele nel 1967, un regime militare temporaneo che governa circa 5 milioni di sudditi palestinesi.
democratico permanente che governa circa 9 milioni di persone, tutti cittadini israeliani; all’interno dei territori occupati da Israele nel 1967, un regime militare temporaneo che governa circa 5 milioni di sudditi palestinesi.