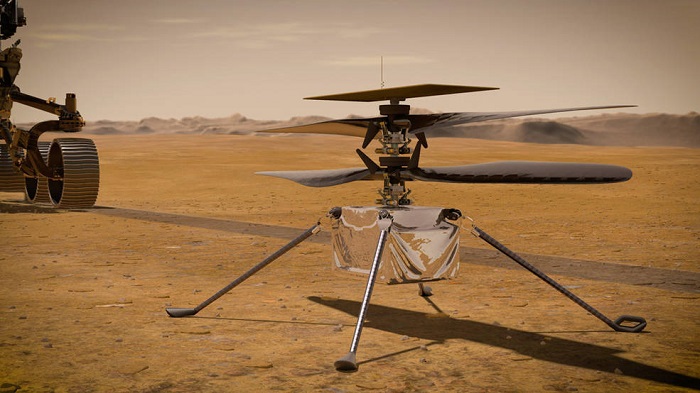Il vero apartheid
Asa Winstanley
17 aprile 2021 Middle East Monitor
“E’ questo il vero apartheid,” ha twittato la scorsa settimana l’avvocata ebrea americana Brooke Goldstein. “il fatto che gli ebrei non possano entrare in territorio palestinese,” ha dichiarato. “Non accetto che ci siano posti dove è pericoloso entrare perché SONO EBREA.”
Goldstein ha inserito nel tweet la foto di un grande cartello rosso in Cisgiordania con la scritta (in ebraico, arabo e inglese): “Questa strada porta a villaggio palestinese [sic] l’ingresso è pericoloso per i cittadini israeliani.”
Tuttavia la Goldstein, a prescindere dalla vergognosa sovrapposizione di ebrei con israeliani, ha trascurato un fatto basilare – il cartello era opera di Israele, non dei palestinesi. In questo modo ha fatto apparire i palestinesi colpevoli di “odio per gli ebrei”.
E’ il regime di apartheid israeliano che stabilisce chi può andare e dove in Cisgiordania. E’ il sistema dittatoriale israeliano dei posti di blocco dell’esercito, delle basi militari e dell’elaborato sistema di permessi che decreta chi si può muovere, dove e perché.
Il post della Goldstein è stato parecchio deriso dagli utenti di Twitter.
Ha ricevuto ciò che i giovani definiscono una “ratio”, vale a dire che ha suscitato molti più commenti (1.100 mentre scrivo questo articolo) che “likes” (378) o retweet (soltanto 145). Le risposte e le citazioni sono quasi tutte critiche e di scherno, fra cui alcune decisamente esilaranti.
Questi cartelli si vedono spesso in Cisgiordania. Chiunque vi sia stato li ha visti all’ingresso dei maggiori agglomerati urbani palestinesi.
Ma questi divieti sono conseguenza del razzismo del regime di apartheid israeliano, non di un immaginario endemico antisemitismo palestinese. L’esercito israeliano ha incominciato a mettere i cartelli intorno all’anno 2006, il periodo in cui vivevo in Cisgiordania.
Questi cartelli non sono unici nella storia del separatismo razziale e coloniale. Molti ricordano che nel sud degli USA ai tempi delle leggi Jim Crow [in vigore fra il 1877 e il 1964, servirono a mantenere la segregazione razziale in tutti i servizi pubblici, ndtr] (prima che il movimento per i diritti civili ottenesse le decisive vittorie degli Anni Sessanta) e in Sud Africa durante l’epoca dell’apartheid, quei regimi avevano implementato un sistema talvolta definito di “segregazione secondaria”.
Cartelli e altre attrezzature segnalavano numerosi spazi pubblici come “riservati ai bianchi” oppure “riservati agli europei”. E’ noto che ai neri veniva negato l’accesso alle fontanelle pubbliche, ed anche a tavole calde ed altri negozi.
Ma il corollario naturale dei cartelli “riservati ai bianchi” erano i concomitanti “riservati ai neri” o “riservati alla gente di colore”, anche questi esposti dagli stessi regimi suprematisti bianchi. Non diversamente, il regime segregazionista israeliano erige questi cartelli rossi per mantenere “al loro posto” i palestinesi.
L’obiettivo vero di quei cartelli non è tenere gli israeliani – certamente non gli ebrei – fuori dalle zone palestinesi in Cisgiordania, semmai di rafforzare l’ideologia europea di separatismo razziale, che nega la pari umanità alla popolazione indigena “non bianca”.
L’obiettivo è far rispettare il principio che nel Sud statunitense delle leggi Jim Crow veniva raccontato come “separati ma uguali”, mentre in realtà era tutto tranne che equo. Gli afroamericani erano sistematicamente tenuti nella povertà più abietta, non diversamente da come il Sudafrica dell’apartheid teneva la maggioranza nera in sistemica povertà.
Il regime segregazionista israeliano nega ai palestinesi pari accesso al sistema scolastico, ai contributi pubblici, alle infrastrutture e alle altre normali funzioni dello Stato, mentre destina generosi investimenti alle comunità ebraiche israeliane. Se questo vale per i palestinesi che teoricamente sono “cittadini israeliani”, non parliamo poi della questione della Cisgiordania occupata, che non è altro che una dittatura dominata dall’esercito israeliano, in cui i palestinesi hanno zero diritti.
Se abbiamo consapevolezza di questa ideologia, possiamo allora comprendere che a chi ha preso in giro la Goldstein per la sua stupidità, pur avendo avuto tutte le ragioni di farlo, è sfuggito però un punto fondamentale.
Quello della Goldstein non è stato un semplice equivoco ed è altrettanto improbabile che ignorasse che è Israele a erigere quei cartelli. E’ invece assai più plausibile che stesse intenzionalmente mentendo per distogliere l’attenzione dal fatto che Israele è un regime segregazionista, fatto di cui si sta sempre di più prendendo coscienza. Ecco perché ha dichiarato che in quel cartello sta il “vero apartheid”.
La realtà è che la Goldstein non è esattamente una qualsiasi sprovveduta con un account su Twitter. In effetti, è una razzista impegnata nella causa anti-palestinese e nell’accanita propaganda a favore dell’imposizione del regime di apartheid israeliano – che si estende alla punizione e persecuzione di chi sostiene i diritti dei palestinesi in ogni parte del mondo.
Gestisce l’organizzazione sionista Lawfare Project [Progetto Guerra Legalista, che finanzia cause legali a sostegno delle comunità ebraiche filoisraeliane, ndtr], che ha la missione di attaccare i palestinesi ed i loro sostenitori nel mondo utilizzando cause legali pretestuose.
Una volta è arrivata a sostenere che “Non esistono persone palestinesi”.
Quindi l’accusa ingiustificata di antisemitismo rivolta dalla Goldstein ai palestinesi è stato un tipico caso di proiezione per cui il razzista presume che tutti quanti – specialmente le sue vittime – condividano le sue stesse idee razziste.
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riflettono necessariamente la politica editoriale del Middle East Monitor.
(Traduzione dall’inglese di Stefania Fusero)