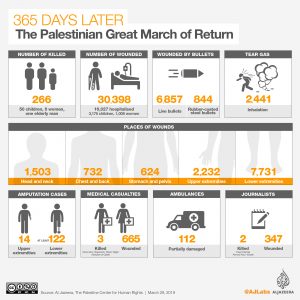I palestinesi cittadini di Israele discutono se boicottare le elezioni
Henriette Chacar e Edo Konrad
7 aprile 2019 +972 Magazine
Dopo quattro anni di uno dei governi più ostili ai palestinesi in Israele, i cittadini arabi stanno discutendo quale sia il modo migliore per far progredire la loro lotta, se partecipare o boicottare le prossime elezioni della Knesset [parlamento israeliano].
Molti palestinesi cittadini di Israele, frustrati dal fallimento delle politiche interne dei partiti arabi e vessati da attacchi continui da parte di politici di tutto lo spettro partitico, stanno esprimendo riserve sul votare alle elezioni di questa settimana. Nonostante un tasso di partecipazione al voto storicamente elevato, un piccolo ma rilevante movimento sta spingendo i cittadini palestinesi a boicottare le elezioni.
L’aspro dibattito contrappone i palestinesi che chiedono il boicottaggio delle elezioni a quelli che vedono la partecipazione al sistema politico come uno dei pochi strumenti disponibili per contrastare la persecuzione israeliana contro i palestinesi – sia il 20% della sua popolazione che Israele definisce una “minaccia demografica”, sia i milioni di palestinesi nei territori occupati che vivono sotto il governo israeliano ma non possono votare.
La discussione è antica quanto lo è Israele. Ma quest’anno gli appelli al boicottaggio si sono fatti più rilevanti e accesi di quanto lo siano stati per anni. Gli attivisti hanno attaccato manifesti in tutte le città di Israele incoraggiando i cittadini palestinesi a restare a casa nel giorno delle elezioni, e importanti politici, giornalisti e addirittura stelle dell’hip hop palestinesi hanno dato il loro appoggio.
Il contrasto è sconvolgente, se si considera quanto i cittadini palestinesi fossero elettrizzati nel recarsi alle urne nelle elezioni del 2015. Dopo che la destra israeliana innalzò la soglia elettorale nel tentativo di escludere i partiti palestinesi, i quattro maggiori partiti palestinesi si unirono in un’unica coalizione per poter sopravvivere. La Lista Unita promise di dare priorità alle esigenze dei palestinesi cittadini di Israele dopo decenni di divisioni e lotte politiche intestine. Fu uno spartiacque per i palestinesi in Israele – la Lista Unita conquistò 13 dei 120 seggi della Knesset, il miglior risultato dalla fondazione dello Stato.
Tuttavia la promessa di unità coincise con uno dei più pericolosi governi israeliani che i cittadini palestinesi abbiano mai visto. L’ultimo governo Netanyahu ha cercato di demolire interi villaggi, ha approvato leggi che sancivano la segregazione etnica e razziale ed ha fomentato una nuova ondata di razzismo contro i cittadini arabi. Poi, nel giugno 2018, la Knesset ha approvato la legge sullo Stato-Nazione ebraico, che sancisce a livello costituzionale la supremazia ebraica in Israele. Il crescendo è arrivato quando la Lista Unita – che comprendeva palestinesi comunisti, islamisti e nazionalisti – si è scissa in due.
“Nel momento stesso in cui loro diventano più oppressivi noi dobbiamo rispondere con ancora maggior forza”, ha detto a +972 Magazine la parlamentare Aida Touma-Sliman, del partito ebreo-arabo Hadash. La comunità palestinese, in quanto “minoranza oppressa e perseguitata”, ha bisogno di essere rappresentata in parlamento, ha sostenuto Touma-Sliman, se non per promuovere i diritti e le esigenze dei palestinesi, per “smascherare l’ipocrisia e gli atteggiamenti razzisti (del governo)”.
“Stiamo aiutando l’opinione pubblica a capire che questa non è democrazia”, ha detto Touma-Sliman.
Punto e a capo
Nasreen Hadad Haj-Yahya, un’attivista sociale e politica che vive a Taybeh, una cittadina nel centro di Israele, ritiene che l’astensione palestinese dal voto sia ciò che vuole la destra – “per far finta che noi non esistiamo”, ha spiegato. “Purtroppo siamo stati delegittimati a tal punto che, oggi, persino la sinistra preferisce perdere un altro turno elettorale piuttosto che collegarsi agli elettori arabi.”
“Non biasimo (chi boicotta le elezioni) perché so quanto sia difficile votare quando sai che il tuo voto non conta niente”, ha detto Hadad Haj-Yahya. I partiti palestinesi sono sempre stati all’opposizione, il che significa che non hanno mai appoggiato alcuna politica governativa, per non parlare di quelle di grandi conseguenze. “Moralmente, è molto difficile far parte di un governo che continua ad opprimere il popolo palestinese in Cisgiordania e a Gaza.”
E’ proprio per questo che Hadad Haj-Yahya è contraria al boicottaggio. “Questa mancanza di speranza, la sensazione che non vinceremo mai – non fa che indebolirci. Non possiamo permetterci di alzare le mani e dire che aspetteremo di vedere che cosa accadrà in questo Paese. Dobbiamo prendere in mano le cose e cercare di promuovere i nostri interessi”, ha sostenuto.
Ma per i palestinesi che invitano al boicottaggio, la lotta riguarda qualcosa di più grande del mettere semplicemente in crisi il governo. Rifiutano l’idea stessa di far parte di un’istituzione che incarna la supremazia ebraica.
“Se partecipo alle elezioni della Knesset, questo significa che attribuirgli legittimità”, ha detto Nizar Hawari, organizzatrice sociale e politica di Tarshiha, una cittadina della Galilea. Hawari, che ha 58 anni, ha detto di aver boicottato le elezioni fin da quando ha avuto il diritto di votare. Non l’ha convinta ad andare a votare nemmeno la Lista Unita, che lei ritiene abbia unito gli elettori palestinesi con la promessa di una maggior rappresentanza, non con un programma politico.
Hawari ha aggiunto che andare a votare non ha fatto che peggiorare le cose, frenando le lotte popolari e creando “un ostacolo al progetto di liberazione nazionale palestinese.”
Secondo Hawari l’alternativa sta nel tornare alla mobilitazione locale, di base. Il movimento di boicottaggio rappresenta un risveglio politico che potrebbe dare nuova energia alla popolazione palestinese e “riportare la nostra lotta al punto di partenza.” La campagna non terminerà martedì, ha affermato, e i militanti del boicottaggio “trasformeranno i nostri principi in un’azione continua.”
Gli attivisti per il boicottaggio hanno appeso manifesti in tutte le città di Israele che invitano i cittadini palestinesi a non partecipare alla “democrazia militare” di Israele. Alcuni di loro hanno costituito un gruppo che si è denominato ‘Campagna popolare per il boicottaggio delle elezioni del parlamento sionista’.
“Lo Stato ebraico ci priva dei diritti civili, non perché sia diminuito il numero di coloro che dicono di rappresentarci nella Knesset, ma perché ci tratta come un problema demografico”, stava scritto in un post sulla pagina Facebook del gruppo fin da fine febbraio.
Gli organizzatori della campagna di boicottaggio non hanno accettato di essere intervistati per questo articolo.
Un altro post diceva: “I partiti politici arabi si stanno inserendo nel sistema coloniale israeliano e ne stanno minando gli stessi fondamenti per la liberazione dal colonialismo, attraverso un’alternativa che coinvolga tutti i mezzi politici, sociali ed economici.”
Votare in massa
Nonostante ciò che credono i leader ebrei israeliani di tutto lo spettro politico, i cittadini palestinesi storicamente hanno preso molto sul serio la loro cittadinanza e il loro diritto al voto, ha detto Hillel Cohen, che è a capo del Dipartimento di Studi Islamici e del Medio Oriente presso l’università ebraica di Gerusalemme.
Nei 18 anni seguenti alla creazione di Israele, il nascente Stato ha posto i palestinesi che erano riusciti a restare nel Paese dopo il 1948 sotto un regime militare, che ha limitato la loro libertà di movimento ed espropriato la loro terra.
Cohen ha spiegato che, mentre alcuni volevano privare completamente o parzialmente i nuovi cittadini arabi del diritto di voto, il primo ministro David Ben Gurion premette perché invece ottenessero il diritto a votare, una decisione che prese in parte per ottenere il sostegno della comunità internazionale.
La posizione di Ben Gurion prevalse, ha detto Cohen. E benché il governo militare non vietasse tecnicamente agli arabi di votare, interferì pesantemente nel processo, anche incarcerando o deportando gli attivisti in prossimità delle elezioni.
Al tempo stesso, la dirigenza israeliana creò diversi partiti arabi satellite guidati da leader locali con stretti legami col Mapai [partito di sinistra israeliano, antecedente del partito laburista, ndtr.]. Attraverso questi partiti strettamente controllati, il governo era in grado di garantire un’alta affluenza di elettori che avrebbe costituito un affidabile bacino di sostegno.
La media dell’affluenza al voto tra i palestinesi si aggirava intorno all’85% fino alla fine del governo militare. Ma anche dopo che non furono più sotto il giogo del governo militare, i palestinesi continuarono a partecipare alla elezioni israeliane in numero relativamente alto. Alla fine degli anni ’80 i cittadini palestinesi formarono i primi partiti arabi non satelliti e nel 1992 queste liste arabe indipendenti ebbero la funzione di un blocco parlamentare di sostegno per l’affermazione del governo di minoranza di Yitzhak Rabin quando sosteneva gli Accordi di Oslo nella Knesset.
I cittadini palestinesi per la maggior parte hanno continuato a partecipare al processo democratico nel corso degli anni. Tuttavia l’affluenza palestinese al voto registrò un crollo all’inizio degli anni 2000, dopo che la polizia uccise 13 palestinesi – 12 dei quali cittadini di Israele – in quelli che sono diventati famosi come i fatti dell’ottobre 2000.
Da allora, la violenza della polizia, spesso letale, e la mancata attribuzione delle responsabilità incisero profondamente nella comunità palestinese in Israele. Ci vollero 15 anni e la creazione della Lista Unita per riportare i numeri dei palestinesi votanti ai livelli precedenti all’ottobre del 2000.
Secondo Yousef Makladeh, che è a capo di Statnet, un istituto di ricerca che si occupa della comunità araba in Israele, quel numero potrebbe nuovamente diminuire in occasione delle elezioni di quest’anno. Il recente sondaggio di Makladeh segnala che solo il 55% dei cittadini palestinesi intende votare martedì – il 9% in meno rispetto al 2015. Inoltre Makladeh ha detto che, mentre solo il 18% degli elettori arabi hanno sostenuto i partiti sionisti nelle ultime elezioni, il suo sondaggio mostra che tale percentuale è salita al 30%.
“Ci sono 940.000 arabi che possono votare in Israele”, ha detto Makladeh. “Se si considera l’accanimento contro i palestinesi di Israele, iniziato con gli incendi nel 2016, proseguito con l’uccisione di Umm al-Hiran e culminato con la legge sullo Stato-Nazione ebraico – tutto ciò ha spinto i cittadini palestinesi a stare a casa e non votare.” Non intendono più cercare di integrarsi nella società israeliana, ha aggiunto.
Intanto, oltre il 70% degli arabi afferma di volere che i loro rappresentanti eletti facciano parte di una coalizione di governo, cosa che Makladeh spiega come risultato della delusione per la Lista Unita. “Molti elettori arabi ritengono che la Lista Unita non sia riuscita a migliorare le loro condizioni di vita, che non li abbia aiutati a mettere più cibo in tavola. Si sono stancati di loro ed ora chiedono politiche pragmatiche.”
(Traduzione di Cristiana Cavagna)