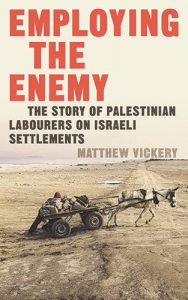STUART LITTLEWOOD
21 settembre 2018, American Herald Tribune
Miko Peled, figlio di un generale israeliano e lui stesso ex-soldato israeliano, è ora un noto attivista pacifista e un instancabile militante per la giustizia in Terra Santa. È considerato una delle voci più limpide che chiedono di sostenere il BDS (Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni) contro il regime sionista e la creazione di un’unica democrazia con uguali diritti in tutta la Palestina storica. Sarà presente al congresso del partito Laburista a Liverpool del 23-26 settembre. Sono stato abbastanza fortunato da avere la possibilità di intervistarlo prima. In una settimana che segna il settantesimo anniversario dell’uccisione di Folke Bernadotte e il trentaseiesimo anniversario del massacro genocida nel campo di rifugiati di Sabra e Shatila, atrocità commesse per perseguire gli obiettivi sionisti, quello che dice Miko potrebbe fornire argomento di riflessione a quanti scrivono sotto dettatura della lobby israeliana.
Stuart Littlewood: Miko, sei cresciuto in una famiglia sionista con una formazione sionista. Cos’è successo perché tu te ne allontanassi?
Miko Peled: Come suggerisce il titolo della mia autobiografia “The General’Son” [Il figlio del generale], sono nato da un padre che era generale dell’IDF [l’esercito israeliano, ndt.] e allora, come evidenzia il sottotitolo, ho intrapreso un “viaggio di un israeliano in Palestina”. Il viaggio ha chiarito a me, e attraverso me spero che chiarisca al lettore, quello che “Israele” è e cos’è la Palestina. È un viaggio dalla sfera dell’oppressore e occupante (Israele) a quella dell’oppresso (Palestina) e del popolo nativo della Palestina. Ho scoperto che di fatto è lo stesso Paese, che Israele è la Palestina occupata. Ma senza il viaggio non me lo sarei mai immaginato. Per me è stato fondamentale. Mi ha permesso di vedere l’ingiustizia, la deprivazione, la mancanza di acqua e di diritti, e via di seguito. Più mi sono permesso, e continuo a permettermi, di avventurarmi in questo viaggio, più sono stato in grado di vedere cosa realmente sia il sionismo, cosa sia Israele e cosa sono io in tutto questo.
Molti mesi fa hai avvertito che Israele stava “impegnandosi al massimo, stava calunniando, stava cercando qualunque mezzo possibile per bloccare Jeremy Corbyn [segretario del partito Laburista inglese e futuro candidato alle prossime elezioni britanniche, ndt.]”, e la ragione per cui viene usata l’accusa di antisemitismo è che non hanno altri argomenti. Ciò si è avverato con Jeremy Corbyn sottoposto a un attacco brutale e continuo persino da parte dell’ex-rabbino capo Lord Sacks. Come dovrebbe affrontarlo Corbyn e quali contromisure gli suggeriresti di prendere?
Nel corso del congresso del partito Laburista dello scorso anno Jeremy Corbyn ha chiarito che non consentirà che le accuse di antisemitismo interferiscano con il suo lavoro come leader del partito Laburista e come uomo impegnato a creare una società britannica e un mondo giusti. In quel discorso ha detto qualcosa che nessun dirigente occidentale oserebbe dire: “Dobbiamo porre fine all’oppressione del popolo palestinese.” E’ sempre stato corretto e il suo appoggio sta aumentando. Penso che stia facendo la cosa giusta. Prevedo che continuerà a farla.
E cosa ne dici dell’esternazione di Sacks?
Non c’è da sorprendersi che un razzista che appoggia Israele se ne possa uscire in questo modo – non rappresenta nessuno.
La direzione del partito Laburista, il NEC, ha adottato in pieno la definizione di antisemitismo dell’IHRA [International Holocaust Remembrance Alliance, organizzazione intergovernativa che si occupa di antisemitismo e ricordo della Shoa, ndtr.], nonostante gli avvertimenti di esperti giuridici e la raccomandazione da parte della Commissione Ristretta della Camera dei Comuni di inserire riserve. Questa decisione è vista come un cedimento a pressioni esterne e ovviamente ha un impatto sulla libertà di parola che è insita nelle leggi britanniche ed è garantita dalle convenzioni internazionali. Come inciderà ciò sulla credibilità del partito Laburista?
Accettare la definizione dell’IHRA è stato un errore e sono sicuro che su quelli che hanno votato per adottarla ricadrà la vergogna. Ci sono almeno due note già emanate dalla comunità degli ebrei ultra-ortodossi, che rappresenta almeno dal 25% al 30% degli ebrei britannici, in cui rifiutano l’idea secondo cui Jeremy Corbyn è antisemita, rifiutano il sionismo e la definizione dell’IHRA.
Tornando all’occupazione, tu hai detto che 25 anni fa Israele ha raggiunto il suo obiettivo di rendere irreversibile la conquista della Cisgiordania. Perché pensi che le potenze occidentali si aggrappino ancora all’idea della soluzione dei due Stati? Come ti aspetti che evolva la situazione?
Gli USA, e soprattutto l’attuale amministrazione, accettano che Israele abbia inglobato tutta la Palestina mandataria e che non ci sia posto per non ebrei in quel Paese. Non affermano il contrario. Gli europei si trovano in una situazione diversa. I politici in Europa vogliono accontentare Israele e lo accettano com’è. Il loro elettorato, tuttavia, chiede giustizia per i palestinesi per cui, con un atto di compromesso poco coraggioso, i Paesi dell’UE trattano l’Autorità Nazionale Palestinese, con uno stile veramente post-coloniale, come se fosse uno Stato palestinese. Penso che sia per questo che gli europei procedono a “riconoscere” il cosiddetto Stato di Palestina, benché non sia tale. Lo fanno per tener buono il loro elettorato senza fare realmente niente per sostenere la causa della giustizia in Palestina. Questi riconoscimenti non hanno aiutato neppure un palestinese, non hanno liberato neanche un prigioniero dalle carceri israeliane, non hanno salvato un solo bambino dalle bombe a Gaza, non hanno alleviato le sofferenze e le privazioni dei palestinesi nel deserto del Naqab [in ebraico Negev, ndt.] o nei campi di rifugiati. È un gesto vuoto, vigliacco.
Quello che dovrebbero fare gli europei è adottare il BDS. Dovrebbero riconoscere che la Palestina è occupata, che i palestinesi stanno vivendo sotto un regime di apartheid nella loro stessa terra, che sono vittime di una pulizia etnica e di un genocidio e che questo deve cessare e che l’occupazione sionista deve finire del tutto e senza condizioni.
Penso che lo Stato di Israele andrà in frantumi e che prima di quanto la maggior parte delle persone pensi vedremo una Palestina libera e democratica dal fiume al mare. La situazione attuale è insostenibile, due milioni di persone a Gaza non spariranno, Israele ha appena annunciato – di nuovo – che due milioni dei suoi cittadini non ebrei non sono accettati come parte dello Stato, e il BDS sta già lavorando.
L’IDF si autodefinisce l’esercito più etico del mondo. Tu hai fatto il servizio militare nell’IDF. Quanto è credibile questa affermazione?
É una menzogna. Non esiste un esercito etico e l’IDF per settant’anni ha partecipato a una pulizia etnica, a un genocidio e a imporre un regime di apartheid. Di fatto l’IDF è una delle forze terroriste meglio equipaggiate, meglio addestrate, meglio finanziate e meglio nutrite al mondo. Benché abbiano generali e belle uniformi e le armi più sofisticate, non sono altro che bande armate di criminali e il loro scopo principale è terrorizzare e uccidere palestinesi. I suoi ufficiali e soldati eseguono con entusiasmo le politiche brutali e crudeli che sono spietatamente inflitte alla vita quotidiana ai palestinesi.
“Breaking the Silence” [Rompere il silenzio, ndt.] è un’organizzazione di veterani dell’IDF impegnata a mettere in luce la verità riguardo a un esercito straniero che cerca di controllare una popolazione civile oppressa da un’occupazione illegale. Sostengono che il loro obiettivo è porre fine prima o poi all’occupazione. Quante possibilità di successo hanno secondo te?
Loro e altre Ong simili potrebbero fare una grande differenza. Sfortunatamente non si spingono abbastanza avanti, non chiedono ai giovani israeliani di rifiutarsi di fare il servizio militare nell’IDF, non rifiutano il sionismo. Senza questi due elementi mi pare che il loro lavoro sia in superficie e non faccia un granché.
Spesso gli israeliani accusano il sistema educativo palestinese di produrre futuri terroristi. Com’è l’educazione in Israele?
Il sistema educativo palestinese viene sottoposto ad uno scrupoloso controllo, quindi ogni accusa di insegnare l’odio è priva di fondamento. Tuttavia Israele fa un ottimo lavoro insegnando ai palestinesi che sono occupati ed oppressi e che non hanno altra scelta che resistere. Lo fanno con l’esercito, la polizia segreta, la burocrazia dell’apartheid, infiniti permessi, divieti e restrizioni sulle loro vite.
I tribunali israeliani insegnano ai palestinesi che non c’è giustizia per loro sotto il sistema israeliano e che non contano niente. Non ho incontrato nessun palestinese che manifestasse odio, ma se qualcuno lo fa è a causa dell’educazione fornita da Israele, non di un qualunque libro scolastico palestinese. Gli israeliani seguono un’approfondita educazione razzista che è ben documentata in un libro di mia sorella, la professoressa Nurit Peled-Elhanan, intitolato “Palestine in Israeli Textbooks” [La Palestina nei testi scolastici di Israele. Ideologia e propaganda nell’istruzione, EGA Edizioni Gruppo Abele, 2015, ndtr.]
Le comunità cristiane stanno rapidamente diminuendo. Gli israeliani sostengono che i musulmani li stanno cacciando, ma i cristiani affermano che è la spietatezza dell’occupazione che ha determinato il fatto che tanti se ne vadano. Che opinione ti sei fatto? Gli israeliani stanno cercando di seminare zizzania tra cristiani e musulmani? É in corso una guerra di religione che spinge i cristiani ad andarsene?
I cristiani rappresentavano il 12% della popolazione palestinese, ora sono a mala pena il 2%. Non c’è nessun altro colpevole oltre a Israele. Israele ha distrutto le comunità e le chiese cristiane come ha distrutto quelle musulmane. Per Israele gli arabi sono gli arabi e non hanno posto nella Terra di Israele. Raccomando vivamente l’eccellente reportage del defunto Bob Simon nel programma “60 minuti” della CBS del 2012 intitolato “Cristiani in Terra Santa”. Alla fine si è scontrato con l’ex-ambasciatore di Israele a Washington che voleva che la messa in onda venisse annullata.
Attualmente ti definisci una persona religiosa?
Non lo sono mai stato.
Tu conosci Gaza. Come giudichi la capacità di Hamas di governare? E mediatori onesti potrebbero lavorare con essa per raggiungere la pace?
Non ho modo di giudicare Hamas in un modo o nell’altro. Ho parlato con persone che hanno lavorato a Gaza per molti anni, sia palestinesi che stranieri, e la loro opinione è che fin dove può arrivare un governo e prendendo in considerazione le durissime condizioni in cui vivono, meritano un elogio.
Qualcuno sostiene che l’opinione pubblica israeliana è per lo più ignara degli orrori dell’occupazione e che la verità gli viene nascosta. Se è vero, ciò inizia a cambiare?
Gli israeliani sanno benissimo delle atrocità e le approvano. Gli israeliani votano, e votano in gran numero e per settant’anni hanno continuato a votare per persone che hanno portato loro e i loro figli a commettere quelle atrocità. Le atrocità sono commesse non da mercenari stranieri, ma da ragazzi e ragazze israeliani che per la maggior parte fanno orgogliosamente il servizio militare. L’unica cosa che è cambiata è il discorso. Nel passato in Israele c’era un’apparenza di discorso civile, e oggi non esiste più. Oggi affermare che Israele deve uccidere sempre più palestinesi è perfettamente accettabile. Nel passato le persone provavano un certo imbarazzo ad ammettere che la pensavano in quel modo.
Israele ha condotto una serie di attacchi armati in acque internazionali contro imbarcazioni per l’aiuto internazionale che portavano rifornimenti di medicinali urgenti e di altro genere non militare alla popolazione assediata di Gaza. Equipaggio e passeggeri sono stati regolarmente picchiati e incarcerati, alcuni uccisi. Ora gli organizzatori devono rinunciare o rinnovare i loro tentativi utilizzando tattiche diverse?
Le flottiglie di Gaza sono sicuramente da lodare, ma se l’obiettivo è raggiungere le spiagge di Gaza sono destinate a fallire. Il loro valore risiede solo nel fatto che sono un’espressione di solidarietà e ci si deve chiedere se il tempo, lo sforzo, il rischio e le spese giustifichino il risultato. Israele farà in modo che nessuno riesca a passare e il mondo non presta loro molta attenzione. A mio parere le flottiglie non sono la forma migliore di azione. Nessuno dei problemi nella continua tragedia dei palestinesi può essere risolto singolarmente. Non l’assedio a Gaza, non i prigionieri politici, non la questione dell’acqua, non le leggi razziste, ecc.
Solo una strategia mirata e ben coordinata per delegittimare e abbattere il regime sionista può portare giustizia alla Palestina. Il BDS ha il miglior potenziale per questo, ma non viene utilizzato a sufficienza e si perde troppo tempo a discuterne i vantaggi.
Sicuramente una delle debolezze di quelli che si preoccupano di vedere la giustizia in Palestina è che chiunque abbia un’idea semplicemente “vi si dedica”. Ci sono poco coordinamento e poca strategia riguardo alla questione fondamentale di come liberare la Palestina. Israele è riuscito a creare un senso di impotenza da questa parte e a legittimare se stesso e il sionismo in generale, e questa è una sfida impegnativa.
Questa settimana è stato il settantesimo anniversario dell’uccisione di un diplomatico svedese, il conte Folke Bernadotte, da parte di un commando sionista mentre fungeva da mediatore del Consiglio di Sicurezza dell’ONU nel conflitto arabo-israeliano. Tutti sono rimasti stranamente indifferenti a questo, persino gli svedesi.
Questo è stato uno tra i molti assassinii politici perpetrati da gruppi terroristici sionisti di cui nessuno è stato chiamato a rispondere. Il primo fu nel 1924, quando assassinarono Yaakov Dehan [scrittore ebreo olandese antisionista, ndt.]. Poi nel 1933 uccisero Chaim Arlozorov [sindacalista, poeta e politico israeliano, ndt.]. Il massacro nel 1946 dell’hotel King David [sede del governo mandatario britannico in Palestina, ndt.] fu ovviamente motivato da ragioni politiche e provocò quasi cento morti, molti dei quali persone innocenti che si trovarono nel posto sbagliato nel momento sbagliato. Poi nel settembre 1948 l’assassinio a Gerusalemme dell’intermediario dell’ONU e membro della famiglia reale svedese, Folke Bernadotte, che a quanto pare era arrivato con piani per porre fine alla violenza in Palestina, piani che i dirigenti sionisti non consideravano accettabili. Bernadotte è sepolto in un’umile tomba di famiglia a Stoccolma, che io sappia non sono previste cerimonie commemorative o qualunque riferimento a questo anniversario da parte di alcuna organizzazione ufficiale svedese. Mio nonno fu il primo ambasciatore israeliano in Svezia. Ciò avvenne poco dopo l’assassinio e fece un buon lavoro per garantire che il governo svedese mettesse a tacere la questione.
Ci furono molte più uccisioni e massacri – viene in mente l’attacco contro la nave da guerra USA “Liberty” e il ruolo giocato dalla brutalità dell’apparato sionista che vede l’assassinio come uno strumento legittimo per raggiungere i propri obiettivi politici. Si sa o si ricorda poco di queste brutali uccisioni. Innumerevoli dirigenti, scrittori, poeti, ecc. palestinesi vennero assassinati da Israele.
Il movimento di solidarietà con la Palestina ripone molte speranze nel BDS. Quanto è efficace il BDS e come la società civile può aumentare al massimo la pressione?
Il BDS è un processo molto efficace ma lento. Non funzionerà per intervento magico o divino. Le persone devono accoglierlo a pieno, lavorare duramente, chiedere l’espulsione di tutti i diplomatici israeliani e l’isolamento totale di Israele. C’è troppa tolleranza per quelli che promuovono il sionismo, Israele e l’esercito israeliano e questo deve cambiare. I politici eletti devono essere obbligati ad accettare il BDS in toto. I gruppi solidali con la Palestina devono passare dalla solidarietà alla resistenza totale, e il BDS è la forma ideale di resistenza a disposizione.
Ci sono altre questioni fondamentali che stai affrontando adesso?
Ritengo che a questo punto sia fondamentale passare dalla solidarietà alla resistenza. È importantissimo utilizzare gli strumenti a nostra disposizione, come il BDS. L’approvazione della legge israeliana sullo Stato-Nazione è un’opportunità per unire di nuovo i cittadini palestinesi di Israele con gli altri palestinesi. Tutti noi dobbiamo cercare di portare l’unità totale tra i rifugiati, la Cisgiordania, Gaza e il 1948 [cioè Israele, ndt.] e chiedere la totale uguaglianza di diritti e la sostituzione del regime sionista che ha terrorizzato la Palestina per settant’anni con una Palestina libera e democratica. Spero che questa opportunità venga colta.
Per terminare, Miko, come stanno andando i tuoi due libri – ‘The General’s Son’ e ‘Injustice: The Story of The Holy Land Foundation Five’ [Ingiustizia: la storia dei cinque della “Fondazione della Terra Santa”, sui responsabili di una Ong USA ingiustamente condannati per finanziamenti mai avvenuti ad Hamas, ndtr.]? Mi pare che l’ultimo, che racconta come il sistema giudiziario negli USA sia stato indebolito a favore di interessi filo-israeliani, dovrebbe essere un libro molto letto qui, nel Regno Unito, dove la stessa cosa sta avvenendo nelle nostre istituzioni politiche e parlamentari e potrebbe diffondersi nei tribunali.
Beh, stanno andando bene, benché nessuno dei due sia ancora un best seller, e dato che stiamo dalla parte meno popolare della questione è difficile venderlo. “The general’s son” è uscito nella seconda edizione, per cui va bene, e naturalmente mi piacerebbe vedere questo e “Injustice” in mano a più persone. Purtroppo però poca gente ha capito come l’occupazione in Palestina stia colpendo le vite di persone in Occidente a causa del lavoro di gruppi di controllo sionisti come il Board of Deputies [gruppo di parlamentari britannici che appoggia Israele, ndt.] in Gran Bretagna e AIPAC e ADL [due associazioni lobbistiche a favore di Israele, ndtr.] negli USA.
In questo solo caso, cinque innocenti stanno scontando condanne di lunga durata nelle prigioni federali degli USA solo perché sono palestinesi.
Molte grazie, Miko, ti ringrazio per aver trovato il tempo di condividere le tue opinioni.
La principale delle molte idee positive che ho avuto da questo incontro con Miko è la necessità per gli attivisti di cambiare marcia e accelerare dalla solidarietà alla resistenza totale. Ciò significherà maggiore coinvolgimento, miglior coordinamento, modificare gli obiettivi e una strategia più acuta. Di fatto un BDS MK2, sovralimentato e con benzina ad alto numero di ottani. In secondo luogo, dobbiamo trattare il sionismo e quelli che lo promuovono con molta minore tolleranza. Come ha detto Miko in un altra occasione, “se opporsi ad Israele è antisemitismo, allora come chiamate l’appoggio a uno Stato impegnato da settant’anni in una brutale pulizia etnica?”
Riguardo a Jeremy Corbyn – se legge questo articolo – sì, sarebbe meglio che ci andasse giù pesante con i seminatori d’odio, compresi i veri antisemiti con la schiuma alla bocca, ma dovrebbe anche ripulire il partito Laburista della sua altrettanto spregevole “Tendenza Sionista”. E questo vale per tutti i nostri partiti politici.
(traduzione di Amedeo Rossi)