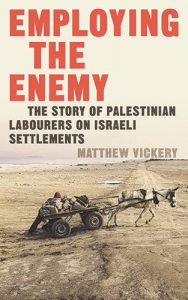Le contraddizioni di una religione atea
Rabkin Y. M., Capire lo Stato di Israele. Ideologia, religione e società, Zambon, Francoforte, 2018.
Recensione di Amedeo Rossi
“Dio non esiste e ci ha promesso questa terra”: con questa caustica citazione di un intellettuale israeliano l’autore, docente di storia all’università di Montreal, in Canada, sintetizza il rapporto contraddittorio tra ideologia e religione che caratterizza il sionismo e l’attuale società israeliana.
Rabkin inizia la sua analisi presentando un’interpretazione che smentisce le basi teologiche su cui si fonda la rivendicazione della conquista della Palestina da parte del popolo ebraico. A differenza di quanto è stato e viene tuttora affermato dai leader sionisti e dai coloni fondamentalisti religiosi, la tradizionale posizione dei rabbini nei confronti della “terra di Israele” è stata a lungo caratterizzata da una sostanziale indifferenza nei confronti di qualunque tipo di rivendicazione territoriale. Anzi, l’idea di riunificare il popolo ebraico in Palestina è stata considerata empia e combattuta. Lo stesso termine “antisionista” è nato tra gli ebrei, sia religiosi che laici. Su questo punto Rabkin insiste con un’analisi approfondita e ricca di citazioni ricavate da testi per lo più religiosi. “Vi era ben poco spazio per la tradizione ebraica nel progetto sionista, che non soltanto aveva avuto origine in ambienti protestanti, ma era appoggiato da individui di origini ebraiche che si professavano atei o agnostici,” ricorda Rabkin nella nota introduttiva. Infatti, il concetto stesso di “esilio”, centrale nell’ideologia sionista, nella fede ebraica “è innanzitutto uno stato di incompletezza spirituale, una perdita di contatto con la presenza divina, più che un allontanamento da un luogo fisico concreto.” Addirittura, la nascita dello Stato di Israele, che per i sionisti è considerata la redenzione dallo sterminio e dalle persecuzioni, per i rabbini è stata e sarà la causa del processo di distruzione del popolo ebraico per aver violato i precetti divini. Alcuni rabbini, come Elhanan Wasserman, erano convinti che la Shoà “non potesse essere altro che un castigo per l’abbandono della Torah così a lungo incoraggiato e praticato dai sionisti.”
Secondo l’autore il movimento sionista, pur facendo frequente ricorso a citazioni bibliche, avrebbe operato una separazione tra il giudaismo (inteso come identità spirituale e religiosa peculiare del popolo ebraico) ed ebraismo, concetto etnico- razziale prima ancora che culturale. Nel libro questo processo di allontanamento viene attribuito storicamente a due processi fondamentali: l’influenza tra gli intellettuali laici assimilati del millenarismo protestante, che già nel 1621 avrebbe preconizzato il ritorno degli ebrei in Terrasanta come propedeutico al ritorno di Cristo sulla terra; il processo di emancipazione fallita degli intellettuali ebrei, che sarebbero stati frustrati dalle politiche restrittive e discriminatorie messe in atto soprattutto nei Paesi dell’Europa centro orientale. Ciò li avrebbe portati ad accogliere il nazionalismo tipico dell’epoca e a considerarlo l’unica soluzione contro le persecuzioni, in particolare nell’impero zarista. Sviluppatosi in un contesto politico autocratico, lontano dal liberalismo che stava conquistando l’egemonia politica nei Paesi occidentali, il sionismo laico avrebbe aderito ad un nazionalismo “Sangue e suolo” con forti connotati autoritari.
Per sostenere quest’ultima tesi Rabkin tratta con maggiore approfondimento la corrente “revisionista” del sionismo (Jabotinsky e Nordau) e ricorda anche le simpatie per i regimi di destra, compreso il nazismo, e per l’URSS di Stalin che hanno caratterizzato le vicende storiche nel sionismo fino alla creazione dello Stato di Israele. Oltre al volontarismo, che ha caratterizzato sia il marxismo-leninismo che fascismo e nazismo, l’autore sostiene ad esempio che “tra il movimento sionista e il nazionalsocialismo esisteva un’affinità concettuale, anche se non politica: entrambi consideravano gli ebrei come un popolo straniero che non si sarebbe mai assimilato e per il quale non vi era posto in Europa.” Nel libro si insiste molto sulla dicotomia tra gli ebrei originari dei Paesi dell’Est Europa, che avrebbero dato vita ad un movimento politico fortemente caratterizzato da autoritarismo e cinismo, e il contesto liberale in cui al contrario si sarebbe sviluppata l’opposizione a questo progetto.
Il libro cita anche vari esempi di opposizione, o quanto meno di critica, al sionismo da parte di intellettuali laici, come Arendt, Freud, Buber, Einstein (che definì Jabotinsky “un pericolo per la nostra gioventù quanto l’hitlerismo lo è per la gioventù tedesca”), oltre naturalmente ai comunisti ed ai socialisti ebrei, come i militanti del Bund, su cui però l’autore ricorda lo sprezzante giudizio di Plechanov, il padre del marxismo in Russia, che definiva i bundisti “sionisti con il mal di mare”. Ma Rabkin si concentra in particolare sull’opposizione religiosa, tra gli haredi (ortodossi e ultraortodossi) e gli ebrei riformati in Europa e negli USA, ricordando ad esempio la tragica vicenda dell’avvocato e giornalista olandese Jacob de Haan. Pur essendo un haredi, aderì al sionismo e nel 1919 si stabilì a Gerusalemme. Resosi conto della situazione, cercò di arrivare a un accordo tra il potere mandatario inglese, i notabili arabi e i coloni ebrei. La sua influenza a Londra e i buoni rapporti con il figlio del re di Giordania potevano minacciare i progetti sionisti, e venne ucciso da sicari dell’Haganah, la milizia armata dei laburisti. Un complice dell’omicidio dopo anni ammise che venne eliminato perché l’eventuale accordo avrebbe minacciato i progetti sionisti.
Oltre alla creazione dello Stato di Israele nel 1948, la guerra dei Sei Giorni del 1967 rappresenta l’altro punto di svolta nei rapporti tra progetto sionista e opposizione religiosa. La vittoria sui nemici arabi “era stata l’opera della divina provvidenza, oppure l’opera di Satana, che crea miraggi di redenzione per fuorviare gli innocenti […] costituiva parte di un susseguirsi ininterrotto di distruzioni originatosi con l’ascesa del sionismo, proseguito con le stragi naziste e destinato inevitabilmente a concludersi con il declino e la caduta.” Questa posizione radicalmente critica è diventata progressivamente sempre più marginale, ed anzi dal ’67 molti gruppi integralisti religiosi si sono sempre più schierati a sostegno di Israele e del processo di colonizzazione dei territori palestinesi occupati. Sono stati quelli che Rabkin chiama i “fautori del nazional-giudaismo” (mentre il sociologo delle religioni Renzo Guolo usa il termine “fondamentalisti nazional-religiosi”) ad essere i primi a fondare colonie e ad essere i più fanatici e violenti contro i palestinesi. Il libro ricorda in particolare l’assassinio di Rabin e l’attentato di Baruch Goldstein a Hebron.
Nonostante questo rapporto contraddittorio e spesso conflittuale con il sionismo, l’autore ammette che le comunità ebraiche del resto del mondo si sono schierate in modo incondizionato dalla parte di Israele. Rabkin spiega questo dato affermando che “per molti, la fedeltà a Israele ha da lungo tempo sostituito il giudaismo come principio cardine dell’identità ebraica. Me nella diaspora, questa fedeltà si indirizza ad uno Stato ideale, persino immaginario, più che allo Stato di Israele esistente.” Questa visione idealizzata non ammette critiche e non dà ascolto neanche alle voci degli israeliani dissidenti. Tuttavia, ricorda l’autore, da sondaggi effettuati sull’argomento risulta che negli USA solo il 40% degli ebrei ritiene che Israele incarni la promessa di dio al popolo ebraico, contro l’82% degli evangelici bianchi. Con questo dato coerente con le argomentazioni del libro, a conferma dell’importanza, anche numerica (Rabkin parla di 50 milioni di “cristiani sionisti” negli USA), delle sette protestanti nel sostegno incondizionato a Israele, si chiude il libro.
In conclusione, si tratta di un lavoro molto approfondito e complesso, in cui la religione e la teologia ebraiche si ripercuotono sulle questioni politiche che segnano le vicende dello Stato di Israele e dell’ideologia da cui è nato. È un saggio che richiede una lettura attenta e competente, molto ricco di spunti di discussione (peccato che delle molte fonti riportate in nota nella bibliografia finale vengano citati solo i libri editi in italiano). Come ha scritto lo storico israeliano Shlomo Sand in una frase citata all’inizio del volume: “Chi crede che il sionismo sia una prosecuzione del giudaismo farà bene a leggere questo libro; e chi crede che Israele sia uno Stato ebraico deve leggerlo assolutamente.”