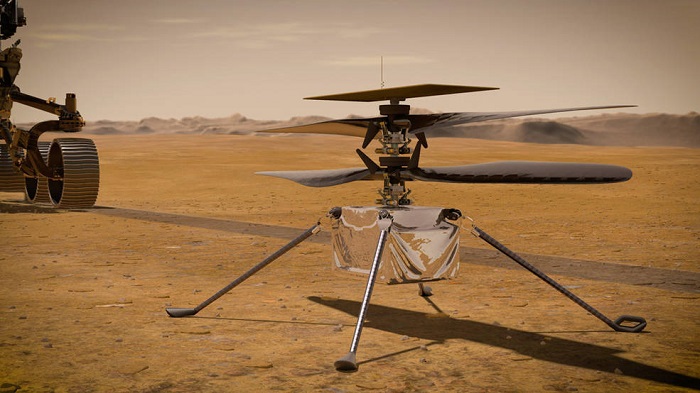Yara Hawari
6 aprile 2021 – Al Shabaka
Sintesi
I finanziamenti ai progetti People-to-People [Da-Persona-a-Persona] (P2P) sono ripresi negli USA e in Europa, minacciando di danneggiare le leggi internazionali e i diritti dei palestinesi. L’analista esperta di Al-Shabaka Yara Hawari esamina le sconcertanti implicazioni delle iniziative P2P e offre indicazioni su come i decisori politici possano contrastarle per portare avanti una giusta pace che chiami Israele a rendere conto delle sue violazioni dei diritti dei palestinesi.
Introduzione
Tra le iniziative finanziate in Palestina dai donatori è stato riattivato lo schema People-to-People (P2P), che riguarda progetti che uniscono attori palestinesi e israeliani della società civile in cosiddette collaborazioni e discussioni. Sottolineando i concetti di cooperazione, comprensione e costruzione della pace, P2P è pubblicizzato come un progetto positivo nel momento in cui la situazione politica si sta aggravando. Benché in apparenza P2P possa sembrare promettente, il contesto è profondamente problematico, presentando fondamentali ostacoli sia epistemici che materiali sul terreno, per riuscire a portare Israele a rispondere delle sue violazioni dei diritti umani dei palestinesi e raggiungere una pace giusta.
Invece di identificare la colonizzazione di insediamento israeliana e l’occupazione militare come la causa profonda, l’inquadramento complessivo [P2P] si basa sulla convinzione aprioristica che ci sia un lungo conflitto tra palestinesi e israeliani. Inoltre stabilisce che il contatto e il dialogo siano il modo per porre fine alla violenza e quindi al conflitto, creando un falso parallelo tra l’oppressione strutturale da parte degli occupanti israeliani e la giustificata resistenza dei palestinesi oppressi.
Diversi attori locali ed internazionali hanno anche dimostrato che P2P è inutile, perché la grande maggioranza dei palestinesi non ne vuole sapere. Infatti la società civile palestinese rifiuta in modo unanime l’idea di P2P perché i progetti non si basano sui principi delle leggi internazionali o sul riconoscimento dei diritti fondamentali dei palestinesi. Di fatto spesso arrivano persino a compromettere tali diritti.
Benché fin dall’inizio degli anni 2000 P2P sia in declino, recentemente è stato rivitalizzato con il Middle East Partnership for Peace Act [legge sulla Collaborazione per la Pace in Medio Oriente] di Nita M. Lowey [parlamentare USA, ndtr.], approvata dal Congresso USA nel dicembre 2020. La legge prevede 250 milioni di dollari in cinque anni per due fondi, uno dei quali specificatamente incentrato su “progetti di pace e riconciliazione” tra palestinesi e israeliani. Notizie nei media l’hanno definita un’iniziativa per riprendere gli aiuti ai palestinesi dopo una lunga interruzione durante l’amministrazione Trump. È stata persino festeggiata come una spinta al riavvicinamento e a un approccio nuovo a un processo di pace altrimenti stagnante.
Una rapida occhiata a questa legge e al finanziamento in sé non provocheranno necessariamente un allarme per molti parlamentari progressisti. Tuttavia un’analisi più approfondita sia del testo della legge che delle sue probabili implicazioni rivela un preoccupante precedente a minacciare le leggi internazionali e i diritti fondamentali dei palestinesi, anche perché ignorano l’impunità del regime israeliano. Questo articolo di politica presenta una critica a P2P e dimostra il pericolo di questo progetto volendo garantire giustizia ai palestinesi. Infine l’articolo arriva a concludere che quanti appoggiano i principi fondamentali delle leggi internazionali e i diritti dei palestinesi dovrebbero contrastare questi finanziamenti e il contesto P2P più in generale e portare Israele a rendere conto delle sue violazioni.
Un quadro problematico e ormai defunto
Il predecessore di P2P è stata la diplomazia Track II [Cammino II] degli anni ’80, in cui vennero utilizzati canali ufficiosi per creare spazi informali in cui discutere alternative di soluzione con l’intento di influenzare prima o poi quanti erano coinvolti nella diplomazia Track I, in cui avvenivano negoziati ufficiali tra dirigenti politici. Ma P2P è decollato dopo la firma degli Accordi di Oslo del 1993, che ampliarono l’ambito della diplomazia Track II per includere le organizzazioni della società civile palestinese e israeliana che non intendevano necessariamente influenzare i politici, ma piuttosto creare una migliore comprensione tra i due popoli.
Mentre la traiettoria storica del quadro P2P è complessa, è importante notare che conobbe un periodo di significativo declino iniziato all’inizio degli anni 2000 in seguito a vari fattori: lo scoppio della Seconda Intifada, il crollo della “sinistra” israeliana, alcuni membri della quale avevano partecipato ai progetti P2P, e nel 2007 l’emergere di un rinnovato accordo della società civile palestinese contro la normalizzazione.
“Contrasto alla normalizzazione” è una definizione coniata e definita dalla società civile palestinese. Trova le sue radici nella lotta palestinese contro l’occupazione britannica culminata con la Grande Rivolta del 1936-1939. “Contrasto alla normalizzazione” vuol dire rifiuto palestinese di partecipare a progetti, eventi o attività che promuovano il concetto secondo cui Israele è un’entità legittima che a sua volta avrebbe normalizzato i rapporti tra l’oppressore e l’oppresso.
Come tattica il contrasto alla normalizzazione è un tentativo di rifiutare la legittimazione e l’occultamento delle violazioni dei diritti dei palestinesi da parte di Israele attraverso la patina del dialogo. Un esempio di normalizzazione sarebbe un progetto che intenda unire donne israeliane e palestinesi per discutere delle sfide che devono affrontare rispettivamente nella società senza citare la fondamentale disparità tra loro, una disparità che sottomette regolarmente le donne palestinesi alla violenza da parte del regime israeliano.
Il contrasto alla normalizzazione non è semplicemente una posizione di principio, ma anche una tattica politica che riconosce il fallimento di un dialogo tra palestinesi ed israeliani e una costruzione della pace che non siano fondati sui principi fondamentali delle leggi internazionali. Infatti riconosce che i progetti P2P ignorano le responsabilità israeliane nella violazione dei diritti dei palestinesi e di conseguenza i palestinesi vedono i progetti P2P come tattiche specificamente destinate a garantire l’impunità di Israele.
Oltretutto P2P sottolinea l’importanza della “cooperazione oltre i confini” per raggiungere una pace duratura. Progetti all’interno di questo quadro sono destinati a “iniziare e promuovere contatti a livello di base e l’interazione tra persone sui lati opposti del confine.” Ma nel caso della Palestina ciò è chiaramente inapplicabile. Come Edward Said e altri intellettuali e attivisti palestinesi hanno instancabilmente sostenuto, il conflitto non è tra due parti uguali intrappolate in una lotta simmetrica. È invece un colonialismo d’insediamento e un’oppressione senza sosta di Israele nei confronti dei palestinesi.
Il concetto di confine è altrettanto errato. Il regime israeliano è un’entità sovrana de facto dal fiume Giordano al mare Mediterraneo. Da decenni ha tenuto milioni di palestinesi sotto occupazione militare e, nel contempo, continua ad espropriare terra palestinese. Il risultato è la bantustanizzazione dei palestinesi in piccole enclave. Da parte sua il regime israeliano non ha mai ufficialmente dichiarato i suoi confini; farlo sarebbe stato in conflitto con le sue intenzioni espansioniste. In questo modo la narrazione P2P di due popoli in conflitto attraverso un confine condiviso rappresenta in modo errato la situazione di un popolo palestinese occupato e colonizzato.
Ancora peggio, P2P presuppone che i palestinesi cooperino e si riconcilino con un popolo e un’entità che approvano la loro colonizzazione e occupazione o che le praticano direttamente. Non sorprende che tali progetti siano nella stragrande maggioranza falliti. Infatti le analisi di un rapporto del 2014 della Commissione per lo Sviluppo Internazionale del governo britannico riguardo ai programmi P2P in Cisgiordania hanno rilevato che tali progetti hanno avuto un costo elevato e nel complesso hanno prodotto “risultati, modularità e un impatto strategico dimostrabile scarsi.”
Un’altra narrazione comune è il falso assunto che iniziative e finanziamenti P2P abbiano il potenziale di “far ripartire” l’economia palestinese, un concetto pericoloso che ignora di proposito il dato di fatto che l’economia palestinese è totalmente soffocata dal regime israeliano. Oltre a essere falso, ciò non considera il regime israeliano responsabile della continua distruzione dell’economia palestinese. Infatti fin dalla fondazione dello Stato israeliano nel 1948 e in seguito alle successive ondate di occupazione della terra palestinese l’economia dei palestinesi è stata schiacciata.
Gli Accordi di Oslo l’hanno ulteriormente assoggettata, e il Protocollo di Parigi del 1994 è stato particolarmente dannoso. Ha imposto un’unione doganale iniqua, che concede alle imprese israeliane accesso diretto al mercato palestinese, ma limita l’ingresso dei prodotti palestinesi a quello israeliano; concede allo Stato di Israele il controllo sulla riscossione delle imposte; rafforza ulteriormente l’uso dello shekel israeliano in Cisgiordania e a Gaza, lasciando l’Autorità Nazionale Palestinese (ANP) appena creata senza mezzi per imporre il controllo fiscale o adottare politiche macroeconomiche autonome.
In effetti ciò significa che oggi il regime israeliano ha il totale controllo diretto o indiretto sulle leve dell’economia palestinese. L’occupazione militare rafforza questa situazione, consentendo al regime israeliano di esercitare il controllo fisico sulle attività economiche quotidiane dei palestinesi e di espandere l’espropriazione della terra palestinese.
L’iniezione di denaro in questo sistema attraverso iniziative finanziate con P2P non è ciò di cui ha bisogno l’economia palestinese. Invece, come ha scritto Leila Farsakh [economista giordano-palestinese, ndtr.], “l’economia palestinese…non può esistere, per non dire prosperare, fino a quando la comunità internazionale non chiamerà Israele a rispondere in base alle leggi internazionali, proteggerà i diritti dei palestinesi e obbligherà Israele a porre fine alla sua occupazione.”
Il Middle East Partnership for Peace Act
Indipendentemente dalle questioni fondamentali su illustrate, il quadro P2P è tornato di moda in seguito al Middle East Partnership for Peace Act [legge per la Collaborazione in Medio Oriente per la Pace] di Nita M. Lowey nel 2000. La legge è stata proposta al Congresso USA dall’ex parlamentare democratica Nita Lowey e dal repubblicano Jeff Fortenberry, a dimostrazione dell’appoggio bi-partisan alla legge.
In seguito alla sua approvazione l’Alliance for Middle East Peace [Alleanza per la Pace in Medio Oriente] (ALLMEP) ha rivendicato l’iniziativa spiegando che si è trattato del risultato di “oltre un decennio di sostegno” da parte di ALLMEP “alla creazione di un Fondo Internazionale per la Pace Israelo-palestinese.” ALLMEP cita una “vasta coalizione” di sostenitori, che include J Street, il New Israel Fund, Jewish Federations of North America, l’Israel Action Network, Churches for Middle East Peace, AIPAC, AJC e l’Israel Policy Forum. Significativamente tutte queste organizzazioni tranne una sono dichiaratamente sioniste.
Un mese prima della legge, ALLMEP ha citato un dibattito parlamentare in Inghilterra diretto dalla deputata Catherine McKinnell, a capo di Labour Friends of Israel [Amici Laburisti di Israele], che ha portato avanti l’idea di creare un fondo simile in Gran Bretagna. Si sosteneva che la proposta era ampiamente appoggiata da deputati sia dell’opposizione che del partito di governo. Nel dibattito McKinnell ha finito con un accenno all’International Fund for Ireland [Fondo Internazionale per l’Irlanda, istituito per finanziare progetti di pacificazione in Irlanda del nord, ndtr.] e al Good Friday Agreement [Accordo del Venerdì Santo, che ha posto fine alla guerra civile nell’Irlanda del Nord, ndtr.]. In effetti ALLMEP fa riferimento all’ International Fund for Ireland (IFI) come “quadro concettuale” che sta dietro a questa idea di un fondo per “la pace israelo-palestinese” e cita il Partnership for Peace Act [legge per una pace condivisa ndtr] quale primo passo verso un tale fondo.
Dopo il dibattito, McKinnell ha inviato una lettera aperta a James Cleverly, ministro per il Medio Oriente e il Nord Africa presso l’Ufficio per gli Esteri, il Commonwealth & lo Sviluppo (FCDO). Nella lettera chiede al ministro di incontrarla per discutere del coinvolgimento britannico in tale fondo. Ha anche chiesto al ministro di impegnarsi a “discutere con l’amministrazione Biden come il Middle East Partnership for Peace Fund possa trasformarsi in una vera istituzione internazionale.” Infine ha proposto che la Gran Bretagna presenti una richiesta agli USA per uno dei seggi come membro internazionale nel consiglio del Partnership for Peace Act.
La legge è stata adottata anche nel testo della legge di bilancio per il Dipartimento di Stato e le Operazioni Estere del 2021. Essa destina 50 milioni di dollari all’anno per oltre 5 anni per la costituzione di due fondi: il fondo “People-to-People Partnership for Peace” con USAID [discussa agenzia federale USA per la cooperazione internazionale, ndtr.] e la Joint Investment for Peace Initiative [Iniziativa di Investimenti Congiunti per la Pace] dipendente dall’ International Development Finance Corporation [Società Finanziaria per lo Sviluppo Internazionale, istituzione finanziaria federale USA che gestisce i fondi per lo sviluppo, ndtr.].
Il fondo P2P è governato e gestito dall’Amministrazione dell’Agenzia USA per lo Sviluppo Internazionale in collaborazione con il Segretario di Stato e il ministero delle Finanze USA.
Vi sovrintende un consiglio di amministrazione formato da cinque cittadini USA nominati dall’amministrazione dell’Agenzia USA per lo Sviluppo Internazionale. La legge, stilata per la prima volta nel giugno del 2019, stabilisce che i membri del consiglio debbano essere persone che hanno “dimostrato esperienza e competenza nelle questioni relative a Israele e ai territori palestinesi,” e fa particolare riferimento alla competenza in campo economico. Due seggi del consiglio sono riservati a rappresentanti di organizzazioni internazionali di governi esteri: da qui la summenzionata richiesta di McKinnell di un rappresentante britannico.
Il fondo sarà finanziato principalmente dagli USA, ma la legge afferma anche che “raccoglierà ulteriori contributi per il Fondo dalla comunità internazionale, compresi Paesi del Medio Oriente e in Europa.”
Gli Stati che hanno recentemente normalizzato i rapporti con il regime israeliano saranno senza dubbio inclusi tra quelli a cui si chiederanno contributi. È anche probabile che gli ideatori del fondo sperino che diventi il principale meccanismo attraverso il quale finanziamenti internazionali saranno diretti in Palestina e i palestinesi saranno obbligati a impegnarsi nel “dialogo” P2P con gli israeliani come condizione per ricevere finanziamenti. In cambio questo darà come risultato il monopolio e la micro-gestione da parte degli Usa della maggioranza dei progetti finanziati dai donatori in Palestina.
Minare le leggi internazionali e rinunciare a chiamare Israele a rispondere dei suoi crimini
Benché il discorso del Partnership for Peace Act riguardi pace e cooperazione, una lettura attenta del testo della legge rivela preoccupanti lacune che consentono il totale annullamento dei diritti dei palestinesi. Così facendo la legge incoraggia le violazioni israeliane del diritto internazionale.
Nel settembre 2020 l’analista politica di Al-Shabaka e avvocatessa per i diritti umani Zaha Hassan ha notato che una prima bozza della legge vietava la “discriminazione geografica” nella presentazione di richieste da parte di beneficiari da “Israele, Cisgiordania e Gaza.” In altre parole chiunque, compresi i coloni israeliani in Cisgiordania, avrebbero potuto presentare domanda di finanziamenti.
In effetti Hassan ha evidenziato che un rapporto della commissione per gli Stanziamenti del Senato [USA] che ha messo in discussione la prima versione della legge, aveva esplicitamente affermato che i finanziamenti avrebbero dovuto essere utilizzati “per incoraggiare il commercio tra l’economia israeliana e palestinese in Cisgiordania.” Benché la versione finale non contenga più quella formulazione, essa non presenta alcuna definizione che possa impedire ai coloni di far richiesta di finanziamenti. Eppure l’impresa di colonizzazione del regime israeliano in Cisgiordania, avviata da un governo laburista israeliano poco dopo la conquista della Cisgiordania nel 1967, è uno dei crimini più vergognosi contro il popolo palestinese.
Oggi ci sono oltre 622.500 coloni israeliani che vivono in centinaia di insediamenti illegali in Cisgiordania, compresa Gerusalemme est. Questa impresa di colonizzazione ha avuto un impatto incredibilmente devastante sulla vita dei palestinesi in Cisgiordania. La terra palestinese è continuamente espropriata per le colonie e le loro infrastrutture, rinchiudendo i palestinesi in enclave sempre più piccole collegate da pochissime strade in pessimo stato.
Oltre a questo le colonie si impadroniscono delle migliori risorse della Cisgiordania, in particolare dell’acqua. Per decenni il regime israeliano ha sistematicamente scavato pozzi e ha bloccato l’acceso dei palestinesi alle sorgenti in Cisgiordania, mentre deviava nel contempo l’acqua per rifornire la propria popolazione, compresa quella che vive negli insediamenti illegali. Non è quindi sorprendente che le colonie illegali israeliane siano spesso definite il maggior ostacolo alla pace, anche dalle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU.
Mentre queste attività e la costante espansione del regime israeliano sulla terra palestinese sono continuamente condannate dalla comunità internazionale e dalle associazioni per i diritti umani, non ci sono state conseguenze e il regime israeliano deve ancora essere chiamato a risponderne. Tuttavia il Partnership for Peace Act va ben oltre la semplice mancata richiesta al regime israeliano di risponderne; esso fornisce deliberatamente una scappatoia per non vietare esplicitamente ai coloni degli insediamenti illegali di chiedere finanziamenti, incentivando quindi l’attività di colonizzazione e arricchendo i coloni.
Come detto in precedenza, la legge di bilancio USA proposta nel luglio 2020 dalla Camera dei Rappresentanti USA per l’anno fiscale 2020-2021 ha incluso provvedimenti per il Partnership for Peace Act. Le disposizioni impongono inoltre una serie di clausole per ricevere i finanziamenti, comprese restrizioni all’accesso per i palestinesi nel caso in cui l’ANP promuova un’inchiesta della Corte Penale Internazionale contro crimini di guerra di Israele. In particolare il testo include la seguente clausola:
Nessuno dei fondi stanziati sotto la voce “Fondo per il sostegno economico” di questa legge può essere messo a disposizione per assistenza all’Autorità Nazionale Palestinese se dopo la data di entrata in vigore di questa legge: (I) i palestinesi ottengono la stessa posizione di Stato membro o la piena adesione come Stato nelle Nazioni Unite o in qualunque loro specifica agenzia al di fuori di un accordo negoziato tra Israele e i palestinesi; o se i palestinesi promuovono un’indagine giuridicamente autorizzata della Corte Penale Internazionale (CPI), o appoggiano attivamente una simile indagine che sottoponga cittadini israeliani a un’inchiesta per presunti crimini contro i palestinesi.
Ciò è particolarmente significativo, considerando che nel febbraio 2021 l’ufficio della procura generale e la Camera Preliminare della Corte Penale internazionale (CPI) hanno stabilito che la Palestina ricade sotto la giurisdizione della CPI, consentendo quindi un’indagine per crimini di guerra contro Israele in Palestina. Meno di un mese dopo, nel marzo 2021, la procura ha annunciato l’apertura di un’inchiesta formale. Mentre ciò può essere festeggiato come una prima vittoria, molti ostacoli si prospettano ancora, compreso il fatto che l’ANP possa o meno essere convinta ad abbandonare l’inchiesta con la minaccia del ritiro dei finanziamenti.
Benché la CPI conserverebbe la giurisdizione anche se la ANP dovesse rinunciare a sostenere un’indagine e presentare denunce per crimini di guerra, ciò avrebbe un pesante impatto sulla causa. Infatti lascerebbe nelle mani di attori non statali, come le Ong per i diritti umani, la responsabilità di presentare denunce. Le denunce da parte di Stati hanno un peso politico maggiore, soprattutto nei confronti della CPI, che si basa molto sulla collaborazione degli Stati per condurre le proprie indagini.
È estremamente problematico il fatto che un ente finanziatore imponga simili limitazioni alla distribuzione dei propri fondi. Si deve quindi mettere in discussione la sincerità di ogni tentativo di “pace e riconciliazione” che limiti i finanziamenti in base al fatto che un popolo o, in questo caso, uno Stato persegua attraverso un’istituzione giudiziaria internazionale la richiesta di procedere in giudizio contro responsabili di crimini di guerra. Inoltre va notato che l’amministrazione Trump ha presentato clausole simili insieme all’“Accordo del Secolo”, che vietava alla dirigenza palestinese di ricorrere a un’indagine della CPI.
Clausole come queste, che politicizzano i finanziamenti incardinandoli a condizioni ingiuste, non solo sono dannose nel garantire i diritti fondamentali dei palestinesi, ma minano anche l’intero sistema della giustizia internazionale rafforzando l’impunità israeliana in quanto rinunciano a chiedere conto delle sue gravi violazioni del diritto internazionale. Il Partnership for Peace Act non è sicuramente una ragione di ottimismo, è uno strumento politico utilizzato contro i palestinesi che potrebbero cercare di utilizzare mezzi giudiziari affinché il regime israeliano sia chiamato a rispondere delle proprie continue sofferenze sotto l’occupazione israeliana. È una condanna a morte per i palestinesi che cercano giustizia attraverso i canali giudiziari formali del sistema internazionale.
Mettere in dubbio la falsa vernice di pace e riconciliazione
Questo articolo ha dimostrato come il Partnership for Peace Fund agisca all’interno di un quadro epistemico che pretende che la mancanza di collaborazione, di dialogo e di opportunità economiche per i palestinesi siano il principale ostacolo alla pace tra palestinesi e israeliani. Questo articolo ha anche dimostrato che ciò è semplicemente falso. Il principale ostacolo per “raggiungere la pace” sono le violazioni dei diritti dei palestinesi da parte del regime israeliano da oltre settant’anni, così come la continua colonizzazione della terra palestinese.
Tuttavia il fondo non è l’unico ad adottare questa narrazione. È l’ultimo esempio di una storia più lunga di iniziative P2P simili che tentano di minare i diritti fondamentali dei palestinesi attraverso una vernice di pace e riconciliazione.
Alla luce delle leggi emanate negli USA e della possibilità che leggi simili vengano emanate altrove, in particolare in Gran Bretagna e in Europa, è fondamentale che quanti appoggiano le leggi internazionali e i diritti dei palestinesi si oppongano con decisione a tali iniziative che minacciano il diritto internazionale e privilegiano una falsa vernice di dialogo e responsabilizzazione.
Come ha notato Omar Barghouti [co-fondatore del movimento BDS, ndtr.]:
“La lotta è innanzitutto per la libertà, la giustizia e l’autodeterminazione dell’oppresso…Solo attraverso la fine dell’oppressione ci può essere una vera potenzialità per quella che chiamo coesistenza etica, basata sulla giustizia e sulla piena uguaglianza per chiunque, non una coesistenza del tipo ‘padrone-schiavo’ che invocano molti nell’ ‘industria della pace’.”
L’impostazione P2P dovrebbe essere rifiutata in quanto inadeguata e problematica nel contesto palestinese e, in effetti, in ogni contesto di colonialismo d’insediamento definito da un notevole asimmetria di potere. Politici e legislatori dovrebbero invece appoggiare progetti e iniziative che si basino sui principi fondamentali delle leggi internazionali e sulla protezione dei diritti umani dei palestinesi invece che su quelli che li ignorano per promuovere il “dialogo”.
Infine, dovrebbero appoggiare i meccanismi esistenti che si oppongono all’espansionismo del colonialismo d’insediamento israeliano e dell’occupazione militare. Ciò include il divieto di importazione nei mercati internazionali dei prodotti delle colonie illegali o di investimenti da istituzioni e imprese complici delle violazioni dei diritti umani da parte di Israele. In ultima analisi Israele sarà chiamato realmente a pagare le conseguenze delle sue azioni con l’applicazione di sanzioni internazionali. Infatti obbligarlo a risponderne è l’unico cammino attraverso il quale ottenere una pace giusta.
Yara Hawari
Yara Hawari è analista esperta di Al-Shabaka: La Rete Politica Palestinese. Ha ottenuto un dottorato in Politiche del Medio Oriente presso l’università di Exeter, dove ha insegnato in vari corsi di post-grado e continua ad essere ricercatrice onoraria. In aggiunta al suo lavoro accademico centrato su storia indigena e storia orale, è anche una assidua commentatrice che scrive su vari mezzi di comunicazione, tra cui The Guardian, Foreign Policy e Al Jazeera in inglese.
(traduzione dall’inglese di Amedeo Rossi)