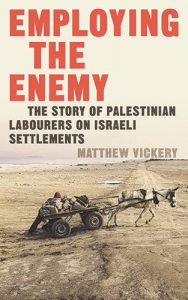|
Poche, fra le questioni oggi aperte sul piano internazionale, sono così semplici dal punto di vista giuridico, storico, morale, come quella palestinese, e poche appaiono invece così difficili a risolvere sul piano pratico.
Dal primo punto di vista non mi pare seriamente contestabile il buon diritto dei palestinesi che rivendicano il principio dell’autodeterminazione né seriamente difendibile la posizione di Israele, giustamente condannata ormai da decine di risoluzioni dell’ONU e dell’UNESCO; eppure ancor oggi la maggioranza della pubblica opinione occidentale – sia pure una maggioranza che tende lentamente a diminuire – sembra convinta del buon diritto d’Israele e ne accetta acriticamente la politica di forza. Quali ne sono le ragioni?In primo luogo l’affinità culturale. I primi ebrei immigrati in Palestina provenivano dall’Europa, cacciati dalle persecuzioni che vi subivano, ed europea è stata anche la prevalente colonizzazione successiva fino alla creazione dello stato di Israele. Europea comunque è la classe dirigente, proveniente in gran parte da territori dell’ex-impero zarista, ed europea la cultura, ciò che crea una profonda affinità di idee, di modo di pensare, di mentalità, di linguaggio. Viceversa gli arabi rimangono ancora per molti europei, ammalati di eurocentrismo, un popolo inferiore, coloniale, di cui si dimentica volentieri il contributo straordinario fornito nel corso dei secoli al progresso soprattutto scientifico dell’umanità. Perciò nel subcosciente di milioni di occidentali Israele, testa di ponte europea nel mondo arabo, soddisfa il complesso di superiorità e le ambizioni egemoniche che una volta trovavano piena soddisfazione negli imperi coloniali.
A ciò si deve aggiungere anche la presenza di molti ebrei sparsi ovunque in Occidente – e spesso in posizioni di autorità e di prestigio – che, nella quasi totalità, sono dei sostenitori di Israele, sovente anche dei propagandisti, mentre non c’è nulla di simile da parte araba. In alcuni casi, come particolarmente negli Stati Uniti, la presenza ebraica è così massiccia e così potente da poter influire decisamente sulle scelte politiche e sugli indirizzi della stampa, orientando tutta l’opinione del paese. E d’altra parte poiché l’opinione pubblica americana è abituata a una politica internazionale basata sul diritto del più forte, non trova nulla di scandaloso nel fatto che lo stesso criterio guidi la politica israeliana. E questi orientamenti americani, data la posizione egemonica degli USA nel mondo occidentale, sono poi facilmente ricevuti e accettati anche dall’opinione europea. Non ultimo motivo, infine, di questa propensione proisraeliana è il desiderio di liberarsi da complessi di colpa per le persecuzioni di cui per secoli la minoranza ebraica è stata fatta oggetto in Europa, ad opera della Chiesa cattolica e di varie monarchie cristianissime, nonché ad opera dei governi zaristi e, da ultimo, dei nazisti che hanno fatto della popolazione ebraica d’Europa un popolo martire per eccellenza. Ma è un curioso modo di liberarsi dai rimorsi per i torti fatti a un popolo quello di sacrificarne un altro. È di questo curioso modo, e del suo fondamento, che vorrei discorrere in termini obiettivi, convinto che la verità anche in questo caso serva la causa della pace e, quindi, la causa della stessa popolazione ebraica trapiantata in Palestina.
I titoli rivendicati dagli Ebrei sul territorio palestinese
Esisteva un diritto degli ebrei sul territorio palestinese? Evidentemente non può avere nessun senso sul piano internazionale l’argomento religioso della Terra Promessa, e non mette neppur conto di indagare sull’obiezione, che spesso viene mossa a questo argomento, e cioè che non esiste alcuna prova che gli ebrei che oggi vivono in Israele siano realmente i discendenti degli ebrei cui la promessa sarebbe stata fatta. Diciamo che non mette conto di indagare perché, se anche lo fossero, essi non possono certamente pretendere che la loro credenza religiosa, che la maggioranza dell’umanità non accetta, costituisca un titolo valido per occupare terre altrui.
Neppure può essere seriamente invocato l’argomento storico del fatto che la Palestina è stata per secoli la terra abitata dagli ebrei. A parte l’obiezione già avanzata più sopra sulla impossibilità di dimostrare che gli attuali israeliani siano i discendenti di quei lontani abitatori della Palestina e a parte la considerazione che la Palestina era abitata da altre popolazioni, prima che dagli Ebrei, che vi entrarono con la forza secondo quanto racconta la stessa Bibbia; a parte la considerazione che nessuno è in grado di stabilire se fra le popolazioni che hanno abitato la Palestina prima o contemporaneamente agli Ebrei non vi fossero anche antenati delle attuali popolazioni arabe, rimane l’obiezione fondamentale che gli Ebrei furono cacciati dalla Palestina 19 secoli fa e che 19 secoli di storia sono fonte di nuovi diritti che non possono essere annullati. In proposito un grande pensatore ebreo, Erich Fromm, ha pronunciato un giudizio al quale non possiamo non associarci: “La pretesa degli Ebrei sulla terra di Israele, quindi, non può essere pretesa politica realistica. Se, improvvisamente, tutti i paesi rivendicassero i territori dove i loro antenati sono vissuti duemila anni or sono, il mondo diventerebbe un manicomio”.
Vediamo allora se vi sono titoli validi più recenti, e in particolare esaminiamo la Dichiarazione Balfour e la risoluzione del 29 novembre 1947 dell’Assemblea dell’ONU sulla spartizione della Palestina. Per quanto riguarda la prima, è ovvio che essa non è che una dichiarazione unilaterale di intenzioni che non poteva creare situazioni giuridiche nuove, tanto più che, nel momento in cui fu fatta, l’Inghilterra non aveva alcun diritto di sovranità sulla Palestina, facente allora parte integrante dell’impero ottomanno e solo militarmente occupata da truppe britanniche. Ma è noto che l’occupazione militare di territori in tempo di guerra non attribuisce alcun diritto di sovranità e tanto meno la libertà di disporne. Ora fu solo con il Trattato di pace di Losanna del 1923 che la Turchia rinunciò ai suoi diritti sovrani su quel territorio. La stessa commissione reale inglese che esaminò il problema nel 1939 concluse che “secondo il parere della Commissione, è tuttavia evidente (…) che il governo di Sua Maestà non era libero di disporre della Palestina senza tener conto della volontà e degli interessi dei suoi abitanti”.
È bensì vero che la Dichiarazione Balfour fu fatta propria dalla Società delle Nazioni e inclusa nel Preambolo del mandato conferito all’Inghilterra sulla Palestina (peraltro in contraddizione con l’art. 22 dello stesso Patto della Società delle Nazioni), ma è chiaro in ogni caso – come ebbe ad affermare allora lo stesso Winston Churchill, che era ministro all’epoca della Dichiarazione – che questa non attribuiva la Palestina agli Ebrei, ma semplicemente stabiliva che una sede nazionale ebraica avrebbe potuto essere creata in Palestina, senza pregiudizio dei diritti dei suoi abitanti. Nulla più di questo può essere pertanto dedotto da quella dichiarazione.
Quanto alla risoluzione dell’ONU, che ha istituito lo Stato di Israele accanto a uno Stato arabo di Palestina, vale innanzi tutto lo stesso argomento che neppure l’ONU aveva la sovranità su quel territorio e che in nessun caso avrebbe potuto disporne violando il principio fondamentale dell’autodeterminazione del popolo. Di questa carenza di potestà l’ONU ebbe certamente coscienza perché respinse la proposta di interpellare in proposito la Corte di giustizia dell’Aia, che pure è un suo organo, con soli 25 voti su 54 (18 favorevoli e 11 astenuti), e respinse la contestazione della propria competenza con appena 21 voti su 54 (20 favorevoli e 13 astenuti).Del resto questa carenza assoluta di potere da parte dell’ONU di disporre delle sorti di un popolo risulta chiara non solo dal fatto che lo statuto non lo prevede, ma anche dalla considerazione che tutto lo spirito che ha presieduto alla creazione dell’ONU era proprio quello di por fine alla diplomazia della prepotenza – di cui Hitler era stato l’incarnazione – che trattava i popoli come oggetti.
Fin dalla prima guerra mondiale il presidente Wilson aveva proclamato alcuni principi fondamentali la cui realizzazione, a base dell’ordine internazionale, doveva costituire lo scopo di guerra degli Stati Uniti, e il dovere degli alleati vittoriosi. Fra questi principi, indicati nei quattordici punti e nelle quattro proposte complementari, uno suonava: “I popoli e le provincie non devono costituire oggetto di mercato e passare di sovranità in sovranità, come se fossero semplici oggetti o semplici pedine di un giuoco, sia pure del grande giuoco, ora screditato per sempre, dell’equilibrio delle forze”.
Esso veniva poi ribadito in maniera ancor più precisa dallo stesso presidente Wilson il 4 luglio 1918 con queste parole: “La sistemazione di ogni questione di territorio, di sovranità economica o politica, deve essere basata sulla libera accettazione da parte dei popoli interessati e non sugli interessi materiali o sul tornaconto di qualsiasi altra nazione o popolo che desideri una sistemazione diversa per imporre la propria influenza o il proprio dominio”.
Se comunque si volesse prendere come base giuridica valida la delibera dell’ONU, si dovrebbe considerare che essa prevedeva la creazione di due stati palestinesi, uno ebraico e uno arabo, e in più la garanzia dei diritti della popolazione araba, il divieto di discriminazioni, ecc., e che le varie parti della risoluzione costituiscono un tutt’uno.
Non credo pertanto che si possa parlare di una legittimità giuridica nascente dalla risoluzione di spartizione: del resto gli stessi israeliani lo hanno riconosciuto parlando del loro Stato come fondato sul diritto della forza. È questa anche la nostra opinione: anche il fatto compiuto crea situazioni nuove da cui nascono nuovi rapporti giuridici. Quando uno Stato esiste da circa trent’anni, riconosciuto dalla quasi universalità degli Stati e membro dell’ONU, non è più possibile contestarne la legittimità, anche se questa legittimità si basa sull’uso della forza. È questa la legittimità di Israele, ma poiché siamo in presenza di un uso della forza continuato, diretto ad allargare il territorio occupato, è forse opportuno vedere se possa attribuirsi eguale legittimità a tutte le diverse tappe dell’occupazione, o, in altre parole, quali debbano considerarsi territori su cui potrebbero esercitarsi i diritti di autodeterminazione del popolo palestinese.
È evidente che all’occupazione di territori effettuata con la forza nella guerra del 1967 non può essere attribuita validità alcuna perché gli altri paesi non l’hanno riconosciuta e il Consiglio di sicurezza dell’ONU l’ha condannata con la famosa risoluzione 242 del 22 novembre 1967. Questa risoluzione è stata approvata anche dagli Stati Uniti, che tuttavia si sono sforzati di introdurvi elementi di ambiguità per favorirne il non-rispetto da parte di Israele. Ben diverso era stato l’atteggiamento del presidente Eisenhower dieci anni prima, quando, dopo l’aggressione israeliana del ’56, aveva obbligato Israele ad evacuare i territori arbitrariamente occupati. “Forse che – aveva detto Eisenhower in quell’occasione – una nazione che attacca e s’impadronisce di territori stranieri, nonostante la disapprovazione delle Nazioni Unite, può pretendere d’imporre essa stessa le condizioni della sua evacuazione? Se dicessimo di sì, temo che avremmo fatto un passo indietro nell’ordine internazionale”. Fu appunto la fermezza di Eisenhower che obbligò Israele a sgombrare il Sinai e la striscia di Gaza. Purtroppo la stessa fermezza non si ripeté dopo la guerra del ’67, ché anzi gli Stati Uniti, pur votando la risoluzione 242, si adoperarono perché non fosse applicata. Il lobby israeliano, cui non mancano mezzi di agire, aveva nel frattempo lavorato molto bene.
L’espansionismo israeliano e i Palestinesi
Sono così passati trent’anni dalla risoluzione dell’ONU sulla spartizione della Palestina, e il popolo palestinese, dopo l’ingiustizia di quella prima risoluzione che lo spogliava senza consultarlo di metà del suo territorio, ha subìto quella ancor più pesante di vedersi privato anche del diritto di costituire questo Stato di dimensioni ridotte.
Si obietta spesso, da parte israeliana, che la risoluzione dell’ONU sulla spartizione fu accettata da Israele ma non dagli Stati arabi né dai palestinesi, e che pertanto essa non avrebbe più valore. Ma le cose non stanno veramente così. Quanto ai palestinesi, essi non avevano ancora una propria autonomia giuridica come Stato e non avrebbero potuto esprimere immediatamente una loro volontà, ma avevano il diritto di essere tempestivamente consultati per esprimere questa volontà. Invece non lo furono né prima che la spartizione fosse decisa, né subito dopo. Il territorio che l’ONU aveva assegnato al costituendo Stato arabo di Palestina fu immediatamente invaso da Israele e dagli Stati arabi confinanti che su quel territorio combatterono la prima delle loro guerre, quella del 1948.L’occupazione da parte di Israele di territori che il piano di spartizione assegnava allo Stato arabo aveva avuto già inizio ancor prima della cessazione del mandato e dello sgombero britannico, prima dunque della proclamazione dello Stato di Israele, prima che scoppiasse la guerra del 1948. In quel periodo gli ebrei si impadronirono con la forza di città importanti come Jaffa e Acri lungo la costa e avanzarono verso Gerusalemme, occupando nella zona che il piano riservava all’internazionalizzazione il villaggio di Deir Yassin (9 aprile 1948) dove fu interamente massacrata la popolazione civile: un atto probabilmente premeditato che ebbe influenza determinante nel provocare la fuga della popolazione araba terrorizzata. Poco dopo scoppiò la prima guerra con i paesi arabi, e Israele ne approfittò per impadronirsi con la forza di altri territori compresi nella zona riservata allo Stato arabo, che fu ulteriormente ridotta, ma il possesso definitivo di queste terre non fu mai riconosciuto a Israele dai successivi accordi armistiziali, che definirono la linea di “cessate il fuoco” come una linea puramente militare, senza alcun carattere di frontiera politica fra Stati. Ma anche dopo la firma dell’armistizio (il 24 febbraio 1949 con l’Egitto, il 23 marzo con il Libano, il 3 aprile con la Giordania e il 20 luglio con la Siria), Israele continuò ad avanzare con la forza, in spregio agli impegni assunti con gli accordi stessi ed avallati dall’ONU: il 10 marzo 1949, due settimane dopo la firma dell’armistizio con l’Egitto, truppe israeliane attaccarono la parte meridionale del Negev – territorio egiziano -, si spinsero fino al golfo di Akaba, da cui furono espulsi gli abitanti arabi. Sull’antico villaggio arabo gli israeliani costruirono il porto di Eilath, sebbene l’accordo generale di armistizio stipulasse, al suo articolo IV: “È riconosciuto il principio che nessun vantaggio militare o politico deve essere conseguito durante la tregua ordinata dal Consiglio di Sicurezza”. È particolarmente importante mettere in rilievo l’assoluta illegittimità di questa occupazione, perché l’aggressione israeliana del 1967 fu giustificata soprattutto con la necessità di mantenere aperto lo stretto di Tirian, che dà accesso precisamente al golfo di Akaba e quindi al porto di Eilath: in altre parole l’aggressione, che aveva permesso agli israeliani di insediarsi illegittimamente sul golfo e di costruirvi un porto, diventava motivo di legittimazione per una nuova aggressione e per la conseguente occupazione di Sharm al Sheikh. E come tutti sanno, la guerra del 1967 ha permesso agli israeliani di estendere ulteriormente l’occupazione abusiva di altri territori, che dovrebbero costituire lo Stato palestinese, dove, nonostante le ripetute risoluzioni dell’ONU gli israeliani non solo continuano a rimanere, ma continuano a stabilire nuovi illegittimi insediamenti.
Questa politica di Israele indica chiaramente una volontà espansionistica permanente, in assoluto contrasto sia con la risoluzione del 1947 sia con le successive decisioni dell’ONU: anche se Israele non lo riconosce apertamente, è evidente che non ha rinunciato a costruire a poco a poco uno Stato ebraico dall’Eufrate al Nilo, secondo un progetto sionista di antica data. D’altra parte, finché Israele mantiene il suo proposito di far affluire nel suo territorio l’intera popolazione ebraica del globo, che è parecchie volte più numerosa di quella che attualmente vi abita, è chiaro che questa affluenza presupporrebbe una moltiplicazione del territorio corrispondente alla moltiplicazione della popolazione. Perciò se Israele ha titolo a reclamare frontiere sicure contro le minacce – che sono risultate essere dei semplici bluff propagandistici – di veder ricacciata in mare la popolazione ebraica, tanto maggior diritto a una garanzia delle frontiere hanno i paesi arabi, che hanno subìto tutta una serie di aggressioni e hanno assistito a un’espansione continua di Israele ben al di là delle frontiere originarie stabilite dall’ONU e che vedono tuttora pendere su di loro la minaccia di un’ulteriore espansione.
L’attuale posizione giuridica di Israele
Sulla base di queste premesse di fatto, come si presenta ora la questione palestinese? Dal punto di vista del diritto internazionale non possono esistere dubbi: Israele deve sgombrare i territori arbitrariamente occupati nel 1967 e su una parte di essi, cioè sul territorio cisgiordano e sulla striscia di Gaza, deve nascere lo Stato arabo palestinese.
Il primo punto non sembra poter dar luogo a contestazioni serie, essendo esso la conseguenza del principio generale, che è fondamento sia del diritto internazionale sia, in particolare, dello statuto dell’ONU, che non possono essere occupati territori di altri Stati con la forza. In particolare questo principio è stato riaffermato con la risoluzione 242 già richiamata e con una serie numerosa di altre risoluzioni successive.
È noto che Israele ha sempre potuto contare all’ONU sulla protezione degli Stati Uniti, che sono arrivati a mettere il veto su una serie di risoluzioni del Consiglio di Sicurezza che avevano il generale consenso. Ricordiamo la risoluzione del 10 settembre 1972 che condannava Israele per i suoi raids sui campi di rifugiati palestinesi in Libano e Siria; quella dell’8 dicembre 1975 che condannava severamente Israele per i suoi raids sui campi di rifugiati in Libano che avevano fatto numerose vittime innocenti; quella del 26 gennaio 1976 che affermava il diritto inalienabile dei Palestinesi all’autodeterminazione, il diritto dei rifugiati palestinesi al rimpatrio o alle riparazioni, e la necessità di garantire la sovranità di tutti gli stati della regione; quella del 25 marzo 1976 che condannava Israele per le sue attività a Gerusalemme e nei territori occupati, ecc. Quest’atteggiamento degli Stati Uniti, che è in palese contrasto con le dichiarazioni di Ford alla conferenza di Helsinki dove ha proclamato “la devozione profonda del popolo americano e del suo governo ai diritti dell’uomo e alle libertà fondamentali”, è stata spesso criticata da autorevoli personalità americane: il senatore William Fullbright, che fu per molti anni il presidente della Commissione degli affari esteri del Senato, ha detto: “Non siamo obbligati ad appoggiare Israele nella sua ostinazione a occupare terre arabe, compresa la vecchia Gerusalemme e la riva sinistra palestinese … Forse il diritto dei Palestinesi di rientrare nella loro patria, da cui sono stati cacciati, è meno fondamentale del diritto degli ebrei sovietici di stabilirsi in un paese nuovo?”.
Tuttavia, se gli Stati Uniti hanno potuto bloccare con il veto alcune risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, non hanno osato opporre un veto alla risoluzione 242 e ad altre che ordinavano a Israele di sgombrare i territori arbitrariamente occupati, e non hanno potuto bloccare – perché lo statuto non lo consente – le risoluzioni dell’Assemblea che ogni anno hanno rinnovato la condanna di Israele per l’occupazione arbitraria, per gli abusi commessi nei territori occupati, per le violazioni dei diritti dell’uomo a danno degli arabi, ecc. Si obietta talvolta che le risoluzioni dell’Assemblea non hanno valore vincolante, ma si dimentica che questa regola non è applicabile a Israele, perché Israele – unico fra tutti gli Stati – è stato ammesso all’ONU con l’esplicita condizione, da esso accettata, di attenersi alle risoluzioni dell’ONU. Si è trattato di una procedura speciale, usata solo in questo caso, e cioè un’ammissione condizionale e dopo lungo interrogatorio nella Commissione ad hoc sull’atteggiamento di Israele di fronte alle decisioni dell’ONU. In quella sede, il rappresentante di Israele, Abba Eban, dichiarò che se Israele fosse stata ammessa all’ONU, essa avrebbe contribuito ad accrescere la forza morale vincolante delle sue risoluzioni; a differenza degli arabi, aggiunse, Israele “non accetta la teoria (…) che le risoluzioni dell’Assemblea siano opzionali e che si possa sbarazzarsene a volontà”. È opportuno richiamare quest’impegno, la cui assunzione fu condizione di ammissione, proprio nel momento in cui Israele è lo stato che più di ogni altro ha sistematicamente disatteso le risoluzioni dell’ONU.
La situazione giuridica dei Palestinesi
Qual è oggi la situazione giuridica dei palestinesi?Dopo la risoluzione del 1947, e dopo la dispersione di larga parte del popolo palestinese a seguito della guerra del ’48, dopo l’occupazione del territorio dell’istituendo Stato da parte di Israele, Giordania ed Egitto, ci vollero molti anni prima che il popolo palestinese potesse darsi una struttura organizzata che gli consentisse di far sentire la sua voce nei consessi internazionali. Ciò è avvenuto solo nel 1964 con la costituzione dell’Organizzazione per la Liberazione della Palestina (OLP), la quale è ormai ufficialmente riconosciuta come legittima rappresentante del popolo palestinese. I momenti più significativi di questo riconoscimento sono stati la conferenza di Rabat e l’invito dell’ONU ad Arafat: nella prima tutti gli Stati arabi, compresi quelli che avevano occupato i territori palestinesi, cioè Giordania ed Egitto, hanno riconosciuto il diritto del popolo palestinese a creare uno Stato indipendente sul territorio palestinese occupato da Israele nel 1967 e hanno riconosciuto all’OLP la legittima rappresentanza del popolo palestinese.
Quanto all’ONU, essa ha proclamato sempre il diritto all’autodeterminazione dei popoli, e lo ha precisato in un testo fondamentale: la risoluzione 1614 (XVI) dell’Assemblea generale del 14 dicembre 1960 sulla concessione dell’indipendenza ai paesi e ai popoli coloniali ha affermato testualmente che “tutti i popoli hanno un diritto inalienabile alla piena libertà, all’esercizio della loro sovranità”, e ha ribadito nelle conclusioni il diritto dei popoli a non sottostare a dominazione alcuna (“Tutti i popoli hanno il diritto di libera determinazione; in virtù di questo diritto essi determinano liberamente il loro statuto politico e perseguono liberamente il loro sviluppo economico, sociale e culturale”). Nessuno oggi contesta che questo principio sia diventato una norma vincolante di diritto: lo prova del resto il fatto che, attraverso la decolonizzazione, esso ha ormai ricevuto applicazione pressoché universale.
È vero che la delibera 242 del Consiglio di sicurezza non parve tenerne conto perché la formula di compromesso, che si dovette accettare per evitare il veto statunitense, parlava dei palestinesi come di “rifugiati”, ma a questa carenza l’ONU ha posto rimedio con una serie successiva di deliberazioni, fra cui quella dell’Assemblea dell’8 dicembre 1970, che riconoscevano il diritto del popolo palestinese a costituire uno stato indipendente sui territori che Israele deve sgombrare. In questo senso si è pronunciata anche la Comunità Economica Europea, e specificatamente, a più riprese, anche il governo italiano. Il fatto che Israele abbia continuato a rifiutarsi di adempiere ai suoi obblighi e abbia mantenuto l’occupazione arbitraria non modifica la situazione di diritto, anche se mantiene una situazione di fatto totalmente antigiuridica.
L’ONU poi, invitando Arafat a parlare alla tribuna dell’assemblea, e ammettendo un osservatore dell’OLP al Consiglio stesso di sicurezza, ha attribuito all’OLP lo status di rappresentante legittima del popolo palestinese.
La pretesa israeliana di non riconoscere l’OLP, accusandola addirittura di essere soltanto un’organizzazione terroristica, è chiaramente destituita di qualsiasi fondamento giuridico e anche di qualsiasi elemento di fatto. Certo ci fu un tempo in cui le organizzazioni ufficiali palestinesi sostenevano doversi ricacciare in mare gli ebrei e difendevano tutti gli atti di terrorismo ovunque compiuti. Questo tempo è passato. Da anni ormai l’OLP condanna gli atti terroristici compiuti da arabi fuori del territorio di Israele e ha punito essa stessa dei terroristi. Diverso naturalmente è l’atteggiamento per quanto riguarda atti compiuti sul territorio di Israele, cioè sul territorio dello Stato oppressore. Qui si tratta di guerriglia e la guerriglia è l’arma universalmente applicata in questi casi: non solo in Vietnam, in Algeria o nelle colonie portoghesi, per non parlare che dei casi più famosi, ma anche in Italia e negli altri paesi occupati dai nazisti, i popoli si sono difesi ricorrendo alla guerriglia. Comunque gli israeliani sarebbero gli ultimi a poter protestare contro il terrorismo, perché è noto che gli ebrei sono penetrati in Palestina con il terrorismo: la storia della colonizzazione ebraica in Medio Oriente è la storia del terrorismo ebraico contro arabi e inglesi. Le organizzazioni che l’hanno praticato (Hagana, Irgun, e Stern) sono celebrate come eroiche e diversi fra i dirigenti di queste organizzazioni, che avevano compiuto alcune fra le più gravi azioni terroristiche, sono diventati ministri o hanno occupato altre importanti cariche nello Stato. E d’altra parte non sono azioni terroristiche le ingiustificate rappresaglie massicciamente e spietatamente condotte dall’aviazione israeliana contro i campi di rifugiati?
I diritti dei palestinesi non si esauriscono però nel diritto alla creazione di uno Stato che costituisca la patria di questo popolo travagliato. Ci sono altri diritti che riguardano sia i palestinesi che vivono in Israele o in territori occupati da Israele che quelli che vivono in campi di rifugiati o, comunque, fuori dalla Palestina.
Per quanto riguarda i palestinesi che vivono entro i confini internazionalmente riconosciuti di Israele, il diritto principale è quello di essere trattati come cittadini di pieno diritto, senza discriminazioni, di avere scuole arabe con gli stessi diritti delle scuole ebraiche, di veder riconosciuto il diritto all’uso della lingua araba anche in sede ufficiale. In altre parole, come ogni altra minoranza etnica, linguistica o religiosa, gli arabi hanno diritto a vedere rispettata la loro identità nazionale, le loro pratiche religiose nonché l’insegnamento e l’uso della lingua. In uno Stato binazionale non possono sussistere né discriminazioni né privilegi, perché discriminazioni a carico di una parte e privilegi a favore dell’altra significherebbero una manifestazione di razzismo, condannato da tutta la gente civile.
Per quanto riguarda i territori occupati arbitrariamente, vale il principio generale che l’occupante non ha e non può esercitare diritti sovrani, non può alterare le forme di vita locale, insediando altre popolazioni o cacciando i legittimi abitanti, alterando il paesaggio, distruggendo abitazioni, luoghi di culto, ecc. Purtroppo tutto ciò è avvenuto largamente nei territori occupati, donde le ripetute condanne pronunciate dall’UNESCO.
Infine, per quanto riguarda i palestinesi che vivono fuori della Palestina, dev’essere riconosciuto il diritto di ritornare e di riottenere le proprietà confiscate, oppure di avere un adeguato indennizzo: diritto questo che spetta anche ai palestinesi che vivono in Israele e che sono stati espropriati. Ultimo, ma più importante diritto, è il diritto alla vita, che Israele nega con i bombardamenti sistematici sui campi dei profughi, sotto pretesto di esercitare un diritto di rappresaglia che non è ammesso dalle norme internazionali. La pretesa di Israele che i profughi palestinesi siano condannati a rimanere eternamente dei profughi, senza poter recuperare una patria, nasconde forse il proposito di massacrarli lentamente nei campi di rifugiati.
La situazione di fatto
Fin qui abbiamo esaminato i principali aspetti giuridici della questione palestinese; ma quale è la situazione di fatto?
Teoricamente dovrebbe tenersi a Ginevra una conferenza della pace cui dovrebbero partecipare tutte le parti interessate, sotto la copresidenza degli Stati Uniti e dell’URSS. In realtà Israele ha sollevato finora una serie di difficoltà pregiudiziali per rimandare la conferenza, nell’attesa della quale non solo continua a occupare i territori che dovrebbe rendere ma vi sviluppa una politica d’insediamento di colonie ebraiche in aperto contrasto con le norme di diritto internazionale e con le decisioni dell’ONU.
Il ritardo nell’avviare serie trattative di pace è stato favorito apertamente da Kissinger, che ha potuto così giocare sulla sua diplomazia dei piccoli passi, svolgendo un ruolo molto ambiguo nel Medio Oriente. In sostanza mi pare fuori di dubbio che la guerra civile in Libano e il successivo intervento siriano in appoggio alle forze cristiane di destra, contro i palestinesi e contro i progressisti libanesi, siano stati concordati con Washington e con Israele. Kissinger ha giocato la carta dell’arabizzazione del conflitto, come in Vietnam aveva giocato quella della vietnamizzazione: ottenere cioè che arabi combattano contro arabi come vietnamiti avevano combattuto contro vietnamiti e come pure in Angola tentò di mobilitare angolani (sia pure rafforzati da mercenari) contro il movimento di liberazione dell’Angola. È probabile che l’evoluzione della situazione abbia agevolato una pace diplomatica fra Israele e gli Stati arabi: se questa tuttavia dovesse realizzarsi ai danni del popolo palestinese, che fosse privato del suo diritto di avere un proprio Stato indipendente, potrebbe risultare una pace precaria e pericolosa.
Mi auguro che i dirigenti arabi, soprattutto egiziani e siriani, e i dirigenti israeliani abbiano sufficiente senso storico per rendersi conto che tutte le soluzioni tentate per fermare il movimento reale della storia (in questo caso il movimento di un popolo verso l’indipendenza) servono solo a protrarre l’inquietudine e, in ultima analisi, a provocare nuove guerre. Mi auguro soprattutto che i governanti di Israele si rendano conto che difficilmente potranno trovare un momento storico più favorevole per una soluzione definitiva che allontani minacce e pericoli. È chiaro che ormai non solo gli Stati arabi, ma lo stesso movimento palestinese sono pronti a riconoscere lo State di Israele, anche se non si può pretendere di farne una pregiudiziale alle trattative: il riconoscimento dovrà essere il risultato della trattativa, insieme però con la rinuncia definitiva di Israele ad ulteriori tentativi di aggressione e di espansione e quindi con la garanzia delle frontiere. E fra queste frontiere devono essere comprese anche quelle dello Stato arabo palestinese, che sarà necessariamente più piccolo di quello previsto dall’ONU nel 1947.
Credo che una soluzione di questa natura è la sola che possa dare finalmente pace e tranquillità al Medio Oriente, e, in particolare, allo Stato di Israele che commetterebbe una follia se scegliesse la strada di una ulteriore tensione, necessariamente destinata ad aggravarsi, che rischierebbe di portarlo alla perdizione. Nessun uomo di buon senso, soprattutto se si è trovato ad aiutare gli ebrei nei momenti delle feroci persecuzioni, può desiderare che Israele rischi di essere distrutto da una guerra futura, ma nessun uomo di buon senso può pensare che i milioni di ebrei assassinati dai nazisti siano morti perché i loro correligionari si facessero a loro volta promotori dell’oppressione e della persecuzione di un altro popolo. Il modo migliore di onorare le vittime del nazismo è di lottare perché non ci siano più popoli eletti e popoli inferiori.
|