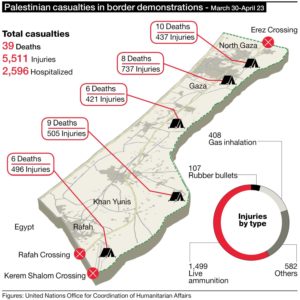Storie della catastrofe: Palestina
Rami Almeghari, Mohammed Asad e Anne Paq
16 maggio 2018, Electronic Intifada
Settant’anni fa i palestinesi hanno subito la Nakba, o catastrofe, quanto la maggioranza di loro lasciò o fu obbligata dalle milizie sioniste a lasciare la Palestina per far posto alla creazione dello Stato di Israele e garantire una maggioranza ebraica. Circa 750.000 persone finirono per diventare profughi registrati dalle Nazioni Unite. Molti altri se la cavarono da soli. Non gli venne mai consentito di tornare alle loro terre o case, che vennero confiscate dal nascente Stato, e molti dei loro villaggi vennero successivamente distrutti. Qui alcuni sopravvissuti raccontano le loro storie.
Khoury Bolous, 84 anni, di Haifa. Originariamente di Iqrit, nei pressi del confine con il Libano.
Iqrit era un piccolo villaggio cristiano di circa 500 abitanti molto vicino alla frontiera della Palestina con il Libano. Il villaggio subì la pulizia etnica nel 1948 e venne distrutto nel 1951, tranne la chiesa. I suoi abitanti divennero sfollati interni – quello che Israele definì “presenti assenti”
Eravamo contenti. Avevamo fichi, hummus e ulivi. Seminavamo di tutto, tranne zucchero e riso. Mio padre aveva molta terra, circa 100 dunum [10 ettari, ndt.]. Facevamo la farina, coltivavamo lenticchie e fagioli, ogni tipo di verdure e olive. L’unica cosa che mio padre comprava era il tabacco. Morì quando ero molto giovane, e mio fratello maggiore prese il suo posto. La nostra casa era fatta di grandi pietre ed era stata costruita da mio nonno.
Nel 1948 non ci fu resistenza nel villaggio. Le forze sioniste entrarono nel villaggio e alzammo bandiera bianca. Non avevamo armi. Ci dissero di andarcene ad al-Rama, che sarebbe stato solo per due settimane e che era solo per la nostra sicurezza. Venimmo trasportati da camion militari. Ma io non andai insieme agli altri. Mio fratello mi disse di andare in Libano a Qouzah, da nostra zia, per salvare gli animali. Camminai verso il Libano con 5 mucche, un cammello, un asino e un cavallo. Attesi il messaggio che mio fratello avrebbe dovuto mandarmi quando fossero tornati a Iqrit, ma il messaggio non arrivò mai.
Dopo un mese sentii dire che alcune persone stavano andando a Iqrit per raccogliere frutta e così decisi di andare. Avevo paura di attraversare la frontiera ma lo feci. Non era rimasto niente nella nostra casa, tutto era stato rubato. Persone che incontrai mi dissero che non sarei riuscito ad arrivare ad al-Rama, così tornai in Libano e vi rimasi per due anni. Poi incontrai un passeur, Alì, e con un gruppo partimmo di notte per la Palestina. Avevamo paura, era pericoloso. Alla fine all’alba, vicino ad al-Rama, continuai da solo attraverso i campi. Quando raggiunsi il villaggio, vidi qualcuno di Iqrit che mi portò dalla mia famiglia. Non potevano credere che fossi riuscito a fare una cosa simile. Non ci potevo credere neppure io.
Un Natale sentimmo che Iqrit era stato totalmente distrutto. Il mukhtar [capo villaggio, ndt.] ed altri erano andati su una collina di fronte al villaggio e confermarono la notizia. Era un disastro sentire questa notizia. Volevano uccidere ogni nostra speranza di tornare. Ma non ci riuscirono.
Alla fine ebbi un permesso ed iniziai a lavorare come macellaio ad Haifa. Mi sposai nel 1960 ed andai ad Haifa. Tornavamo spesso a Iqrit, dormendo nella chiesa. Fui arrestato alcune volte per essere stato lì. Ci portavamo i bambini per le vacanze.
Siamo come i rifugiati. Quello che abbiamo in comune è la speranza del ritorno. Vogliamo solo andare a casa, questo è un nostro diritto fondamentale. Voglio tornare e costruire una piccola casa.
Reportage di Anne Paq
Saed Hussein Ahmad al-Haj, 85 anni, campo di rifugiati di Balata, nella città di Nablus della Cisgiordania occupata. Originario di al-Tira, nei pressi di Ramla.
Sono stato fortunato rispetto ad altri profughi. Ho avuto successo nel lavoro ed ho tre macellerie. Ho dei figli. Ma è sempre mancato qualcosa. Mi sono sempre dato da fare, ma non c’è una vera allegria perché non vivo nella casa in cui sono nato.
Il mio villaggio era noto soprattutto per le sue greggi e per i suoi prodotti. Era un piccolo villaggio, circa 2.000 abitanti. All’epoca la nostra vita era semplice. La scuola era così precaria che ci sedevamo sul pavimento. Ho passato la mia vita giocando all’aperto con i vicini.
Mio padre commerciava pecore e mucche. Vendeva anche il latte. Avevamo una piccola casa fatta di pietre e 2 dunum [0,2 ettari] di terra coltivata a grano, sesamo, fichi e ulivi. All’epoca tutto aveva un sapore migliore. Ci nutrivamo direttamente con i prodotti della terra. Potevamo anche andare facilmente al mare e grazie al commercio ci incontravamo con ogni genere di persone.
Nel 1948 avevo circa 15 anni. Una notte vedemmo arrivare verso di noi dei soldati. In un primo momento pensammo che fossero arabi. Ma poi iniziarono a sparare. Le pallottole volavano sopra la mia testa e pensai che sarei morto. Corsi da mio padre, che mi disse di andare verso est con le pecore. Allora ne avevamo sei. Me ne andai da solo, ma sentii sparare, così lasciai le pecore e corsi a casa.
Ce ne andammo con gli altri abitanti del villaggio. Prima arrivammo ad al-Abbassiyya, dove c’erano alcuni gruppi della resistenza palestinese. Poi ci incamminammo verso Deir Ammar, vicino a Ramallah.
Non ci portammo niente. Tutti parlavano di Deir Yassin (dove le forze sioniste avevano commesso un massacro). Eravamo spaventati già prima che arrivassero i sionisti. Avremmo dovuto rimanere e morire là. Avremmo dovuto lottare. Per lo meno non abbiamo mai venduto le nostre case. Siamo stati buttati fuori contro la nostra volontà.
Pochi giorni dopo che ce ne eravamo andati, entrai di soppiatto nel villaggio di notte. Ma quando entrai nella nostra casa, tutto – la farina, l’olio d’oliva, i mobili – era distrutto e sparso per la casa.
Tornammo al nostro villaggio, una volta, con mio padre. Fu dopo il 1967 [anno della guerra dei Sei giorni e della conquista israeliana della Cisgiordania, ndt.]. Bussò alla porta, e rispose uno [ebreo, ndt.] yemenita. Mio padre gli disse: “Questa è la mia casa.” Ma lo yemenita rispose solo: “Era casa tua, Ora è la mia.”
Reportage di Anne Paq
Wafta Hussein Khleif, 82 anni, campo di rifugiati di Dheisheh nella città di Betlemme della Cisgiordania occupata. Originaria di Deir Aban, nei pressi di Gerusalemme.
Tutti i figli maschi di Wafta sono stati arrestati da Israele in un momento o nell’altro, e uno sta scontando più di 20 anni di prigione. Uno dei suoi nipoti è stato ucciso durante un’incursione dell’esercito israeliano a Betlemme nel 2008. Aveva 17 anni.
Mangiavamo quello che coltivavamo. Tutto veniva dalla terra. Non compravamo niente. Vivevamo in una fattoria che aveva un cortile interno. Avevamo più di 1 dunum di terra con 200 ulivi, galline e pecore. C’erano ebrei che vivevano vicino a noi. Erano amici e venivano al villaggio a comprare latte. Non avevano neanche un mulino, per cui usavano quello del villaggio.
Nel 1948 ci furono molti scontri. Ci furono spari e bombardamenti aerei. Non avevamo armi, solo coltelli e falci. Scavammo una trincea attorno al villaggio. Durante quei giorni ci furono tre morti. Quando venimmo a sapere del massacro di Deir Yassin, come misero in fila gli uomini e gli spararono, fu troppo. Prendevano anche le ragazze. Fu allora che scappammo. Se fossi stata al nostro posto, che cosa avresti fatto?
Non c’era tempo. Prendemmo quello che potevamo portarci dietro. Mio nonno Hussein dovette essere trasportato su un cammello. Ci fermammo sotto un carrubo appena fuori dal villaggio. Pensavamo che saremmo tornati presto. Gli uomini tornarono per raccogliere le olive ma vennero attaccati dai sionisti.
Andammo a Jabba e rimanemmo con i loro amici, e da lì a Betlemme. Affittammo una spelonca da una famiglia cristiana che mio padre trasformò in una stanza con un tetto di zinco. Poi mi sposai con mio marito Muhammad al-Afandi e andai al campo di Dheisheh. Vivemmo in una tenda per tre o quattro anni. Lì nacquero i nostri primi tre figli.
Se Dio vuole, torneremo. Se non io, i miei figli, o i loro figli, o i figli dei figli, o i figli dei figli dei figli. Lasceremo tutto in un attimo e andremo, anche se questo significasse vivere di nuovo in una tenda.
Reportage di Anne Paq
Muhammad Khalil Leghrouz, 93 anni, campo di rifugiati di Aida nella città di Betlemme della Cisgiordania occupata. Originario di Beit Natif, a ovest di Betlemme.
Muhammad piange ancora quando parla di suo fratello Thaer, che venne ucciso dai miliziani sionisti nel 1948 all’età di 15 anni.
Beit Natif era tutto frutti e verdure. Coltivavamo di tutto. C’erano molti contadini. E c’erano molte mucche e pecore. Sono cresciuto con le pecore. Giocavo con loro dalla mattina alla sera. Non sono andato a scuola. La mia famiglia aveva una grande fattoria, costruita con vecchie pietre.
Nel 1948 venimmo attaccati. Ci furono sparatorie. Dovemmo scappare, passando su corpi lungo il tragitto per uscire dal villaggio. Mio fratello Thaer venne colpito a morte e lo seppellimmo subito. Lasciammo ogni cosa – le pecore e i gioielli di mia madre. Mio padre dovette essere trasportato su un cammello, perché non poteva camminare. Non voleva andarsene, ma lo presi sulle mie spalle, lo obbligai a salire sul cammello. Voleva morire là.
Prima andammo a Beit Ommar, poi a Hebron, a Betlemme e a Husan, dove incontrai mia moglie Fatima. Insieme venimmo a vivere nel campo profughi di “Aida” e ci fermammo lì. Non sono mai tornato al mio villaggio.
Mio padre non ha mai potuto dimenticare. “Torneremo”, continuava a dire.
Reportage di Anne Paq
Hakma Attallah Mousa, 108 anni, campo profughi “Spiaggia”, Gaza City. Originaria di al-Sawafir al-Shamaliya, a circa 30 km oltre il confine di Gaza.
Hakma ha più di 80 nipoti e pronipoti, ma persino i suoi familiari sono incerti sul numero esatto.
Mio padre Attallah Mousa era il mukhtar della nostra famiglia. Ricordo ancora il diwan (sala di ricevimento) di mio padre, dove accoglieva gli ospiti e aiutava a risolvere i problemi del villaggio.
Andavo a mungere le nostre mucche per fare il formaggio e lo yogurt. Avevamo pecore e galline. La mia famiglia possedeva più di 100 dunam [10 ettari] di terra su cui i miei fratelli seminavano grano, lenticchie e orzo. La nostra vita si basava sull’agricoltura. Grazie a Dio, abbiamo avuto dei momenti bellissimi.
Mia madre venne ferita quando stavamo scappando. Venne colpita dopo che avevamo preso alcune delle nostre cose e stavamo uscendo dal villaggio. L’abbiamo trasportata fino ad un ospedale a Gaza City. Morì poche settimane dopo.
Figlio mio, vogliamo tornare al nostro villaggio, e lo faremo. Vogliamo tornare alla nostra patria.
Reportage di Rami Almeghari
Hassan Quffa, 88 anni, campo profughi di Nuseirat, nella zona centrale della Striscia di Gaza occupata. Originario di Isdud, nei pressi di Ashdod.
Eravamo contadini, coltivavamo la nostra terra generazione dopo generazione. All’epoca l’agricoltura era molto diffusa e i cedri erano rigogliosi. La mia famiglia da sola possedeva circa 90 dunum [9 ettari]. Ero solito accompagnare mio zio Abdelfattah al nostro diwan dove incontrava la gente del posto e a volte gli inglesi. All’epoca le autorità britanniche andavano da mio zio, facendo affidamento su di lui come intermediario tra le autorità e gli abitanti del posto.
Giocavo a baseball. Eravamo sette per una partita. Dopo aver giocato, andavamo al bar “Ghabaeen” a bere caffé e a chiacchierare.
Le feste di matrimonio duravano da tre a sette giorni. Alla fine dei festeggiamenti gli zii di una sposa l’accompagnavano a casa del marito, di solito su un cavallo.
Quando i miliziani dell’ Haganah [il principale gruppo armato sionista, ndt.] iniziarono a sistemare posti di blocco nella zona di Ashdod, bloccando il passaggio, cominciammo ad prendere le armi. Un giovane su quattro aveva un fucile, nel tentativo di difenderci contro gli attacchi dell’Haganah. Eravamo solo contadini. Le bande sioniste erano ben addestrate ed equipaggiate, con l’aiuto degli inglesi. In effetti quando gli eserciti arabi arrivarono a combattere, ci sentimmo sollevati.
Ma l’unità dell’esercito arabo vicino a noi venne sconfitta. Le loro armi erano vecchie. Ovunque c’erano soldati arabi morti. Comprendemmo che non potevamo far altro che scappare.
Voglio tornare. Voglio che tutti noi torniamo. Quella è la mia casa. Ho il diritto di tornare. Spero di farlo prima di morire.
Reportage di Rami Almeghari
Amna Shaheen, 87 anni, attualmente vive a Gaza City, originaria del villaggio di Ni’ilya, nei pressi di Ashkelon.
Mio nonno Ibrahim era l’imam del villaggio e insegnava ai bambini il Corano e qualche argomento islamico. Ovviamente alle ragazze, compresa me, non era consentito imparare.
Mio padre aveva un gregge e io solevo aiutarlo. Avevo solo un fratello, che era malato.
Cacciavo via le volpi che cercavano sempre di prendere le nostre anatre. Per nutrire il gregge portavo qualche foglia verde, alcune dal nostro sicomoro. Mio padre commerciava in angurie e noi conservavamo quelle angurie sotto l’albero.
Fu quando venimmo a sapere di Deir Yassin che gli abitanti del villaggio iniziarono a fuggire. Durante il giorno i miliziani [sionisti] arrivarono per mandarci via, ricordo che mio cugino ed io stavamo pelando patate.
Due mesi dopo che eravamo scappati, mio padre è stato ucciso. All’epoca stavamo vivendo nel campo profughi di Jabaliya, a Gaza. Aveva comprato due mucche e stava andando a comprare paglia e fieno per le mucche. Ma in quel momento le jeep dell’esercito israeliano erano di pattuglia e i soldati iniziarono a sparare. Venne colpito quattro volte.
Anche se mi offrissero centinaia di milioni di dollari, non rinuncerei al mio diritto di tornare alla mia casa in Palestina. Cosa me ne farei di quei soldi?
Reportage di Rami Almeghari
Ismail Hussein Abu Shehadeh, 92 anni, originario ed attualmente abitante di Jaffa, nei pressi di Tel Aviv.
Adesso Jaffa non vale niente. Prima la città era stupenda. Era chiamata la “sposa del Medio Oriente.” Esportavamo arance in tutto il mondo. Arrivava gente da tutte le parti per lavorare qui.
Mio padre era un soldato dell’impero ottomano. Se ne andò nel 1914 per combattere nella Prima Guerra Mondiale. Tornò indietro a piedi. Questa probabilmente è la ragione per cui decise di rimanere quando i sionisti attaccarono Jaffa. Non voleva scappare di nuovo, e ci impedì di farlo. “O morite qui oppure scappate e vi sentirete umiliati per tutta la vostra vita,” ci disse. Pregava la gente di non andarsene. Solo 35 famiglie rimasero dopo la resa, appena 2.000 abitanti sui 120.000 che stavano qui.
Nel 1948 gli attacchi furono molto violenti. Il capo della città, il dottor Youssef Aked, ci riunì per dire che Jaffa stava per essere assediata e che la gente doveva scegliere tra andarsene e rimanere. Qualcuno chiese al dottore cosa egli avrebbe fatto, ed egli rispose che sarebbe fuggito con la sua famiglia. In seguito a ciò, molti lo fecero, anche perché si parlava molto di quello che era successo a Deir Yassin.
Solo poche persone con una certa autorità rimasero. Ci fu un altro incontro in cui si decise di arrenderci a condizione che non ci fossero distruzioni o saccheggi. Dei rappresentanti andarono a Tel Aviv con una bandiera bianca. I sionisti arrivarono con un megafono e dichiararono che ora Jaffa era sottoposta all’autorità sionista. Poi entrarono e si comportarono in modo avido. Rubarono proprietà. Ci nascondemmo nei frutteti per un mese. Poi la gente venne spinta nel quartiere di Ajami, dietro una recinzione elettrificata. Alcuni morirono di stenti. Ma noi riuscimmo a stare fuori dalla recinzione.
Nonostante le promesse sioniste metà di Jaffa venne demolita. Abu Laban, che aveva negoziato la resa, andò a lamentarsi me venne picchiato. Gli ruppero le costole e venne messo a sedere su un asino. Poi iniziarono a prendere di mira la gente. Una persona che si rifiutò di lasciare i frutteti venne uccisa.
Dopo il 1948 mi sposai e iniziai a lavorare nella regione di Tiberiade per circa sei anni. Venni assunto da israeliani per aggiustare motori o per portare l’acqua a nuove comunità ebraiche. Ero l’unico palestinese lì. Abbiamo mantenuto rapporti professionali. Mia moglie e i figli neonati stavano lottando per avere da mangiare e per un certo periodo tornai a Jaffa solo una volta al mese.
Il mio lavoro terminò quando arrivò l’elettricità. Lavorai in una fabbrica di Jaffa, aggiustando motori, ma nel 1956 alcuni operai ebrei mi aggredirono a causa della sconfitta israeliana a Suez [si riferisce alla guerra per il controllo del canale di Suez tra Egitto e Francia e Gran Bretagna, a cui Israele si alleò, ndt.], per cui me ne andai. Poi ebbi un’officina meccanica nel porto, e cercai di fare il pescatore, ma senza successo. Nel 1982 lo Stato di Israele iniziò a chiedere tasse e più documenti. Dovetti vendere tutto. Alla fine aprii una drogheria ma poi dovetti smettere per ragioni di salute.
Rami Almeghari è giornalista e docente universitario a Gaza.
Anne Paq è una fotografa freelance francese e fa parte del collettivo di fotografi ActiveStills [collettivo di fotografi israeliani, palestinesi e internazionali che lotta contro le ingiustizie e le discriminazioni, in particolare in Israele/Palestina, ndt.].
Mohammed Asad è un fotogiornalista che vive a Gaza.
(traduzione di Amedeo Rossi)
.