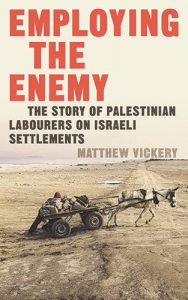Il mare è sempre il solito mare
The London Review of Books
Adam Shatz
Bibi: The Turbulent Life and Times of Benjamin Netanyahu [Bibi: La vita e i tempi turbolenti di Benjamin Netanyahu]di Anshel Pfeffer, Hurst, 423 pp, £20.00, Maggio.
“Il problema di Israele,” ha scritto Tony Judt sulla New York Review of Books nel 2003,
“non è –come qualcuno ha sostenuto – che sia un’‘enclave’ europea nel mondo arabo, ma piuttosto che è arrivato troppo tardi. Ha importato un progetto di separatismo tipico della fine del XIX° secolo in un mondo che è andato avanti, un mondo di diritti individuali, frontiere aperte e leggi internazionali. La stessa idea di uno ‘Stato ebraico’ – uno Stato in cui gli ebrei e la religione ebraica hanno privilegi esclusivi da cui i cittadini non ebrei siano per sempre esclusi – è radicata in un altro tempo e luogo. In breve, Israele è un anacronismo.”
Oggi è la certezza internazionalista liberale di Judt che sembra un anacronismo, mentre Israele – una “società ibrida di antiche fobie e speranze di tecnologia avanzata, una combinazione di tribalismo e globalizzazione”, nelle parole del giornalista Anshel Pfeffer – assomiglia sempre più all’embrione di un nuovo mondo governato da timori atavici, il cui sintomo più malefico è la presidenza di Donald Trump.
Pfeffer, corrispondente di “Haaretz”, ha scritto una biografia di Benjamin Netanyahu per spiegare l’odierno Israele – un compito per niente invidiabile. Dite quello che volete dei predecessori di Netanyahu, ma essi avevano un loro fascino, dall’autodisciplina monacale di David Ben-Gurion all’avidità di Ariel Sharon. Netanyahu sembra un personaggio vuoto: un “responsabile del marketing”, con le parole di Max Hastings, che lo ha incontrato mentre scriveva una biografia di suo fratello Jonathan. Eppure Netanyahu può difficilmente essere ignorato, o la sua capacità di sopravvivenza negata. Se non verrà obbligato a lasciare il suo incarico per accuse di corruzione prima del luglio 2019, sarà il primo ministro più a lungo in carica, superando Ben-Gurion. La democrazia israeliana, il marchio del responsabile del marketing, è caduta in un discredito totale tra i progressisti dell’Occidente, ma lui non si è mai preoccupato di quello che pensano i progressisti, ed essi hanno un’influenza molto minore in un’era di demagogia populista. Trump, Putin, Modi, Orbán: Netanyahu non potrebbe essere più a suo agio in un mondo di uomini forti nazionalisti. Senza restituire neppure un centimetro di terra occupata, ha sconfitto gli Stati arabi sunniti, paralizzati dal timore per l’Iran sciita, che ne hanno abbastanza dei palestinesi e incapaci di esercitare pressioni su Israele. La resistenza palestinese in Cisgiordania ha in pratica subito una battuta d’arresto. Gli ebrei israeliani – più di 600.000 dei quali vivono nelle colonie – non hanno alcuna ragione per preoccuparsi dei palestinesi, salvo che si stiano appassionando agli episodi di “Fauda”, la serie televisiva israeliana sull’occupazione. La maggioranza degli ebrei israeliani considera l’assedio di Gaza, che ha reso il territorio quasi inabitabile, un prezzo accettabile da pagare per la ‘sicurezza’, anche se è proprio la miseria provocata dall’assedio che accresce la loro insicurezza. Questa opinione non è condivisa dai cittadini palestinesi di Israele, circa il 20% della popolazione, ma essi sono degli emarginati interni.
L’Israele di Netanyahu incarna quello che Ze’ev Jabotinsky, l’idolo di suo padre, chiamava “un muro di ferro di baionette ebraiche”. Jabotinsky, il fondatore del sionismo revisionista [corrente di destra del sionismo, ndtr.], sognava un Israele su entrambe le rive del Giordano. Netanyahu ha fatto la pace con il dominio degli Hascemiti [la dinastia regnante, ndtr.] sulla Giordania, ma nel suo impegno per un Israele più grande e nella sua implacabile opposizione all’autodeterminazione dei palestinesi rimane figlio di suo padre. Nato nel 1910 in una famiglia sionista a Varsavia, Benzion Mileikowsky si stabilì a Gerusalemme nel 1924 e si unì a “Hatzohar”, l’Unione Mondiale dei Sionisti Revisionisti, sionisti di destra ma laici, profondamente influenzati dal nazionalismo sangue e terra, ed adottò lo pseudonimo di suo padre, ‘Netanyahu’, ‘donato da dio’. Diventò uno studioso dell’inquisizione spagnola, proponendo la tesi spietata secondo cui, invece di morire per la loro fede, i conversos accettarono la Chiesa [cattolica] per ambizione.
Il maggior risultato raggiunto da Benzion in “Hatzohar” fu di esserne il rappresentante ad una conferenza del 1940 a New York: era un militante di destra di poco conto, “al massimo, una figura marginale nel circolo del leader”. Ma era uno che ci credeva davvero, sconvolto dalla sconfitta del movimento nella sua rivalità con il sionismo socialista di Ben-Gurion, che per questioni di tattica accettò l’idea della partizione della Palestina. Con la fondazione dello Stato di Israele sotto la direzione di Ben-Gurion, uomini come Benzion Netanyahu vennero lasciati a leccarsi le ferite. Uomo rigido e cupo, continuò a leccarsele per tutta la vita, per lo più passata in un orgoglioso e autoimposto esilio da Sion. Convinto che “il cuore della nostra Nazione sia stato distrutto” dopo l’Olocausto, vedeva i nuovi dirigenti dello Stato come uomini deboli, che preparavano la strada per la “liquidazione dei sionisti”. Dopo l’indipendenza trovò lavoro come uno dei redattori della nuova Encyclopedia Hebraica, ma si rodeva dall’amarezza per la sua incapacità di garantirsi un incarico accademico degno di quelle che sentiva essere le sue capacità.
Bejamin Netanyahu, ‘Bibi’ per la sua famiglia, è nato nel 1949 a Tel Aviv, tre anni dopo il suo fratello maggiore, Jonathan (‘Yoni’), ed è cresciuto a Katamon, un sobborgo abitato prevalentemente da arabi cristiani prima della guerra del 1948. (Un terzo figlio, Iddo, è nato nel 1952). Nel 1963 i ragazzi vennero sradicati quando il padre, convinto di essere stato messo nella lista nera dal mondo accademico, spostò la sua famiglia a Elkins Park, un verdeggiante quartiere periferico di Filadelfia. Per una famiglia revisionista lasciare Israele non era un’umiliazione da poco: gli ebrei che emigrano [da Israele] sono noti come yordim, quelli che scendono (gli immigrati fanno aliyah e “salgono”). Scendendo, i ragazzi Netanyahu dovettero rimandare il loro ingresso nell’esercito, la loro più profonda aspirazione: sia Yoni che Bibi erano decisi a lavare l’onta del loro colto padre, un profeta reietto nello Stato ebraico. Le lettere di Yoni ai suoi amici in patria fanno pensare ad un Sayyid Qutb [leader islamico egiziano, dirigente della Fratellanza musulmana, ndtr.] sionista, disgustato dall’edonismo americano: “Qui la gente parla di macchine e ragazze. La loro vita gira attorno ad un argomento – il sesso – e penso che Freud qui avrebbe avuto un fertile campo per seminare e raccogliere i suoi frutti. Mi sto convincendo di vivere in mezzo a scimmie, non a esseri umani.” Yoni inizialmente si accontentò di predicare il sionismo con i suoi compagni di classe, ma nel 1964 tornò in Israele per diventare paracadutista, realizzando la fantasia di suo padre del guerriero ebreo che difende la sua terra dagli arabi, che vedeva come “una marmaglia di cavernicoli”.
Senza il fratello maggiore, che adorava, Netanyahu sembra si sia perso nella selva degli anni ’60 americani. A “Cheltenham High” [prestigioso college nei pressi di Filadelfia, ndtr.] era noto come Ben, non Bibi. Giocava nella squadra di calcio ed era membro della società di scacchi, ma per lo più se ne stava per conto suo. Aveva poco in comune con i suoi compagni di classe ebrei progressisti infervorati dal movimento per i diritti civili [degli afroamericani, ndtr.]. Lettore di Ayn Rand [scrittrice e filosofa liberale di destra, ndtr.], era preoccupato dei mali del comunismo, non di quelli del razzismo. Una settimana prima dello scoppio della guerra del 1967 [tra Israele e gli Stati arabi, nota come la Guerra dei Sei Giorni, ndtr.] volò in Israele. Netanyahu sostiene di essere tornato per lottare per il suo Paese, ma Pfeffer afferma che la ragione principale era che gli mancava Yoni.
Tornato in Israele, Bibi si addestrò come soldato combattente, e si unì a “Sayeret Matkal”, un’unità speciale d’élite la cui esistenza rimase un segreto ufficiale fino al 1992. Benché più corpulento del suo slanciato e spartano fratello maggiore, era estremamente in forma, e rimase nell’esercito per cinque anni, partecipando a molti attacchi al di là dei confini, compresa la battaglia di Karameh, in Giordania, del 1968 [nota come prima vittoria dei palestinesi contro l’esercito israeliano, ndtr.], in cui combatté contro i guerriglieri palestinesi sotto il comando di Arafat. Nel maggio 1972 venne ferito a una spalla da fuoco amico durante la liberazione del Boeing 707 della Sabena dirottato [dal gruppo palestinese “Settembre nero”, per chiedere uno scambio di prigionieri, ndtr.].
Bibi avrebbe potuto continuare la carriera militare come Yoni, ma aveva ambizioni più mondane. Due mesi dopo la liberazione del volo Sabena ritornò negli Stati Uniti con la sua ragazza, Miki Weizmann, con cui si sposò poco dopo. Si iscrisse ad un corso di architettura e urbanistica al MIT [Massachusetts Institute of Technology, ndtr.] (in seguito prese una seconda laurea alla scuola di management), mentre Weizmann studiò chimica a Brandeis [prestigiosa università nei pressi di Boston, ndtr.]. Ritornò a chiamarsi Ben invece di Bibi; cambiò persino il suo cognome in ‘Nitay’ perché gli americani facevano fatica a pronunciare ‘Netanyahu’. Era un tipico insieme di zelo assimilazionista e di disprezzo per l’unico Paese in cui aveva conosciuto qualcosa di simile a una vita civile: in Israele da adulto è stato solo un soldato o un politico. Pochi mesi prima dello scoppio della guerra del 1973 indusse Yoni, diventato ora vice di Ehud Barak nell’unità “Sayeret Matkal”, a passare il semestre estivo ad Harvard. Benché Yoni condividesse l’ammirazione di Bibi per l’intraprendenza americana, gli attivisti contro la guerra nel campus lo disgustarono, soprattutto quelli ebrei: “Sembra che abbiano smesso da molto tempo di essere obiettivi. Un peccato per l’America, perché questi pazzi la distruggeranno.” (Tutti e due i fratelli parteciparono alla guerra: Bibi ha raccontato con orgoglio di essere stato vicino ad Ariel Sharon e a Ehud Barak sulle sponde del Canale di Suez, ma Barak dice di non ricordarsi di un simile incontro).
Il dramma che ha segnato la vita di Netanyahu da giovane ha avuto luogo nel luglio 1976, quando Yoni venne ucciso all’aeroporto di Entebbe durante una missione per la liberazione di ostaggi israeliani ed ebrei del volo Air France 139, dirottato da quattro membri di una cellula tedesca del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina [gruppo armato marxista, ndtr.]. La storia della sua morte e di chi l’abbia ucciso rimane controversa. Secondo il racconto più ampiamente accettato, contravvenne agli ordini aprendo il fuoco contro i soldati ugandesi, attirando quindi l’attenzione della torre di controllo, da cui molto probabilmente vennero sparati i colpi che lo uccisero. La famiglia Netanyahu, tuttavia, rifiutò di credere che il loro figlio fosse stato ucciso da un soldato semplice ugandese, e insistettero che fosse stato ucciso dal comandante tedesco dei dirottatori. Benché Yoni fosse stato depresso per mesi e poco comunicativo nelle riunioni, venne esaltato nella mitologia familiare come “l’impareggiabile comandante”, trasformato in un’icona anche prima del suo funerale. “Mi aspettavo che il padre dicesse quanto amasse suo figlio e gli mancasse,” ricordò dopo il funerale Moshe Arens, politico del Likud. “Invece Benzion disse: ‘Gli arabi non sanno ancora quale perdita hanno inflitto agli ebrei.’”
Incaricato dalla famiglia di scrivere la biografia di Yoni, Max Hastings lo ritrasse come un tipo scontroso, testardo e solitario, molto simile al padre, solo senza la sua intelligenza – “un giovane problematico di media intelligenza, che si sforzava di fare i conti con concetti intellettuali al di là della sua comprensione.” Lungi dall’essere un comandante senza pari, Yoni era stato “attivamente detestato da non pochi dei suoi uomini.” Furiosi contro Hastings, i Netanyahu pubblicarono il libro in forma depurata. Hastings, che nelle sue memorie scrisse dei suoi incontri con la famiglia (“uno dei più spiacevoli episodi della mia carriera”), prese in particolare antipatia Bibi, che si vantò: “Nella prossima guerra, se facciamo le cose come si deve, avremo la possibilità di buttar fuori tutti gli arabi…Possiamo ripulire la Cisgiordania, mettere a posto Gerusalemme.” Il razzismo di Bibi, ricordò Hastings, non si limitava agli arabi: “Scherzava sulla brigata Golani, il corpo di fanteria [dell’esercito israeliano, ndtr.] in cui molti uomini erano ebrei nordafricani o yemeniti. ‘Vanno bene finché sono guidati da ufficiali bianchi,’ ghignava.”
Con tutta la sua spacconeria, ‘Ben Nitay’ era ancora confuso in pieni anni ’70. Tenne occasionali discorsi nella zona di Boston a favore del governo israeliano, che riconobbe in lui un elemento prezioso per la sua esperienza nelle forze speciali, per il suo accento americano, per il bell’aspetto e, non da ultimo, per la sua predisposizione per l’hasbara – una parola ebraica che significa difendere Israele attraverso una presentazione notevolmente selettiva dei fatti. Ma a 25 dollari a discorso, l’hasbara non lo ripagava delle spese, o non ancora, per cui Netanyahu si mantenne con il suo lavoro di consulente e, per un breve periodo, come direttore commerciale per un produttore di mobili in Israele. La sua vita privata era un disastro. Il suo matrimonio finì poco dopo la nascita della figlia Noa nel 1978, quando Weizmann venne a sapere della sua storia con Fleur Cates, una donna anglo-tedesca che aveva incontrato nella biblioteca della facoltà di economia di Harvard e che in seguito sposò.
Netanyahu rimase nell’ombra di Yoni, il figlio favorito: si impegnò nella supervisione della pubblicazione delle lettere di suo fratello e nella costituzione di un gruppo di ricerca intitolato a lui. L’elezione di Menachem Begin nel 1977, che portò al potere il Likud e preannunciò un grande riassetto nella politica israeliana a favore della Destra, avrebbe dovuto migliorare le sue prospettive. Ma Begin, l’ex-comandante della milizia “Irgun” e seguace di Jabotinsky, considerava il padre di Bibi “un borioso parolaio che aveva preferito una comoda vita negli Stati Uniti”, e guardava con sospetto al suo figlio yordim [espatriato]. Quando Begin acconsentì a ritirarsi dal Sinai, Netanyahu vide la decisione come un tradimento, ma fu abbastanza calcolatore da non firmare nessuna petizione di protesta: la famiglia aveva bisogno del beneplacito di Begin per la prima conferenza internazionale dell’istituto “Jonathan”, tenutasi a Gerusalemme nel 1979.
Due anni più tardi il discorso di Netanyahu a quella conferenza gli diede la prima occasione in politica come vicecapo della missione diretta da Moshe Arens, il nuovo ambasciatore di Israele negli USA, un falco. Tanto edotto del pensiero di Ayn Rand quanto fluente in inglese, Netanyahu prosperò nella Washington di Reagan, dove l’economia ultraliberista e il sionismo revisionista erano i due pilastri di centri di ricerca di destra come l’”American Enterprise Institute” e la “Heritage Foundation”. Egli si abituò alle interviste davanti alle telecamere e imparò a “tenere l’occhio fisso sugli obiettivi mentre presentava la parte sinistra del suo viso, quella senza la cicatrice sul labbro”. (Netanyahu si tagliò il labbro superiore da bambino quando scivolò dalle braccia di Yoni mentre scavalcavano un cancello, un’altra ‘eresia’ eliminata dalla mitologia di Yoni.) “Giovane, di bell’aspetto e ostentando fiducia in se stesso” come lo presenta Pfeffer, si ingraziò i campioni di Israele nei media americani, da William Safire, un editorialista neoconservatore del “New York Times”, al più affabile sionista Ted Koppel dell’ABC, nel cui spettacolo, “Nightline”, fece frequenti apparizioni come ‘esperto di terrorismo’. Safire chiese ad Israele di nominare Netanyahu suo nuovo ambasciatore quando Arens sostituì Sharon come ministro della Difesa, dopo che Sharon fu obbligato a dimettersi in seguito al massacro di Sabra e Shatila [campi profughi palestinesi a Beirut in cui nel settembre 1982, durante la prima guerra di Israele contro il Libano, i miliziani cristiani massacrarono centinaia di civili con la complicità delle truppe israeliane, ndtr.]. Ma Yitzhak Shamir, il nuovo primo ministro, considerava Netanyahu “superficiale, vanitoso, autodistruttivo e prono alle pressioni.” Come diceva lui: “Il mare è il solito mare e Netanyahu è il solito Netanyahu.”
I ‘principi’ del Likud forse avevano poco tempo da dedicare a Netanyahu, ma egli ebbe successo nel corteggiare Shimon Peres, il dirigente laburista, che lo nominò ambasciatore alle Nazioni Unite nel 1984, dopo aver formato un governo di unità nazionale con Shamir. Appena Netanyahu si trasferì a New York fece richiesta di ristrutturazioni nella residenza dell’ambasciatore di fronte al Met [Metropolitan Museum of Art, ndtr.]. Egli visse nel lusso con Fleur all’hotel Regency finché l’appartamento fu pronto, e corteggiò ricchi ebrei newyorkesi come Ronald Lauder, che lo presentò ad altri miliardari, tra cui Donald Trump. Benché non praticante, strinse alleanza con il leader dei Lubavitcher [setta chassidica originaria della Bielorussia, ndtr.] Menachem Mendel Schneerson, che lo accolse nella sua residenza di Brooklyn e gli ordinò di “accendere una candela per la verità e per il popolo ebraico” in quella “casa di menzogne”, l’ONU.
Nel suo ruolo di ambasciatore, Netanyahu era poco più che un corretto professionista dell’hasbara – un “modesto demagogo”, nelle parole di Reuven Rivlin, segretario della sezione di Gerusalemme del Likud ed ora presidente di Israele. Ma trovò un alleato più utile in Moshe Arens, che nel 1988 convinse Shamir a nominarlo rappresentante al ministero degli Esteri. Netanyahu ingaggiò un collaboratore non ufficiale: Avigdor Lieberman [attuale ministro e capo di un partito di estrema destra, ndtr.], un colono estremista moldavo, di nove anni più giovane, un ex buttafuori di nightclub. Benché Arens fosse il suo capo, Netanyahu aveva difficoltà a controllarsi, al punto da denunciare la politica americana come “fondata su menzogne e distorsioni”. James Baker, il segretario di Stato di George Bush, gli vietò di entrare nel dipartimento di Stato. “Ero offeso dalla sua disinvoltura e dalle sue critiche alla politica USA – per non parlare dell’arroganza e della sua bizzarra ambizione,” ricorda nelle sue memorie Robert Gates, allora vice consigliere per la sicurezza nazionale.
*
Ma Netanyahu aveva come obiettivo impossessarsi del Likud, non la pace in Medio Oriente; si stava esibendo per il pubblico di casa. Il suo insieme di magniloquenza e calcolo funzionò. Durante la prima guerra del Golfo mise in relazione la minaccia degli attacchi iracheni con gas letale con le camere a gas naziste, e si mise una maschera antigas durante un’intervista con la CNN. Dovette trovarne una speciale, con il filtro di fianco, dato che quelle normali hanno un grande filtro sul davanti che non permette di ascoltare le parole di chi se le mette. “Devo dire che questo è il modo più stupido per fare un’intervista,” disse. “Tuttavia quello che mette in evidenza è la minaccia che Israele deve affrontare.” Di fatto, la minaccia che cercava di neutralizzare non era Saddam Hussein, ma il suo principale rivale nel Likud, David Levy, un ebreo marocchino che non parlava inglese e non aveva talento per l’hasbara.
Netanyahu quasi perse la sua lotta con Levy quando la sua nuova moglie, Sara Ben Artzi, una giovane hostess che aveva incontrato ad Amsterdam poco dopo la fine del suo matrimonio con Fleur, ricevette una telefonata da una fonte anonima che sosteneva di avere un video di lui che faceva sesso con un’altra donna. Cacciato dalla dimora del suo ultimo matrimonio e finito a casa dei suoi genitori, Netanyahu si dichiarò vittima di “un delitto senza precedenti nella storia della democrazia” e praticamente accusò Levy. Il matrimonio sopravvisse, grazie ad un accordo architettato da avvocati che concedeva a Sara pieno accesso alla sua agenda e il diritto di bloccare la nomina di ogni membro dello staff. E Netanyahu venne regolarmente eletto leader del Likud, con il 52% dei voti degli iscritti al partito. Si circondò di israeliani di destra che erano nati negli USA o vi avevano passato lunghi periodi: David Bar-Ilan, un pianista da concerto che era editorialista del Jerusalem Post [giornale israeliano in inglese e francese, all’epoca di destra, ndtr.], Dore Gold, un docente universitario del Connecticut che aveva scritto la sua tesi di laurea sull’appoggio dei sauditi al terrorismo (ora un argomento delicato, suppongo [si riferisce al recente avvicinamento tra Arabia Saudita ed Israele, ndtr.]), e l’intellettuale revisionista Yoram Hazony.
“Pochi politici hanno avuto una così lunga ed intensa carriera senza che le loro opinioni cambiassero,” scrive Pfeffer. Queste opinioni sono state espresse chiaramente con impressionante ampiezza nel libro del 1993 di Netanyahu “Un posto tra le Nazioni”, in cui (nell’utile riassunto di Pfeffer) egli sostenne che il conflitto arabo-israeliano non ha niente a che vedere con “palestinesi, confini o rifugiati. Non riguarda neanche Israele. Deriva da un odio implacabile di arabi e musulmani nei riguardi dell’Occidente, e di Israele come avamposto dell’Occidente in Medio Oriente”. Solo la “pace della deterrenza” farà rigare dritti gli arabi; un compromesso territoriale era impensabile, persino un tradimento. “Sei peggio di Chamberlain [primo ministro inglese che consegnò la Cecoslovacchia a Hitler pensando di salvare la pace, ndtr.],” disse Netanyahu a Rabin [primo ministro israeliano che firmò gli accordi di Oslo, ndtr.] nella Knesset [il parlamento israeliano, ndtr.], quando nell’agosto 1993 i colloqui di Oslo vennero rivelati per la prima volta. “Egli mise in pericolo un’altra Nazione, ma tu lo stai facendo con la tua stessa Nazione.” Pfeffer insiste che i discorsi di Netanyahu contro Rabin erano “misurati”, e lo difende dall’accusa di essere responsabile per la campagna di istigazione all’odio che portò all’uccisione di Rabin il 4 novembre 1995. “Pur cavalcando la tigre dell’estrema destra,” scrive, “in nessun momento Netanyahu utilizzò il vocabolario dell’estrema destra contro Rabin ed i suoi ministri.” Ma non ne aveva bisogno. Doveva semplicemente andare ai comizi in cui Rabin veniva chiamato assassino e traditore, e non dire niente. La vedova di Rabin, Leah, rifiutò di stringergli la mano durante i funerali di Stato: “Non lo perdonerò finché vivrò.”
Nelle elezioni del 1996, Netanyahu sconfisse di poco Peres, che aveva fallito la campagna contro Hezbollah, e la cui operazione “Furore” culminò con il bombardamento di una struttura dell’ONU nel sud del Libano [la cosiddetta strage di Canaa, ndtr.] e l’uccisione di più di cento civili che vi si erano rifugiati. “Per gli ebrei ci vuole Netanyahu” fu lo slogan della sua campagna. “Gli ebrei hanno sconfitto gli israeliani,” commentò Peres, un’amara allusione all’oscura mentalità da shtetl [villaggi ebraici dell’Europa orientale, ndtr.] che, secondo lui, isolava il revisionismo di Netanyahu dal fiducioso ethos sabra [gli ebrei nati in Palestina prima della nascita dello Stato di Israele, ndtr.] promosso da Ben-Gurion. Nel suo primo discorso, Netanyahu promise di incoraggiare “colonie d’avanguardia” e non tracciò distinzioni tra i due lati della Linea Verde che separava i confini di Israele prima del 1967 e i territori occupati: “I coloni sono i veri pionieri dei nostri giorni e meritano il nostro aiuto e la nostra stima.” I coloni del complesso di Gush Etzion [prima colonia costruita nei territori palestinesi occupati, ndtr.] presto avrebbero goduto dei benefici di una nuova strada e di un tunnel –creazione del ministro alle Infrastrutture di Netanyahu, Ariel Sharon – che permise loro un accesso diretto a Gerusalemme, evitando le città palestinesi.
Diventando primo ministro, Netanyahu aveva superato Yoni, ma suo padre non rimase impressionato: “Sarebbe stato un eccellente ministro dell’hasbara,” o “un ottimo ministro degli Esteri,” disse Benzion a un giornalista poco dopo le elezioni. Cosa ne pensa come primo ministro, chiese il giornalista: “Il tempo lo dirà.” Il primo mandato di Netanyahu fu burrascoso ed effimero come una prova di matrimonio. Si circondò di persone leali con poca o nessuna esperienza, tutte approvate da Sara, che egli “non cercò mai di contrastare.” (Lei si fece anche la fama di terrorizzare le bambinaie del loro figlioletto, Yair). Dopo il suo primo incontro con Arafat annunciò immediatamente la costruzione di 1.500 abitazioni per i coloni, e minacciò di chiudere il dipartimento dell’OLP a Gerusalemme est. Con un puro e semplice tentativo di affermare la sovranità ebraica su Gerusalemme, aprì l’uscita del tunnel di Asmodeo che unisce la via Dolorosa al Muro del pianto. Dato che l’uscita era nel quartiere musulmano della Città Vecchia, ciò era destinato a far infuriare i palestinesi, ma Netanyahu insistette che l’uscita “riguarda i fondamenti della nostra esistenza.” Il risultato fu una breve guerra, che lasciò un centinaio di palestinesi e 17 soldati israeliani uccisi. Pfeffer atrribuisce a Bibi il fatto di essere stato il primo dirigente del Likud ad aver ordinato il ritiro di truppe israeliane da una parte della “terra di Israele” quando accettò il controllo dell’Autorità Nazionale Palestinese su una parte di Hebron. Ma il ‘compromesso di Hebron’ lasciò lì 450 coloni ebrei con il controllo sul 20% della città, e migliaia di palestinesi ed il centro della città sotto occupazione militare.
Pfeffer sostiene che Netanyahu era detestato dalla sinistra in parte perché proveniva dallo stesso contesto askenazita [lett. “tedeschi”, ebrei originari dell’Europa centro-orientale, ndtr.] cosmopolita e secolarizzato, eppure condivideva le convinzioni dell’“altro Israele”, di cui facevano parte la classe operaia, i mizrahi [ebrei originari dei Paesi arabi o musulmani, ndtr.] e gli ebrei russi. Può darsi, ma la sua determinazione ad uccidere Rabin per la seconda volta, seppellendo ogni possibilità di accordo con i palestinesi, era più importante. Era irresponsabile quanto provocatore. Nel 1997 cercò di far avvelenare Khaled Meshal, il capo dell’ufficio politico di Hamas, ad Amman, violando l’ordine di Rabin di porre fine alle operazioni clandestine in Giordania, e danneggiando gravemente le relazioni di Israele con il suo unico reale alleato arabo.
Non solo Netanyahu venne obbligato a fornire l’antidoto che salvò la vita di Meshal, ma dovette anche rilasciare lo sceicco Ahmed Yassin, il leader di Hamas a Gaza, un grave colpo per Arafat, il presunto partner per la pace con Israele. “The Economist” [settimanale liberal-democratico inglese, ndtr.] definì Netanyahu il “pasticcione seriale di Israele”. Alla fine del suo primo mandato, aveva perso persino il rispetto della destra religiosa, il suo più prezioso alleato. Il rabbino Ovadya Yosef, il fanatico clericale nato in Iraq che guidava il partito Shas, lo definì “una capra cieca”.
Nelle elezioni del 1999 Netanyahu venne sconfitto da Barak, che corse con l’appoggio del rivale di Netanyahu nel Likud, David Levy. Solo pochi mesi dopo venne aperta un’inchiesta sul suo esorbitante appannaggio mensile per i sigari cubani e la stravagante ristrutturazione della residenza di Netanyahu che Sara, “la sua perfetta co-reggente”, aveva ordinato. Ma nel suo ultimo anno di governo Netanyahu fece una serie di mosse che lo avrebbero profumatamente ripagato. Mentre tranquillizzava Bill Clinton che il “Monicagate” [scandalo sessuale tra il presidente USA e Monica Levinsky, ndtr.] “si sgonfierà”, iniziò a comparire nei comizi degli evangelici tenuti da detrattori di Clinton come Pat Robertson e Jerry Falwell [pastori evangelici di estrema destra, ndtr.], forgiando l’alleanza tra Israele e gli evangelici che ora è un pilastro del mondo di Trump. E il seguace di Ayn Rand si reinventò come uomo del popolo, candidato, come lo raccontava lui, contro “i ricchi, gli artisti…quelle élite. Odiano chiunque…Odiano il popolo. Odiano i mizrahi, i russi, chiunque non sia come loro.”
Quel messaggio non funzionò nelle elezioni del 1999. Né Netanyahu si fece amici tra “il popolo” quando, come ministro delle Finanze di Barak [in un governo di unità nazionale, ndtr.], umiliò una madre single, elettrice del Likud, che aveva marciato dal Negev fino a Gerusalemme per protestare contro i tagli all’assistenza. (“Probabilmente fa jogging tutte le sere”). Ma, come sottolinea Pfeffer, l’uomo del marketing aveva una particolare intuizione su come la politica stesse passando dalle strade a internet, e dell’importanza fondamentale della comunicazione. Contrattò un nuovo consigliere, Ron Dermer, un consulente nato in America che sarebbe diventato famoso come “il cervello di Bibi”, e decise che aveva bisogno di un “suo personale media”. Il magnate americano dei casinò Sheldon Adelson accettò, e nel 2007 creò “Yisrael Hayom” (Israele oggi), un quotidiano gratuito di destra, al costo di circa 25 milioni di dollari all’anno. Per conservare la sua immagine di uomo del popolo, Netanyahu annullò la pubblicazione del suo manifesto per il libero mercato “La tigre israeliana”, per non inimicarsi i votanti colpiti dalla crisi finanziaria del 2008. (Non è mai stato pubblicato). E nel 2009 ritornò al potere, con Barak come suo ministro della Difesa. Il ministro degli Esteri – promosso a ministro della Difesa quando Barak diede le dimissioni – fu il suo vecchio amico, l’irriducibile colono moldavo Avigdor Lieberman, che sosteneva che i cittadini palestinesi di Israele dovrebbero essere obbligati a prestare un giuramento di fedeltà o perdere la cittadinanza.
Pfeffer afferma che Netanyahu “non è un guerrafondaio”, e che “nonostante le sue chiacchiere sullo scontro con la minaccia iraniana, è stato talmente prudente da non scatenare nessuna guerra – il che depone a suo favore.” È vero in parte. Netanyahu è un pragmatico di destra la cui principale preoccupazione è sempre stata di rimanere al potere; ha il senso del limite. Ma, come dimostra Pfeffer, ha il gusto del rischio calcolato, soprattutto quando si tratta dell’Iran, il cui programma nucleare è stato la sua ossessione negli ultimi due decenni. Nel 2010 Netanyahu e Barak ordinarono a Gabi Ashkenazi, il capo di stato maggiore dell’esercito israeliano, di mettere l’esercito in massima allerta, utilizzando il termine che in ebraico significa “alzare il cane della pistola”. Cedettero quando Ashkenazi ricordò loro che fare ciò sarebbe stato un atto di guerra, che in base alla legge richiede l’autorizzazione di tutto il governo. Nell’estate del 2012 progettò di avviare un attacco preventivo contro le strutture nucleari dell’Iran poco dopo un’esercitazione congiunta con l’esercito americano, e due settimane prima delle elezioni presidenziali USA. Un gruppo di ex-ufficiali dell’intelligence, che comprendeva comandanti di “Sayeret Matkal”, gli inviarono una lettera riservata avvertendolo del “terribile caos che ne sarebbe derivato in vari modi dopo l’euforia iniziale.” Barak sostiene che non aveva bisogno di essere convinto: attaccando poco prima di un’elezione, “avremmo piazzato una trappola politica per il presidente degli Stati Uniti.”
That president was, of course, Barack Obama, whom Netanyahu famously loathed (the feeling was mutual). Netanyahu lobbied furiously against Obama’s efforts to reach a peaceful agreement over Iran’s nuclear programme, most notably in his bellicose speech to a joint session of Congress in 2014. For this shameless defiance of Israel’s major patron, he received 26 standing ovations – in Jon Stewart’s words, ‘by far the longest blowjob a Jewish man has ever received’. There were side benefits to Obama’s Iran diplomacy, which, as Pfeffer notes, ‘saved Netanyahu from making progress with the Palestinians’. Even so, Netanyahu cast Obama ‘in the consciousness of the Israeli public as the nation’s enemy’. They didn’t require much persuading: the son of a Kenyan father with a Muslim middle name and a surname that rhymed with Osama, Obama cut a suspiciously Third World figure in a country where race prejudice runs deep, as not only Palestinian Arabs but African asylum-seekers and Ethiopian and Moroccan Jews can attest. Never mind that Obama had declared the American bond with Israel ‘unbreakable’: he had also described the occupation’s ‘daily humiliations’ as ‘intolerable’. Worst of all, in the minds of Netanyahu and his supporters, he had suggested that Israel was created because of the Holocaust, rather than because of the Jews’ ancestral claim to the land, tapping into Zionist anxieties about ultimate ownership rights.
Quel presidente era ovviamente Barack Obama, che notoriamente Netanyahu detestava (ricambiato). Netanyahu fece pesanti pressioni contro i tentativi di Obama per raggiungere un accordo pacifico sul programma nucleare iraniano, in particolare nel suo bellicoso discorso durante una sessione congiunta del Congresso nel 2014. Per la sua sfida senza pudore al maggiore protettore di Israele, ricevette 26 ovazioni – secondo Jon Stewart “in assoluto il più lungo pompino che un ebreo abbia mai ricevuto.” C’erano vantaggi secondari per la diplomazia di Obama con l’Iran, che, come nota Pfeffer, “evitarono a Netanyahu di fare progressi [nei colloqui di pace] con i palestinesi.” Nonostante ciò, Netanyahu assegnò ad Obama la parte di “nemico della Nazione nella coscienza dell’opinione pubblica israeliana.” Non ci voleva molto per convincerla: figlio di un padre keniota con un secondo nome musulmano e un cognome che fa rima con Osama, Obama era un personaggio sospettosamente terzomondista in un Paese in cui i pregiudizi razziali sono molto profondi, come possono testimoniare non solo arabi palestinesi, ma anche richiedenti asilo africani ed ebrei etiopi e marocchini. Non importa che Obama abbia dichiarato “indistruttibile” il legame dell’America con Israele: egli ha anche descritto le “quotidiane umiliazioni” dell’occupazione come “intollerabili”. Peggio ancora, nelle menti di Netanyahu e dei suoi sostenitori, ha insinuato che Israele è stato creato a causa dell’Olocausto, piuttosto che a causa dell’ancestrale rivendicazione degli ebrei sulla terra, andando a toccare le preoccupazioni sioniste sui definitivi diritti di proprietà.
Nella sua risposta al discorso di Obama, Netanyahu fece finta di riconoscere la necessità di uno Stato palestinese, ma la sua versione di un simile Stato corrispondeva a cantoni demilitarizzati e aggiunse una nuova precondizione: che prima che venisse raggiunto un qualsiasi accordo i palestinesi riconoscessero Israele come “Stato del popolo ebraico”. Israele non chiese mai all’Egitto o alla Giordania di concedere un tale riconoscimento, né Netanyahu fece lo stesso con la Siria quando cercò di aprire negoziati con Damasco durante il suo primo mandato come primo ministro. “Che bisogno abbiamo che i palestinesi, o chiunque altro, ci legittimino come Stato ebraico?” scrive (Ehud) Barak nelle sue memorie. “La tua retorica suggerisce che tu abbia una spina dorsale d’acciaio,” dice di aver detto a Netanyahu, “ma il tuo comportamento è una prova vivente del vecchio detto che sia più facile portare gli ebrei fuori dal galut” – la diaspora – “che portar fuori il galut dagli ebrei.” Secondo Barak, Netanyahu non sembrava tanto un primo ministro israeliano quanto un timoroso “rabbino di uno shtetl, o un oratore che cerca di raccogliere fondi per Israele all’estero.” Ma qui sta il punto: la nuova precondizione di Netanyahu era semplice hasbara. Sapeva che nessun dirigente palestinese – ancora meno un uomo vecchio, debole e screditato come Mahmoud Abbas – avrebbe potuto riconoscere Israele come Stato del popolo ebraico, dato che ciò sarebbe stato come approvare il sionismo, il progetto che aveva lasciato i palestinesi senza uno Stato. Ma questo rifiuto poteva essere bollato come ‘rifiuto di trattare’ e invocato come pretesto per continuare a prendere tempo, e lui sapeva che Obama non aveva intenzione di imporre nessuna reale sanzione. Nella sua ultima intervista prima di morire, all’età di 102 anni, Benzion Netanyahu chiarì che suo figlio non appoggiava la creazione di uno Stato palestinese. “Non c’è posto qui per gli arabi, e non ce ne sarà. Non ne accetteranno mai le condizioni.” Quando nel 2014 fu candidato alle elezioni per un secondo mandato, Netanyahu promise che non ci sarebbe mai stato uno Stato palestinese, dato che sarebbe diventato solo un trampolino di lancio per l’’Islam radicale’. L’argomento giocò un ruolo importante tra gli ebrei israeliani già spaventati dalle turbolenze nel mondo arabo. La guerra in Siria non fece altro che confermare che, in un futuro prevedibile, le Alture del Golan rimarranno in mani israeliane.
I palestinesi pagano un caro prezzo per resistere all’occupazione, sia con la violenza che con la non-violenza. L’esercito israeliano lo chiama ‘falciare il prato’. Pfeffer descrive Netanyahu come “il primo ministro con la più bassa percentuale di vittime nella storia di Israele,” ma sta contando solo i morti israeliani. Nel 2014 nella sola guerra di Gaza più di duemila palestinesi vennero uccisi, due terzi dei quali civili, mentre il numero di morti israeliani si limitò a 64 soldati e 6 civili. La risposta di Netanyahu fu accusare Hamas di usare “i morti palestinesi in modo telegenico per la propria causa”. La maggioranza degli israeliani condivide questa opinione. Nel 2016 a Hebron, durante l’’Intifada dei coltelli’ di breve durata, il sergente Elor Azaria venne filmato mentre giustiziava un ferito sospetto [di aver accoltellato un soldato, ndtr.] di nome Abdel Fattah al-Sharif. Era steso a terra da 10 minuti quando Azaria gli sparò. Azaria venne condannato dal ministro della Difesa di Netanyahu, Moshe Yaalon, ma quando la maggioranza degli israeliani sembrò sollevarsi in sua difesa, Netanyahu cambiò atteggiamento, facendo una telefonata di solidarietà alla famiglia dell’assassino. Dopo nove mesi in prigione, Azaria è stato liberato.
*
II progressisti israeliani sono soliti consolarsi con l’idea che all’interno della Linea Verde [cioè in territorio israeliano, ndtr.] le cose fossero diverse: passare dalla Cisgiordania a Israele era come entrare nelle ricche praterie di una vivace democrazia. Ciò è sempre stata una favola: la democrazia israeliana non è mai rimasta immune dall’occupazione, o dal governo militare autoritario imposto ai palestinesi dal 1948 al 1966, un anno prima che l’occupazione iniziasse. Eppure i progressisti israeliani potrebbero ragionevolmente invocare le libere elezioni e una stampa vivace come prova della vitalità democratica nel Paese, almeno per gli ebrei. Sotto Netanyahu non solo l’occupazione è diventata ancora più dura, ma il confine tra Israele ed i territori occupati ha continuato a sfumare. Ahmed Tibi, un deputato palestinese della Knesset, ha spesso evidenziato che Israele è una democrazia per gli ebrei ma uno Stato ebraico per gli arabi. Con l’approvazione della nuova ‘legge fondamentale’, che dichiara Israele ‘lo Stato-Nazione del popolo ebraico’, ciò ora è iscritto nella costituzione dello Stato. Israele è ufficialmente diventato quello che è sempre stato nella pratica: una democrazia herrenvolk [del popolo superiore], in cui solo gli ebrei hanno pieno diritto di cittadinanza e i non-ebrei sono al massimo una minoranza tollerata, in cui un immigrato da Miami o da Mosca può spadroneggiare su un cittadino palestinese nativo la cui famiglia ha vissuto ad Haifa o a Nazareth per secoli. L’arabo, in precedenza lingua ufficiale, è stato declassato a idioma con ‘status speciale’.
Quelli che all’interno di Israele si oppongono all’occupazione o alle discriminazioni contro gli arabi non sono più critici, sono nemici. Giornalisti progressisti, artisti e professori di sinistra, ricercatori per i diritti umani, elettori arabi ‘che vanno in massa a votare’: a sentire Netanyahu c’è da immaginare un complotto interno contro Israele. “Abbiamo due nemici principali, il ‘New York Times’ e ‘Haaretz’,” ha detto Netanyahu durante un incontro privato. “Essi definiscono l’agenda della campagna contro Israele in tutto il mondo.” Quando Sara Netanyahu venne accusata di truffa e di abuso d’ufficio nel settembre 2017, dopo essere stata incriminata per aver speso illegalmente fondi pubblici per cene preparate da chef famosi, il figlio della coppia, Yair, postò su Facebook un cartone neonazista su cui aveva sovrimpresso i volti di chi criticava i suoi genitori.
Con tutta la sua ossessione nei confronti dell’antisemitismo dei palestinesi, Netanyahu ha assunto un atteggiamento più indulgente verso l’antisemitismo dei suoi amici. Quando Victor Orbàn lanciò una campagna antisemita contro George Soros, provocando le ire dell’ambasciatore israeliano a Budapest, Netanyahu difese il suo alleato ungherese contro Soros, critico dell’occupazione [dei territori palestinesi]. Né l’antisemitismo dei sauditi né l’appoggio saudita agli jihadisti in Siria ha impedito il crescente amore-che-non-osa-dire-il-suo-nome tra Tel Aviv e Ryad. E poi c’è Donald Trump, la cui campagna per le presidenziali è stata appoggiata dal patrono di Netanyahu, Sheldon Adelson, e che si è circondato di un inquietante entourage di ebrei di destra e nazionalisti bianchi. Puntando su Trump nelle elezioni del 2016, Netanyahu ha sfidato quello che a lungo è stato il più importante sostegno di Israele all’estero: gli ebrei americani, molti dei quali detestano Trump e erano turbati dalle notizie sull’antisemitismo di Bannon. Ma Ron Dermer gli garantì che Bannon era un convinto sostenitore di Israele, e ciò per lui era sufficiente. (Come Netanyahu, Bannon è stato cresciuto dal padre nella convinzione che la Reconquista, la vittoria dei cristiani sui mori in Spagna, avesse salvato la civiltà, e prefigurato il ritorno a Sion). Trump ha onorato Netanyahu lodando il muro di Israele come un modello del muro che spera di costruire sul confine degli USA con il Messico, e Netanyahu ha risposto a tono su Twitter. Ora l’America è a tutti gli effetti schierata con i coloni. L’apertura dell’ambasciata USA a Gerusalemme è stata festeggiata mentre decine di palestinesi disarmati venivano uccisi a Gaza. E la strada verso una guerra ancora più sanguinosa è stata aperta dal ritiro di Trump dall’accordo con l’Iran.
“Siamo proprio come te,” ha detto Sara Netanyahu a Trump. “I media ci odiano ma il popolo ci ama.” Ha ragione per metà: suo marito rimane popolare tra gli ebrei israeliani. Ma il ‘popolo’ di Trump include pochissimi ebrei americani, e l’alleanza di Israele con lui ha accentuato la divisione tra gli ebrei americani e lo Stato ebraico. Molti ebrei americani, persino alcuni liberal, erano disposti a ignorare, o a giustificare, le violazioni dei diritti umani contro i palestinesi da parte di Israele. Ma non sono disposti ad approvare la guerra contro gli immigrati, il divieto di ingresso ai musulmani o l’erosione della democrazia americana. La convergenza tra il populismo autoritario di Trump e il sionismo colonialista di Netanyahu ha ulteriormente evidenziato le contraddizioni tra le loro convinzioni progressiste e l’Israele attuale. Il risultato è stato una sinistra ebrea americana con nuova linfa e sempre più radicale. Bernie Sanders si è espresso eloquentemente contro le uccisioni da parte di Israele a Gaza, risparmiando ai suoi ascoltatori i luoghi comuni sulla sicurezza di Israele, e il movimento per il boicottaggio, il disinvestimento e le sanzioni è guidato, in parte, da “Jewish Voices for Peace” [“Voci ebraiche per la pace”, organizzazione americana contro l’occupazione, ndtr.]. Alcuni democratici ebrei rimangono fedeli sostenitori di Israele, ma sono sempre più in difficoltà, e il sostegno ad Israele tra i giovani ebrei americani è in declino.
Netanyahu non se ne preoccupa. Come ha spiegato recentemente Dermer al “New York Times”, i cristiani evangelici, che sommano “un buon quarto della popolazione, e sono forse 10, 15, 20 volte la popolazione ebraica,” ora costituiscono il ‘nocciolo duro’ del sostegno USA ad Israele. Le loro idee nei confronti degli ebrei non sono affatto tenere. Il reverendo Robert Jeffress, che ha pronunciato la preghiera iniziale per l’apertura dell’ambasciata a Gerusalemme, dice che “non puoi essere salvato se sei un ebreo.” Il reverendo John C. Hagee, il tele-evangelico che ha dato la benedizione conclusiva, ha descritto l’Olocausto come il modo in cui dio ha fatto in modo che gli ebrei “tornassero alla terra di Israele.” Netanyahu si deve ancora pronunciare su questa teoria dell’Olocausto, ma ha espresso l’opinione che gli ebrei americani sono destinati ad essere assimilati e a scomparire come i conversos spagnoli che suo padre disprezzava. Appoggiato da Trump e dagli evangelici sionisti, l’Israele di Netanyahu non ha bisogno degli ebrei, per lo meno non di quelli politicamente inaffidabili della diaspora.
Dove tutto questo porterà rimane incerto. Netanyahu, per il momento, sembra molto attivo, incoraggiato dai suoi legami con Trump, dall’espansione del commercio con l’Asia e dalla complicità dei regimi arabo-sunniti. La posizione strategica di Israele non è mai stata così forte, o i suoi vicini così deboli. Ma le scene dei manifestanti disarmati uccisi dai cecchini israeliani a Gaza sono un richiamo allo scontento che giace sotto la superficie. Con Netanyahu, Israele ha accumulato un consistente conto di sangue e lacrime. Come la carta di credito di sua moglie, prima o poi dovrà pagarlo.
(traduzione di Amedeo Rossi)