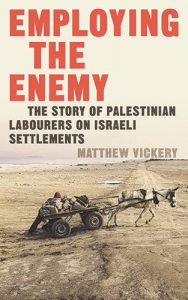‘Una scelta crudele’: perché Israele prende di mira le scuole palestinesi
Ramzy Baroud
23 ottobre 2018,Ma’an News
Il 15 ottobre diversi studenti palestinesi, insieme a insegnanti e dirigenti, sono stati feriti nell’attacco dell’esercito israeliano ad una scuola a sud di Nablus in Cisgiordania. Gli studenti della scuola mista al-Sawiya al-Lubban stavano sfidando un ordine militare israeliano di chiudere la loro scuola, sulla base dell’accusa onnipresente che la scuola fosse un “sito di terrorismo e rivolta popolare.”
“Terrorismo popolare” è un’espressione in codice dell’esercito israeliano che sta per proteste. Ovviamente gli studenti hanno tutto il diritto di protestare, non solo contro l’occupazione militare israeliana, ma anche contro l’aggressiva colonizzazione degli insediamenti di Alje e Ma’ale Levona. Questi due insediamenti ebrei illegali hanno illecitamente confiscato migliaia di dunum [unità di misura terriera in Medio Oriente: 10 dumun corrispondono a 1 ettaro, ndtr.] di terra appartenente ai villaggi di al-Sawiya e al-Lubban.
“I cittadini israeliani” che l’esercito di occupazione intende proteggere attraverso la chiusura della scuola sono, di fatto, proprio i coloni ebrei armati che hanno terrorizzato per anni questa regione della Cisgiordania.
Secondo uno studio del 2016 commissionato dalle Nazioni Unite, ogni giorno almeno 2.500 studenti palestinesi di 35 comunità della Cisgiordania devono attraversare i checkpoint militari israeliani per raggiungere le loro scuole. Circa la metà di questi studenti ha subito aggressioni e violenze da parte dell’esercito solo per aver cercato di arrivare a lezione o di tornare a casa.
Però questa è solo metà della storia, perché i violenti coloni ebrei sono sempre alla ricerca di bambini palestinesi. Anche questi coloni, che “creano anche loro checkpoint”, compiono regolarmente atti di violenza, “tirando pietre” contro i bambini (palestinesi) oppure “maltrattandoli fisicamente”.
ONU, “i gruppi di protezione dell’UNICEF hanno riferito che i propri volontari hanno subito attacchi fisici, aggressioni, arresti e detenzione e minacce di morte”.
In altri termini, addirittura i “protettori” stessi cadono spesso vittime delle tattiche terroristiche dell’esercito e dei coloni ebrei.
Aggiungete a questo il fatto che l’area C – la maggior parte della Cisgiordania, sotto pieno controllo militare israeliano – rappresenta l’apice della sofferenza palestinese. Qualcosa come 50.000 bambini affrontano moltissimi ostacoli, compresa la mancanza di servizi, aggressioni, violenza, chiusura e ingiustificati ordini di demolizione.
La scuola di al-Sawiya al-Lubban, situata in area C, è quindi alla totale mercé dell’esercito israeliano, che non tollera alcuna forma di resistenza, comprese le proteste non violente degli alunni della scuola.
Ciò che è davvero confortante però è che, nonostante l’occupazione militare israeliana e le continue restrizioni alla libertà dei palestinesi, la popolazione palestinese resta una delle più istruite in Medio Oriente.
Secondo il Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP), il tasso di alfabetizzazione in Palestina (stimato del 96,3%) è uno dei più alti in Medio Oriente ed il tasso di analfabetismo (3,7% tra le persone sopra i 15 anni), è uno dei più bassi al mondo.
Se queste statistiche non sono abbastanza incoraggianti, tenendo conto della costante guerra di Israele contro la scuola e i programmi scolastici, considerate questo: la Striscia di Gaza, assediata e devastata dalla guerra, ha un tasso di alfabetizzazione persino più alto della Cisgiordania, in quanto [queste zone] registrano rispettivamente il 96,6% e il 96%.
In realtà questo non dovrebbe stupire del tutto. I rifugiati palestinesi della prima ondata che subì la pulizia etnica dalla Palestina storica erano talmente desiderosi di assicurare che i loro figli fossero in condizioni di proseguire la loro educazione che già nel 1948 crearono delle tende adibite a scuola, gestite da insegnanti volontari.
I palestinesi sanno bene che l’educazione è l’arma più forte per ottenere la libertà a lungo negata. Anche Israele è consapevole di questa dicotomia, sapendo che una popolazione palestinese competente è in grado di sfidare il dominio israeliano molto più di una con scarsi mezzi culturali, di qui il fatto che Israele prenda di mira incessantemente e sistematicamente il sistema educativo palestinese.
La strategia israeliana nel distruggere l’infrastruttura del sistema scolastico palestinese si incentra sull’accusa di “terrorismo”: cioè, i palestinesi insegnano “terrorismo” nelle scuole; i libri scolastici palestinesi celebrano i “terroristi”; le scuole sono covi del “terrorismo popolare”, e varie altre accuse, che, nella logica israeliana, costringono l’esercito a chiudere scuole, distruggere servizi, arrestare gli studenti e sparargli.
Prendiamo ad esempio i recenti commenti fatti dal sindaco israeliano di Gerusalemme, Nir Barkat, che ora sta conducendo una campagna governativa con lo scopo di chiudere le attività dell’organizzazione dell’ONU che si occupa dei rifugiati palestinesi, l’UNRWA.
“È tempo di rimuovere l’UNRWA da Gerusalemme”, ha annunciato Barkat all’inizio di ottobre.
Senza alcuna prova, Barkat ha denunciato che “l’UNRWA sta rafforzando il terrorismo” e che “ai bambini di Gerusalemme viene insegnato, sotto la sua egida, il terrorismo, e ciò deve essere fermato.”
Ovviamente Barkat è disonesto. L’attacco all’UNRWA a Gerusalemme fa parte di una più vasta campagna israelo-americana finalizzata a chiudere un’organizzazione che si è dimostrata fondamentale per lo status e il benessere dei rifugiati palestinesi.
Secondo questo pensiero distorto, senza l’UNRWA I rifugiati palestinesi non avrebbero un riconoscimento giuridico, quindi chiudere l’UNRWA significa chiudere una volta per tutte il capitolo dei rifugiati palestinesi e del loro diritto al ritorno.
La chiusura della scuola al-Sawiya al-Lubban, l’attacco all’UNRWA da parte di Israele e Stati Uniti, i tanti checkpoint che separano gli studenti dalle loro scuole in Cisgiordania ed altro ancora, sono molto più in rapporto tra loro della falsa accusa israeliana di “terrorismo”.
La scrittrice israeliana Orly Noy ha sintetizzato la logica israeliana in una frase: “Distruggendo le scuole nei villaggi palestinesi dell’area C e altrove, Israele costringe i palestinesi a fare una scelta crudele – tra la loro terra e il futuro dei propri figli”, ha scritto all’inizio di quest’anno.
E’ questa logica brutale che ha guidato la strategia del governo israeliano riguardo all’educazione dei palestinesi per 70 anni. È una guerra di cui non si può discutere o che non può essere compresa al di fuori della più complessiva guerra all’identità e alla libertà dei palestinesi e, di fatto, alla stessa esistenza del popolo palestinese.
La lotta degli studenti per il proprio diritto all’educazione alla scuola mista al-Sawiya al-Lubban non è assolutamente una scaramuccia isolata che riguarda alunni palestinesi e soldati israeliani dal grilletto facile. È invece al centro della lotta del popolo palestinese per la sua libertà.
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riflettono necessariamente la politica editoriale dell’Agenzia Ma’an News.
Ramzy Baroud è giornalista, scrittore e redattore di Palestine Chronicle. Il suo ultimo libro è “The last earth: a palestinian story” [L’ultima terra: una storia palestinese].
(Traduzione di Cristiana Cavagna)