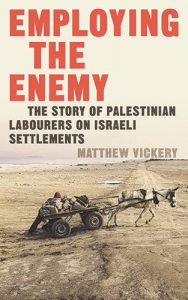Essam Yousef
10 agosto 2018, Middle East Monitor
Dalla sua nascita nel 1949 la United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East [Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente] (UNRWA) è stata sul punto di andare in pezzi ad ogni momento a causa del suo legame con fattori politici, giuridici e umanitari relativi alla causa palestinese. La situazione politica ha spianato la strada affinché giocasse il ruolo di “carta di pressione politica”, non da ultimo perché riguarda direttamente le vite dei rifugiati del problema più complicato nella storia contemporanea.
L’agenzia è stata fondata in base alla risoluzione 302 dell’Assemblea Generale dell’ONU, connessa alla risoluzione 194 approvata un anno prima, relativa al diritto al ritorno dei profughi palestinesi alla loro terra. Quest’ultima risoluzione ha aggiunto una dimensione politica alla decisione di fondare l’UNRWA, soprattutto nei termini di un contributo positivo al ritorno dei rifugiati alle loro case, da cui erano stati espulsi con la forza – qualcuno l’ha chiamata una “pulizia etnica” – dalla creazione dello Stato di Israele.
Tra le raccomandazioni dell’Assemblea Generale dell’ONU c’era l’incarico all’UNRWA di dare assistenza ai rifugiati finché si fosse trovata una soluzione permanente alla loro causa. Questo appoggio includeva programmi di aiuto per educazione e salute, opportunità di lavoro, programmi di assistenza e servizi sociali.
Riguardo alle questioni politiche e giuridiche, l’Assemblea Generale ha affrontato periodicamente il problema dei rifugiati palestinesi come punto all’ordine del giorno. Inoltre ha frequentemente ripetuto e riconosciuto “l’inalienabile diritto dei rifugiati a tornare alle proprie case e al risarcimento per le proprietà perse a causa dell’occupazione e dell’espulsione.” Tuttavia la mancanza di ogni volontà internazionale di obbligare lo Stato israeliano occupante a mettere in pratica le condizioni delle risoluzioni dell’ONU ha fatto sì che sia tuttora un problema in sospeso in attesa di essere risolto, nonostante il fatto che la stessa adesione di Israele all’ONU fosse e rimanga condizionata al fatto di consentire ai rifugiati il ritorno alle proprie case.
Le condizioni in base alle quali l’agenzia è stata creata e i suoi limiti – dovuti al fatto che il suo finanziamento è quasi totalmente dipendente dalle donazioni volontarie da parte degli Stati membri dell’ONU, per la maggior parte dagli USA e dall’Europa, seguiti dai Paesi del Golfo come l’Arabia saudita – rendono più facile capire l’attuale riduzione dei servizi dell’UNRWA per i rifugiati. Le donazioni possono essere – e pare siano – negate per ragioni politiche, il che rende la vita ancora più difficile a milioni di rifugiati palestinesi che dipendono dall’UNRWA in Cisgiordania e nella Striscia Gaza occupate, in Giordania, in Siria e in Libano.
L’ONU non solo delibera e poi emana risoluzioni, ma controlla anche i meccanismi necessari per la loro messa in pratica tranne, a quanto pare, quando queste decisioni sono a favore del popolo palestinese e dei suoi legittimi diritti, compreso quello al ritorno. Ciò non a causa dell’egemonia militare di Israele in Medio Oriente. È molto più importante il fatto che il suo principale benefattore e protettore, gli USA, sia anche il principale Stato che muove i fili all’ONU, dove esercita un grado di influenza sproporzionato. L’America e i suoi alleati sono i veri garanti nel mantenere l’esistenza, l’espansione coloniale e la sicurezza di Israele.
Perché, allora, l’ONU ha creato l’UNRWA e continua così da decenni, se non ha mai avuto nessuna concreta intenzione o capacità di far tornare i rifugiati palestinesi alla loro terra, e quindi di porre fine alla necessità fondamentale dell’esistenza dell’agenzia? Credo che i Paesi occidentali, il cui senso di colpa dopo l’Olocausto porta a far finta di niente riguardo al disprezzo di Israele per leggi e convenzioni internazionali, temano anche lo scandalo che li sommergerebbe se i rifugiati palestinesi fossero lasciati a cavarsela da soli nei Paesi che li ospitano, per i quali rappresentano già un grave peso. Questo peso si accrescerebbe in modo notevolissimo se non ci fosse l’UNRWA a fornire una rete di protezione economica, medica ed educativa. In parte questo spiega anche perché l’Occidente ha creato e finanzia l’Autorità Nazionale Palestinese – che non ha assolutamente nessuna reale autorità – come entità pseudo-nazionale che agisce a favore delle autorità occupanti e non degli stessi palestinesi.
A ciò vanno aggiunti i tentativi degli Stati che controllano l’ONU di rinviare ogni serio tentativo di risolvere il problema dei rifugiati, concedendo a Israele altro tempo per creare “fatti sul terreno” – colonie illegali su terra palestinese rubata – e quindi predeterminare l’eventuale risultato del farsesco “processo di pace”. Come diretta conseguenza di ciò, le priorità sono passate dal consentire ai rifugiati di tornare alle loro case, come loro diritto, alla ricerca di modi per integrarli nei rispettivi Paesi che li ospitano. Sono anche state ventilate delle compensazioni per la perdita del diritto al ritorno. La mancanza di potere degli arabi nella regione ha consentito alle superpotenze di controllare l’UNRWA e la sua impostazione, perché queste ultime sono importanti Paesi donatori dell’agenzia e nessun programma di aiuto umanitario per i rifugiati può essere attuato senza il loro sostegno economico. L’aiuto degli arabi e dei musulmani all’UNRWA è estremamente ridotto rispetto a quello di USA ed Europa.
Ovviamente l’UNRWA è stata creata dopo la “dichiarazione d’indipendenza” dello Stato di Israele. La risoluzione che l’ha istituita era stata ideata per rafforzare la nuova situazione e include articoli che si riferiscono a “prendere misure efficaci il prima possibile per porre fine all’aiuto internazionale”. Ciò è risultato evidente dalle politiche che ha adottato, compreso il fatto di destinare la maggior parte del bilancio all’integrazione dei rifugiati in comunità diasporiche piuttosto che a fornire loro assistenza.
Tuttavia il tracollo dei servizi dell’UNRWA, iniziato anni fa, si è di recente accentuato, dato che il principale Stato donatore, gli USA, ha tagliato i propri finanziamenti all’agenzia. Nel 2017 gli USA donavano 157 milioni di dollari al bilancio del principale programma dell’UNRWA, ma quest’anno li hanno ridotti a soli 60 milioni. Ciò ha avuto un effetto disastroso sulla crisi umanitaria che i rifugiati devono affrontare nei territori palestinesi e nei campi della diaspora.
Il disastro umanitario ha iniziato a manifestarsi già quando l’UNRWA ha annunciato di non essere in grado di accettare studenti nelle sue scuole per l’anno scolastico 2018/19 a causa della mancanza di fondi sufficienti. Ciò è stato preceduto dalla sospensione del Programma Alimentare Mondiale di aiuto alimentare a 92.000 palestinesi in condizione di povertà estrema nella Striscia di Gaza; di nuovo, questo è dovuto alla mancanza di finanziamenti sufficienti da parte della comunità internazionale.
Una delle conseguenze della difficile situazione finanziaria dell’UNRWA è stato il licenziamento all’inizio di quest’anno di decine di dipendenti che lavoravano per l’agenzia in Giordania. Gran parte del bilancio dell’UNRWA è destinato ai salari, e molti dei suoi dipendenti sono loro stessi rifugiati, per cui le loro entrate sono una parte fondamentale dell’economia dei rifugiati. La riduzione del personale in Giordania ha colpito gli addetti alle pulizie ed i custodi di scuole e centri di salute gestiti dall’UNRWA in ogni campo di rifugiati palestinesi – sono 10 – nel Regno hascemita, che è la patria “temporanea” di 2 milioni di rifugiati palestinesi registrati.
Recentemente l’agenzia ha licenziato anche 1.000 dipendenti nella Striscia di Gaza. Secondo gli stessi dati dell’UNRWA, essa si appresterebbe a licenziare altro personale se la crisi finanziaria dovesse continuare, oltre al taglio di programmi regolari come i campi estivi ed altre attività per i bambini.
Fin dall’elezione di Donald Trump a presidente, Washington ha adottato un atteggiamento estremamente ostile verso l’UNRWA. La natura dei cambiamenti riguardanti l’agenzia riflette le politiche dell’amministrazione Trump in merito ai rifugiati palestinesi e al complessivo conflitto arabo-israeliano in Medio Oriente. In generale, la nuova posizione degli USA è persino più allineata con la posizione e gli interessi di Israele di prima, mentre quest’ultimo vorrebbe che l’UNRWA venisse chiusa per cancellare del tutto i rifugiati palestinesi dall’agenda politica internazionale.
Recentemente la posizione dell’America è stata espressa esplicitamente nell’entusiasmo dell’amministrazione Trump verso Israele e il suo espansionismo colonialista a spese del popolo della Palestina e della sua causa. La questione dei rifugiati è stata tenuta ben lontana da quelli che sono stati presentati come “negoziati”, ma che in realtà sono semplicemente il fatto che ai palestinesi viene detto cosa fare, o altrimenti… In ogni caso, “o altrimenti” è in genere il risultato finale. Siamo ora nella fase in cui gli USA dicono che l’UNRWA è “dannosa per i rifugiati palestinesi e che il suo mandato è controproducente.” Davvero sorprendente.
È ingenuo fraintendere la natura della situazione che devono affrontare 5.3 milioni di rifugiati palestinesi sparsi tra Cisgiordania, Striscia di Gaza, Giordania, Siria e Libano. Hanno crescenti necessità relative alla salute, all’educazione e ad altri servizi mentre sappiamo tutti benissimo il livello dei problemi economici e di sicurezza dei Paesi ospitanti.
È difficile immaginare come centinaia di migliaia di famiglie private della rete di protezione dell’UNRWA potranno sopravvivere. Quale destino attende le decine di migliaia di dipendenti dell’UNRWA che si troveranno senza lavoro e senza fonti di reddito?
Non ho dubbi che le conseguenze politiche e di instabilità di una simile impennata di miseria e disillusione nel processo di pace siano state prese in considerazione nelle capitali regionali e in Occidente. Il Medio Oriente è già nel caos, ma può andare ancora peggio, a meno che non si faccia qualcosa per arginare i tagli ai finanziamenti dell’UNRWA. Lo spettro di un incremento dell’estremismo e del terrorismo è molto concreto, e la causa non saranno la religione o la radicalizzazione, ma la scarsa disponibilità dell’Occidente – guidato dall’America – a finanziare in modo adeguato l’UNRWA e a fare sforzi sinceri per risolvere il problema palestinese in base alla volontà espressa dalla comunità internazionale attraverso le risoluzioni dell’ONU.
I funzionari dell’UNRWA sono ben consapevoli del cupo panorama che gli si sta profilando ed hanno lanciato appelli e campagne per ridurre il deficit di bilancio dell’agenzia. Sanno più di chiunque altro – con la possibile eccezione degli stessi rifugiati – quanto sia importante che l’UNRWA sia in grado di rispettare i suoi obblighi umanitari, morali e giuridici per milioni di palestinesi. I Paesi arabi e islamici devono dimostrarsi all’altezza della situazione e prendere le misure necessarie per evitare un disastro, destinando all’UNRWA donazioni che siano al livello delle dimensioni, della complessità e della natura della crisi dei rifugiati.
Le organizzazioni umanitarie e di beneficienza nel mondo arabo e islamico possono anche giocare un ruolo chiave intervenendo nei settori in cui l’UNRWA non è in grado di portare aiuto. Possono contribuire a rafforzare la rete di sicurezza sociale nei campi profughi, soprattutto in più di 700 scuole dell’UNRWA responsabili di mezzo milione di alunni palestinesi. Anche i circa 150 importanti centri di salute possono essere sostenuti dal volontariato, così come progetti di aiuto, sistemi di micro-credito per promuovere l’economia e aiuto umanitario. Tuttavia per fare concretamente ciò i governi devono smettere di politicizzare l’aiuto umanitario ed alleggerire la pressione sugli enti di beneficienza, soprattutto quelli che operano in aree ad alto rischio, come i territori palestinesi occupati.
In pratica è necessario preparare alternative a lungo termine per la situazione di crisi economica e politica dell’UNRWA. Il progetto di una “Organizzazione Araba e Islamica”, per esempio, potrebbe essere responsabile delle questioni politiche ed amministrative dei rifugiati palestinesi, compresa l’erogazione di aiuto finanziario in ogni settore, come educazioni e salute, così come di supporto umanitario, evitando quindi che Paesi donatori controllino e politicizzino l’aiuto che forniscono ai palestinesi e ai Paesi che ospitano rifugiati.
Peraltro non dobbiamo ignorare il sostegno politico necessario a proteggere i punti fermi palestinesi, soprattutto il diritto al ritorno dei rifugiati. Dobbiamo essere in grado di sfidare gli schemi che intendono annientare la causa palestinese. Sarà una priorità di una simile “Organizzazione Araba e Islamica” essere basata sulla religione, con una fede ferma e duratura nei diritti del popolo palestinese, come il diritto al ritorno dei rifugiati ed al risarcimento, oltre ad appoggiare il loro diritto a costruire uno Stato indipendente con Gerusalemme come capitale.
Se c’è la volontà politica ciò non è irragionevole, perché il sostegno popolare sta solo aspettando che si prenda una simile iniziativa. L’UNRWA e il popolo della Palestina hanno dovuto dipendere per troppo tempo da Stati che hanno trasformato la crisi umanitaria in un rimpallo di responsabilità politica; è tempo che ciò finisca. Gli USA e i loro alleati devono smettere di giocare con la vita della gente in questo modo pernicioso; anche le vite dei palestinesi sono importanti [riferimento al movimento per i diritti degli afroamericani “Black lives matter”, ndtr.].
Le opinioni espresse in questo articolo sono dell’autore e non riflettono necessariamente la politica editoriale di Middle East Monitor.
(traduzione di Amedeo Rossi)